Dylan ha ottant’anni e mi ha stremato. Libri, articoli, interviste, presentazioni online. Tutto molto eccitante, per carità, ma mi viene in mente quello che una volta ho sentito dire a Michael Gray, uno studioso di Dylan che prima di una conferenza aveva informato il pubblico di avere anche una vita oltre a Dylan (“And yes, I do have a life”). È bene saperlo, perché Dylan, che i suoi colleghi del Greenwich Village chiamavano “la spugna” perché assorbiva tutto, adesso assorbe chiunque si occupi di lui. E se vuoi avere una vita oltre a Dylan, buona fortuna.
Per me, il suo compleanno è cominciato con la co-edizione di Bob Dylan and the Arts, il volume uscito nel gennaio 2021 per le Edizioni di Storia e Letteratura che raccoglie gli atti del primo convegno universitario su Dylan in Italia, organizzato nell’autunno del 2018 all’Università Roma 3 da Maria Anita Stefanelli e Fabio Fantuzzi. Forse è stato il primo convegno ad aver esplorato nei dettagli la connessione tra il Dylan autore di canzoni e le altre arti in cui Dylan ha voluto cimentarsi: il cinema, la pittura, la scultura (con risultati a volte discreti, a volte dilettanteschi). Soprattutto, è stata l’occasione per raccogliere tutte le informazioni disponibili, non molte a dire la verità, su uno dei pochi “maestri” che Dylan ha avuto. No, non B.J. (Boniface Joseph) Rolfzen (1923-2009), suo professore d’inglese al liceo di Hibbing, l’unica persona al mondo che l’ha sempre chiamato “Robert”. Non Woody Guthrie, dal quale ha imparato ascoltando i suoi dischi e stando al suo capezzale.
Non Lonnie Johnson, che al Village gli aveva insegnato come accompagnarsi alla chitarra non per accordi ma per figure di tre note (una tecnica che però Dylan ha usato tardi, in un paio d’anni del Never Ending Tour tra i novanta e i duemila, e neanche tanto bene), bensì Norman Raeben (1901-1978), l’unico dal quale è veramente andato a scuola, tra il maggio e il luglio del 1974, poco prima di comporre le canzoni di Blood on the Tracks. Raeben era un pittore che con le sue lezioni di arte, letteratura e vita vissuta ha insegnato a Dylan a collegare l’occhio dell’immaginazione con la mano che dipinge e che scrive. (Nato Numa Rabinowitz in Ucraina, Raeben era il figlio minore di Sholom Aleichem, uno dei padri della letteratura yiddish – il musical Il violinista sul tetto è ispirato ai suoi racconti. Nonostante la sua vita non manchi d’interesse, di lui si sapeva poco. Ora, grazie alle ricerche di Fantuzzi e a questo libro, ne sappiamo di più.)
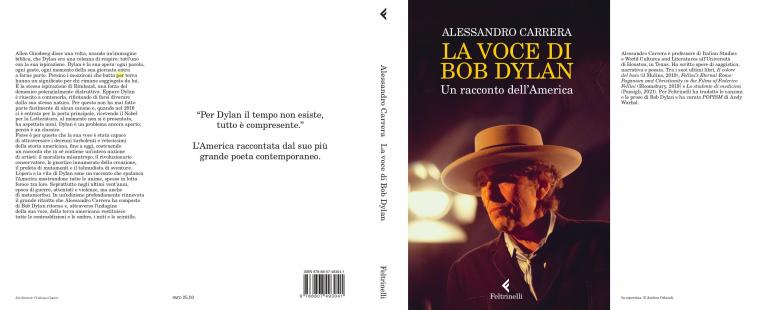
Subito dopo è venuto Bob Dylan & Like a Rolling Stone di Mario Gerolamo Mossa, pubblicato da Mimesis e per il quale ho scritto l’introduzione. Mossa, che è dottorando all’Università di Pisa (anche lui compare in Bob Dylan and the Arts), non solo ha scritto il libro più dettagliato ed esauriente che esista al mondo sulla canzone che ha cambiato il corso della popular music, ma è anche una figura nuova di studioso: il filologo della canzone, e non solo del testo, ma anche della musica e della storia delle sue esecuzioni dal vivo. Anche in questo caso i Dylan Studies italiani sono arrivati in anticipo rispetto a quelli anglosassoni.
Con il mio contributo a questi due libri pensavo di aver pagato il mio debito agli ottant’anni di Dylan. Magari mi avrebbero chiesto un paio di articoli di circostanza, ma nessun altro si faceva avanti. Meglio così, perché anch’io ho una vita oltre a Dylan. Vero, ogni mattina apro www.expectingrain.com e scorro rapidamente quello che è uscito in internet su di lui, ma poi passo ad altro, altrimenti ricadrei nella categoria di coloro che Dylan stesso ha definito come gente che ha un pessimo rapporto con la propria autostima. Ma la tranquillità è durata poco. Adesso è il 24 maggio, data del Piave e del compleanno di Dylan, e io sono esaurito.
Vero, aggiungerò al mio curriculum vitae la terza edizione di La voce di Bob Dylan (520 pagine con capitoli nuovi sul Nobel, The Lonesome Death of Hattie Carroll e gli ultimi album), l’edizione economica delle Lyrics in tre volumi, aggiornata con i testi annotati del recente Rough and Rowdy Ways (tutto per Feltrinelli) nonché articoli, interviste, lezioni e partecipazioni a convegni online, ma come faccio a star dietro continuamente a Dylan e alla Babele di discorsi che ha generato? Dà da fare a chi lo segue anche quando non fa niente, figurarsi quando muove un dito. Anche sui suoi colleghi ci sarebbe molto da dire, anche su Leonard Cohen, Joni Mitchell, Lou Reed, Tom Waits, Joan Baez, David Bowie, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Sam Cooke, Marvin Gaye, Nina Simone, Neil Young, Bruce Springsteen, James Brown, Lennon & McCartney, Jagger & Richard ecc., ma la letteratura su Dylan è un genere a parte, e si può capire. Dal 1963 in poi, non c’è stata una sola persona nell’emisfero occidentale che non abbia sentito parlare di Bob Dylan (no, mi correggo, tra gli anni settanta e ottanta ho incontrato un tale che non l’aveva mai sentito nominare; organizzava concerti per conto dell’ARCI Toscana).
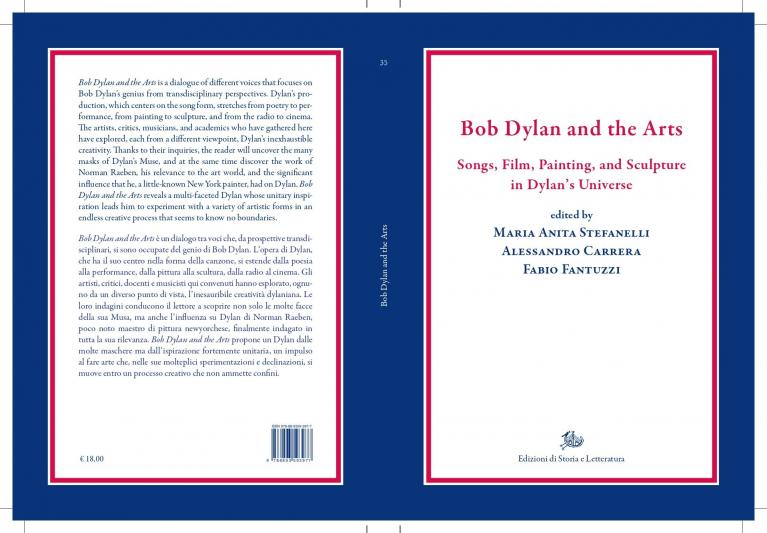
Insomma, l’argomento è infinito, ma io in questo momento non so più cosa dire; ho sparato tutte le cartucce che avevo e, in attesa di ricaricare, ripetermi non mi piace. Però quando non si riesce più a teorizzare si può sempre raccontare. La letteratura rock è sempre stata confessionale, oltre che devozionale. I “critici rock” hanno sempre parlato molto di sé, o hanno usato i loro idoli per creare allegorie di se stessi. Era inevitabile: vivevano anche la semplice occasione dell’ascolto come una filosofia di vita, da cui le innumerevoli madeleine: dov’ero, con chi ero e che cosa facevo quando per la prima volta ho sentito…?
Ma io non vengo da lì (ecco che sono scivolato nel modo confessionale). Ero un ragazzino molto studioso e molto snob, che ascoltava solo musica classica e se non ci fossero state condizioni che lo impedivano avrebbe studiato al Conservatorio con l’ambizione, probabilmente malriposta, di diventare direttore d’orchestra. Però oltre a Bruckner e Mahler c’erano quelle voci… Quelle voci che classiche non erano, o meglio venivano da un’altra classicità, quella dei bardi antichi di cui ci è arrivata solo un’imperfetta trascrizione. Dylan dice nel suo discorso del Nobel che ebbe il primo shock ascoltando Lead Belly cantare Cotton Fields (“Quel disco, in quel preciso momento, cambiò la mia vita”).
È successo anche a me, con Lead Belly che cantava Rock Island Line. L’ho sentita in un disco pubblicato dai Fratelli Fabbri Editori, ultima puntata di La Musica Moderna, splendida enciclopedia a fascicoli dedicata al repertorio classico, ogni volume della quale terminava con una panoramica della popular music (che allora non si chiamava ancora così) di un certo decennio. Quel fascicolo dedicato al folk italiano, europeo e americano era incredibilmente ben scelto, e se non ricordo male iniziava appunto con Rock Island Line. Da dove veniva quel ringhio da personaggio dell’Inferno dantesco, e che pure emanava una determinazione inamovibile, a suo modo serena, non nella voce ma intorno alla voce, sopra e sotto la voce, nel soffio inudibile che faceva esistere quella voce? Non c’era Dylan in quel disco, ma io ormai non potevo più fare a meno di quelle voci. I miei compagni di scuola si passavano dischi di folksingers e cantautori americani che io fino a quel momento avevo ignorato. Me li feci prestare, e su Washington County, un disco di Arlo Guthrie, trovai Percy’s Song, una ballata lunghissima, ipnotica, il cui senso mi era incomprensibile e di cui riuscivo a capire solo le ricorrenti parole: “Turn, turn to the rain and the wind”. Non era di Arlo Guthrie bensì di tale “B. Dylan”.
Ben presto, confrontando dischi di Joan Baez e Pete Seeger, mi accorsi che le canzoni che preferivo erano sempre firmate da questo “B. Dylan”. Decisi allora di procurarmi qualcosa di suo, e il risultato è una storia che ho già raccontato altrove. Era il 1970, e il primo disco di Dylan che ho comprato era quella strana cosa di nome Self Portrait che non mi dispiaceva ma si accordava poco con l’idea che mi ero fatta di lui. Solo quando ho sentito per la prima volta Mr. Tambourine Man ho capito la vastità del mondo che mi si parava davanti. Pur senza capire le parole, mi bastava lo “Hey!” iniziale, che non era rivolto solo a Mr. Tambourine ma anche a te che stavi ascoltando: “Ehi! Sto parlando a te, quello che sto dicendo riguarda te!”.
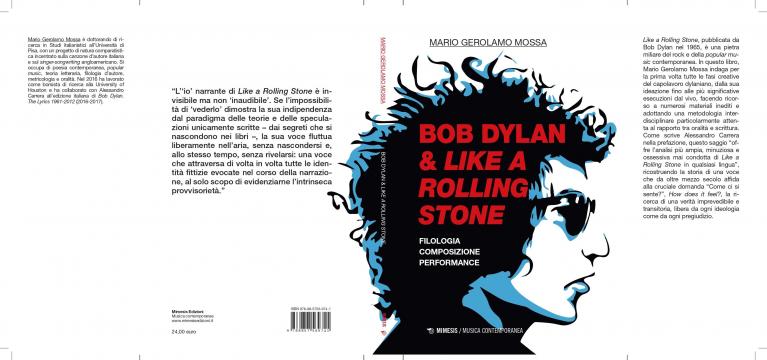
“Quel disco, in quel preciso momento, cambiò la mia vita”. Decisi che di Dylan volevo sapere tutto, ma come si faceva? I dischi si potevano trovare (non in tutti i negozi, peraltro), ma i testi no; bisognava cercare le edizioni musicali, con le riduzioni per pianoforte e gli accordi per chitarra segnati sopra il pentagramma, ed erano piuttosto rare. Bisognava anche capire, e l’inglese insegnato a scuola non bastava, ti faceva fare strafalcioni. E poi chi, a parte pochi americanisti e politologi, sapeva veramente cosa stava succedendo negli Stati Uniti all’epoca dei diritti civili e del Vietnam, senza avere una visione assolutamente di parte, a destra come a sinistra?
Dylan era una passione privata e destinata a rimanere tale. Durante il mio primo viaggio negli Stati Uniti, nel 1979, avevo raccolto materiale prezioso che non ero ancora in grado di capire. Nel mio Musica e pubblico giovanile, prima edizione 1980, di Dylan parlo pochissimo. Un articolo scritto in quello stesso anno per “Cineforum” mi imbarazza ancora per gli errori di traduzione e la superficialità di certi giudizi. Dovevo mettere da parte ogni pretesa di scrivere su di lui e studiare, studiare moltissimo lui e la sua America. Solo quando ho avuto la possibilità di vivere a New York, dal 1995 al 2001, il mio archivio dylaniano ha preso veramente consistenza. Non rimpiango i soldi spesi per mettere insieme una rispettabile collezione di bootleg, anche se ora buona parte degli inediti che per anni ho ossessivamente cercato e catalogato è disponibile nei volumi della Bootleg Series. Rimpiango piuttosto le sortite del sabato mattina nei negozi di dischi del Greenwich Village, ormai quasi tutti chiusi per far posto a rivenditori di magliette, cappellini da baseball e Statue della Libertà fosforescenti (ma si guadagna così tanto, a vendere magliette? Tanto da far chiudere tutte le librerie e i negozi di dischi? E perché allora in quei negozi non vedo mai nessuno?).
Se nel 1997 Dylan non avesse pubblicato Time Out of Mind, sarei stato uno dei tanti a cui piaceva Dylan, ecco tutto, senza che fosse il caso di farci rumore intorno. Ma Time Out of Mind era un disco di cui non solo valeva la pena di parlare, ma anzi era necessario parlare. E dopo vent’anni di studio – non matto e disperatissimo, ma intenso e privatissimo – ormai mi sentivo in grado di affrontare il compito. Ho scritto un articolo per la rivista “Poesia”, con la quale allora collaboravo spesso (e ringrazio ancora Nicola Crocetti per avermi incoraggiato), e il resto lo si può leggere in quello che su Dylan ho scritto da allora. Nel ’97 non eravamo in pochi, a scrivere su Dylan, ma adesso siamo legione. Anzi, mi stupisco che non ci sia ancora stato un contraccolpo, qualche anima bella che si alza e accusa Dylan di tutto quello di cui si può essere accusati al giorno d’oggi. A dire il vero qualche imputazione di sessismo e di scorrettezza politica c’è stata, ma niente che abbia preso piede (curiosamente, sono più gli uomini ad accusarlo di sessismo che non le donne; la coda di paglia dell’uomo anglosassone è piuttosto lunga, e prende fuoco subito; Just Like a Woman sarà anche una canzone sessista, ma ascoltatela da Nina Simone, in particolare l’ultima versione dal vivo, e poi ditemi cosa ne pensate).
Non credo che un backlash accadrà finché Dylan è vivo, perché, ammettiamolo, Dylan fa paura. Nessuno vuole vedere lo sguardo di ghiaccio che ti posa addosso se dici qualcosa che non gli aggrada. E in un’intervista del 2012, alla domanda su che cosa aveva da dire a chi lo accusava di avere occasionalmente plagiato da questo e da quello, la sua risposta è stata: “Che vadano a marcire all’inferno!”. La sua reputazione come difensore dei diritti civili è ancora alta. Ma quanti sanno che Dylan ha anche contribuito di recente a un disco di canzoni per matrimoni gay con una cover della classica She’s Funny That Way, cambiandole il titolo in He’s Funny That Way?
Per ora, il muro che i dylanisti/dylanologi/dylaniati/dylanoidi gli hanno alzato intorno è molto più solido di quello che Trump voleva costruire tra gli USA e il Messico. Spero che duri, perché non vorrei ritrovarmi in compagnia di coloro che in anni non sospetti hanno pensato che valesse la pena di occuparsi di Woody Allen e di Philip Roth. Ma vorrei concludere con un ultimo ricordo. Non è stata Percy’s Song la prima canzone di Dylan ad avermi colpito. Qualche anno fa, rovistando nella mia cantina di Milano, ho ritrovato una scatola da scarpe piena di vecchi 45 giri che qualcuno aveva regalato ai miei genitori. Tra quei 45 giri c’era Ecoute dans le vent, la versione francese di Blowin’ in the Wind cantata da Richard Anthony (Ricardo Anthony Btesh, 1938-2015, il cantante franco-egiziano famoso negli anni sessanta anche per Et j’entends siffler le train – o meglio 500 Miles – poi ripresa anche da Battiato). Altro che madeleine; la mia infanzia mi è venuta addosso come un treno merci. Quante volte l’avevo ascoltata da bambino, affascinato da quella semplicissima melodia, e prima ancora di scoprire la musica classica? Mi ricordavo perfino i primi versi, “Combien de routes un garçon peut-il faire / avant qu’un homme il ne soit?”, e senza aver mai studiato il francese. Il destino non è qualcosa che intravediamo nelle nebbie del futuro. Ci aspetta tranquillo, là nel passato. On revient, on revient toujours…

