Memè Scianca e Bobi sono gli ultimi due libri di Roberto Calasso, usciti ora nella Piccola Biblioteca Adelphi. È significativo che il grande editore e scrittore appena scomparso abbia sentito l’esigenza di comporre un dittico come questo: un’autobiografia e un concomitante ricordo di Bobi Bazlen, quasi che lui e il cofondatore della casa editrice fossero, in qualche modo, una cosa sola, e l’uno non potesse ricordare il proprio passato senza implicare e coinvolgere l’altro.
Precisiamo subito che Memè Scianca è il nome che Calasso, non sa nemmeno lui quando, ma molto presto scelse per se stesso. Un nome singolare che non rievocava né eroi né cavalieri, piuttosto malavitosi. “Scianca” potrebbe alludere più che altro a una infermità. “Memè” è tronco e buffo come “Totò”, ma è anche uno dei soprannomi del barone di Charlus, nella Recherche. Calasso la lesse a tredici anni, su suggestione del suo caro amico veneziano Enzo Turolla (che fu poi professore di storia della critica all’Università di Padova).
Autobiografia abbiamo detto, ma non lineare, non è un itinerario tracciato su una mappa. La memoria è fatta di buchi, crivellata da crateri vulcanici. Calasso si è fatto qui scriba di se stesso. Sa che ogni frammento di vita che affiora alla mente affiora un’ultima volta, “prima di essere abbandonato alla totale inesistenza”.
È chiaro che un così precoce lettore proustiano non può che abbandonarsi al fascino dei nomi. Berlindo e Vergiana per esempio, i fattori della casa di campagna in cui il bambino Roberto era sfollato da Firenze. Un bambino che, in caso d’interrogatorio, avrebbe dovuto declinare false generalità, e dire di chiamarsi Facchini, cognome dell’adorata tata.
La nonna Maria viceversa era chiamata Mollo dal padre di Roberto, il celebre professore di storia del diritto Francesco. Per ragioni mai chiarite peraltro. Per la passione proustiana invece lui stesso, sempre dal padre, era stato ribattezzato “Prousto”. Il nonno Ernesto (Codignola) aveva scelto a sua volta nomi assai caratteristici per i due figli, ossia Tristano e Melisenda, caso singolarissimo di “discendenza musicale” (in omaggio a Debussy e Wagner evidentemente).
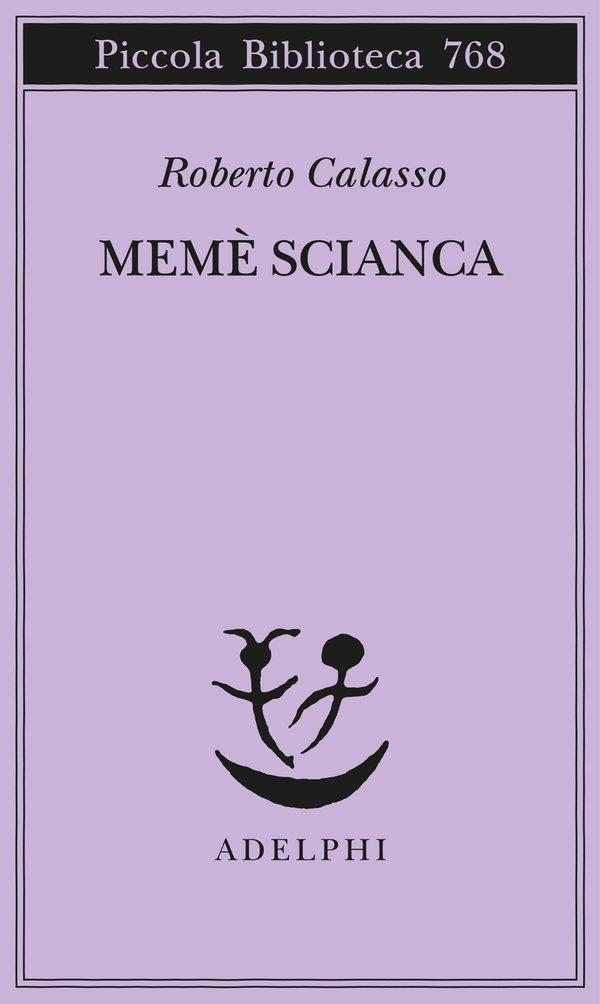
È chiaro che un ragazzo che cresce in un ambiente culturalmente così vivace (in casa Calasso passano via via Giorgio Pasquali, Giorgio La Pira, i Pasternak, perfino una certa Frau Bloch, che altri non è che la Grete Bloch, intermediaria fra Felice Bauer e Kafka nonché madre di un figlio avuto da quest’ultimo e prematuramente morto) finisce ben presto per amare i libri: “leggere fu ciò che insensibilmente prese il posto dei giochi”. E, anche: “il gioco – qualsiasi gioco – induce a una concentrazione estrema, ad annullare tutto ciò che non ne è parte. È una forte droga autoprodotta, la prima fra tante”. Una droga come quella dei libri, in cui il giovane Roberto s’immerse “con la stessa intensità che si sperimenta nel gioco”. Da Cime tempestose apprende la prima volta cos’è la passione. Anche l’eros arriva la prima volta per il tramite dei libri: sono le incisioni di Gustave Doré per un’edizione illustrata dell’Orlando furioso. Angelica vi è raffigurata “nuda e sinuosa” aderire alla roccia, mentre tutt’intorno Ruggero trafigge uno dei mostri con la sua lancia. Abbastanza “per orientare una vita erotica”.
Poi è la volta dei libri del Gabinetto Vieusseux, gialli, Simenon e i classici americani. Ma anche i romans durs di Simenon. Nonché gli scaffali e i tavoli della libreria Seeber di via Tornabuoni.
Ma benché Calasso fosse stato in realtà attratto dai libri “prima ancora che sapesse leggere”, una volta, misteriosamente, fu preso da un sentimento di tale ostilità verso i volumi che trafisse con un coltello o tagliacarte i dorsi dei testi giuridici del padre. Era stato a suo modo “un Erostrato clandestino”.
Comunque persino il presepe allestito dal padre era costruito con l’ausilio di libri, erano essi che, con i loro vari spessori, “movimentavano il paesaggio”.
Verso la fine del volume è rievocata la vicenda che avrebbe potuto costare la vita al professor Francesco Calasso. Dopo l’assassino di Gentile, che viene definito laconicamente “gesto miserabile”, furono arrestati tre docenti, tra cui, appunto il professor Calasso. Fu il console tedesco Gerhard Wolf a salvarli, uno di loro era Ranuccio Bianchi Bandinelli: aveva accompagnato Hitler nei musei di Firenze nel 1938; non poteva venir fucilato.
Quando Roberto Calasso si trasferisce a Roma a metà degli anni Cinquanta non si raccapezzava con i nomi delle vie; la segnaletica era o malconcia o assente. Il padre gli disse: i nomi delle vie di Roma uno li deve conoscere già, da prima.
Ed è proprio a Roma, città in cui “non si arriva da turisti ma da pellegini”, che Calasso conosce Bobi Bazlen, questo triestino di cui si è anche troppo favoleggiato. Il Nostro è lapidario: “Bazlen era inadatto a qualsiasi funzione, se non quella di capire e di essere”. Era uno che aveva già letto tutto, letteratura mitteleuropea, francese, inglese e non solo. Era uno che “sapeva qualcosa in più”. Di se stesso egli diceva di essere “un ibrido fra un bourgeois e un outsider”. Calasso cita ampi stralci dalle opere di questo scrittore senza libri, dove si nota “una certa rapidità insolente, un impulso a passar oltre”.
La vera opera compiuta di Bazlen fu la Casa editrice Adelphi. Alla cui base sta il paradosso dei “libri unici”, ossia libri che nascono da un’esperienza diretta dell’autore, vissuta e trasformata in modo tale da costituire un qualcosa di solitario e autosufficiente. Paradossale perché, di questi libri unici si forma una collana, la “Biblioteca Adelphi”, che si libra dunque tra pluralità e unicità, in misterioso equilibrio.
Di Bazlen rimane a Calasso un oggetto altrettanto misterioso, forse i resti di una caffettiera esplosa. Niente di più vicino a Odradek, l’enigmatico protagonista di un breve racconto di Kafka.
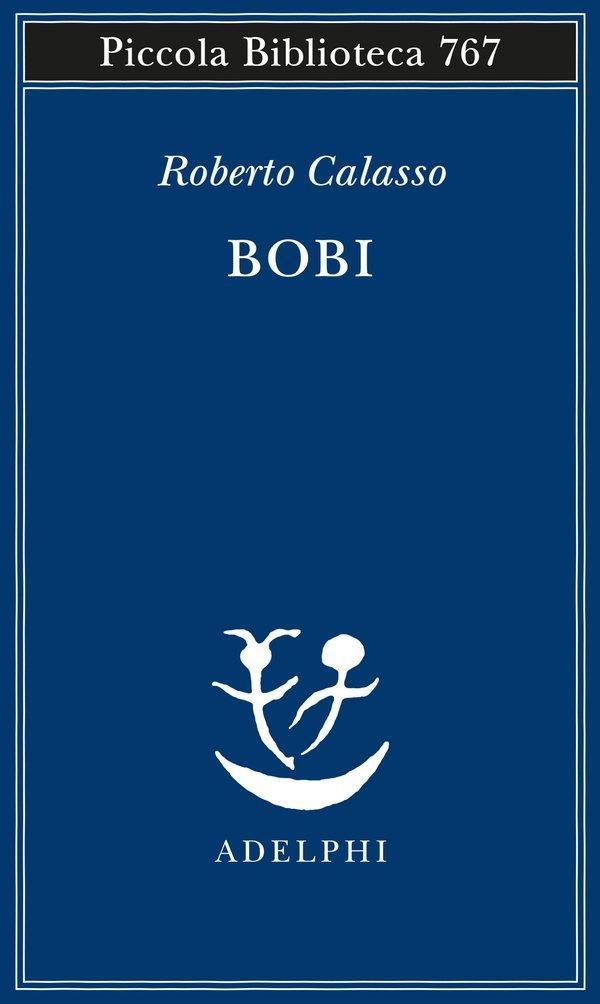
Rimane ora estremamente difficile parlare di Roberto Calasso, l’autore di un’opera immensa e di straordinaria densità. Proviamo a tracciare, con commossa reverenza, alcuni percorsi possibili, senza alcuna pretesa di completezza.
Il nucleo tematico probabilmente più significativo nei suoi testi è quello che lui stesso, con parole di René Guénon, chiamava “interpretazione sacrificale della vita”. Da La rovina di Kasch (1983), un libro in cui, come scrisse Calvino, si parla di due cose, Talleyrand e tutto il resto: “La storia si compendia anche in questo: che per un lungo periodo gli uomini uccisero altri esseri dedicandoli a un invisibile, e da un certo punto in poi uccisero senza dedicare il gesto a nessuno. Dimenticarono? Ritennero inutile quel gesto di omaggio? Lo condannarono come ripugnante? Tutte queste ragioni in qualche modo agirono. Poi rimase la pura uccisione”.
Oggi il sacrificio è diventato l’esperimento. Che è la variante diffusa e desacralizzata del sacrificio.
Il sacrificio non è, come si ritiene comunemente, che so, quello degli aztechi o di altre popolazioni simili. Il sacrificio, teste l’antica filosofia indiana, è inscritto nella nostra fisiologia. È già nell’atto del respiro. È già nell’atto di mangiare. Noi per esistere abbiamo bisogno di far sparire, anche solo il cibo. Ogni attimo della nostra durata dev’esser strappato a forza, con violenza, con precisione, con costanza. Con il sacrificio.
A volte nella storia l’armamentario terminologico del sacrificio viene ritirato fuori, e si parla di olocausto, di vittime, di immolazione eccetera, ma senza che venga mai raggiunta una vera consapevolezza diffusa della sua persistenza.
In alcune pagine memorabili di Le nozze di Cadmo e Armonia (1988), in cui Calasso racconta l’intera mitologia greca, è menzionato un passo di Teofrasto sui Bouphonia, che è la “più alta, la più trasparente formulazione mediterranea della metafisica del sacrificio”.
Tutti coloro che parteciparono all’uccisione del bue furono chiamati a giustificarsi. Le portatrici d’acqua indicano come più colpevoli di loro quelli che avevano affilato le lame. Questi indicano colui che aveva portato l’ascia. Quest’altro indica colui che aveva sgozzato e quest’ultimo indica il coltello.
Il coltello, che non ha voce, venne dunque accusato dell’uccisione. Tutti colpevoli e tutti innocenti. Tranne il coltello, strumento muto, che viene gettato in mare. Ogni volta.
Ma Le nozze di Cadmo e Armonia, oltre alla teoria sacrificale e al suo imprescindibile valore di ricapitolazione globale del mito greco, riveste un’enorme importanza per ciò che dice riguardo le modalità di trasmissione del mito stesso. Che hanno una portata molto più generale e trascendente di gran lunga il mondo greco.
Il mitografo, scrive Calasso, vive in uno stato di perenne vertigine. Perché le storie che racconta presentano varianti infinite. Non c’è un solo mito che sia uguale da un autore all’altro. Le fonti si contraddicono. A volte furiosamente.
Un esempio: Penelope. Proverbialmente il caso più tipico di sposa fedele. Eppure, secondo alcuni (Licofrone), la moglie di Ulisse lo tradì. Lo tradì con tutti i centootto pretendenti, non uno di più non uno di meno. E, dato che aveva tradito Ulisse proprio con tutti, ne nacque Pan (Tutto), il dio della sessualità selvaggia. Altro che fedeltà estrema!
Ma questa pare essere la forma di ogni tipo di comunicazione. Un delirio di versioni contrapposte, dove appare pressoché impossibile pervenire a un risultato certo e non suscettibile di smentite.
Così come nella Rovina di Kash si era partiti dal Settecento, questo secolo di frivolezze, di mondanità, di pettegolezzi e di bon ton e billets doux e si era pervenuti alla carneficina, anche in un’opera come quella su Tiepolo (Il rosa Tiepolo, 2006), artista altrettanto proverbialmente leggero e aereo e vaporoso, esiste una zona oscura, di sapienza pericolosa e accuratamente celata. Il cuore nero dell’artista veneto è rappresentato dalle incisioni dei Capricci e degli Scherzi, frutto di una sapienza arcana e probabilmente legata all’esperienza del sacrificio.
Analogamente un quadro di Degas (e siamo a La folie Baudelaire, 2008) indirizza verso elementi inquietanti e misteriosi. Non si tratta di ballerine, ma di una Scena di guerra nel Medioevo, dove nove donne nude sono ritratte in una campagna spoglia, alla mercé di tre cavalieri armati, impassibili e impeccabili. Calasso definisce la scena “terrorizzante”.
La mistione di mondanità e violenza compare anche in un capitolo, Spuma fui, di Il cacciatore celeste (2016). Quale autore romano antico era meno alla moda di Ovidio? Quale apparentemente meno frivolo ed elegante. Nessuno. Eppure se c’è un poeta che descrive una scena raccapricciante è proprio lui. In un passo delle Metamorfosi, là dove Apollo trafigge la sua amante Coronis, egli nomina un gesto e un suono terribili: “l’istante, l’unico istante in cui ciò che avviene nel mattatoio e nel sacrificio” coincidono. Apollo colpisce “il cavo della sua tempia con un suono secco” (“tempora discussit claro cava malleus ictu”).
Ancora in L’innominabile attuale (2017) è ribadito che “è vano pensare se non si tenta di pensare cosa sia il sacrificio [corsivo originale]”. E questo nonostante siamo ormai in un’epoca in cui si è passati “dal dadaismo al dataismo, da Dada a Big Data”. Del resto “qualcuno ha detto che con la democrazia viene esteso a tutti il privilegio di accedere a cose che non esistono più”.
Vorrei finire queste rapide considerazioni con il libro su Kafka, K., del 2002.
A parte il geniale accostamento di varie situazioni dell’opera kafkiana (ad esempio lo splendido racconto del Cacciatore Gracco) con lo stato di esistenza intermedia del Libro tibetano dei morti (o meglio Bar do t’os sgrol), ciò su cui val la pena di soffermarsi è il senso che Calasso attribuisce al “processo”. Esso “è ciò che originariamente avviene”. Non solo: “Il processo è solo una teatralizzazione temporanea di qualcosa che non si arresta mai”. Ossia non è che uno dei nomi del sacrificio.

