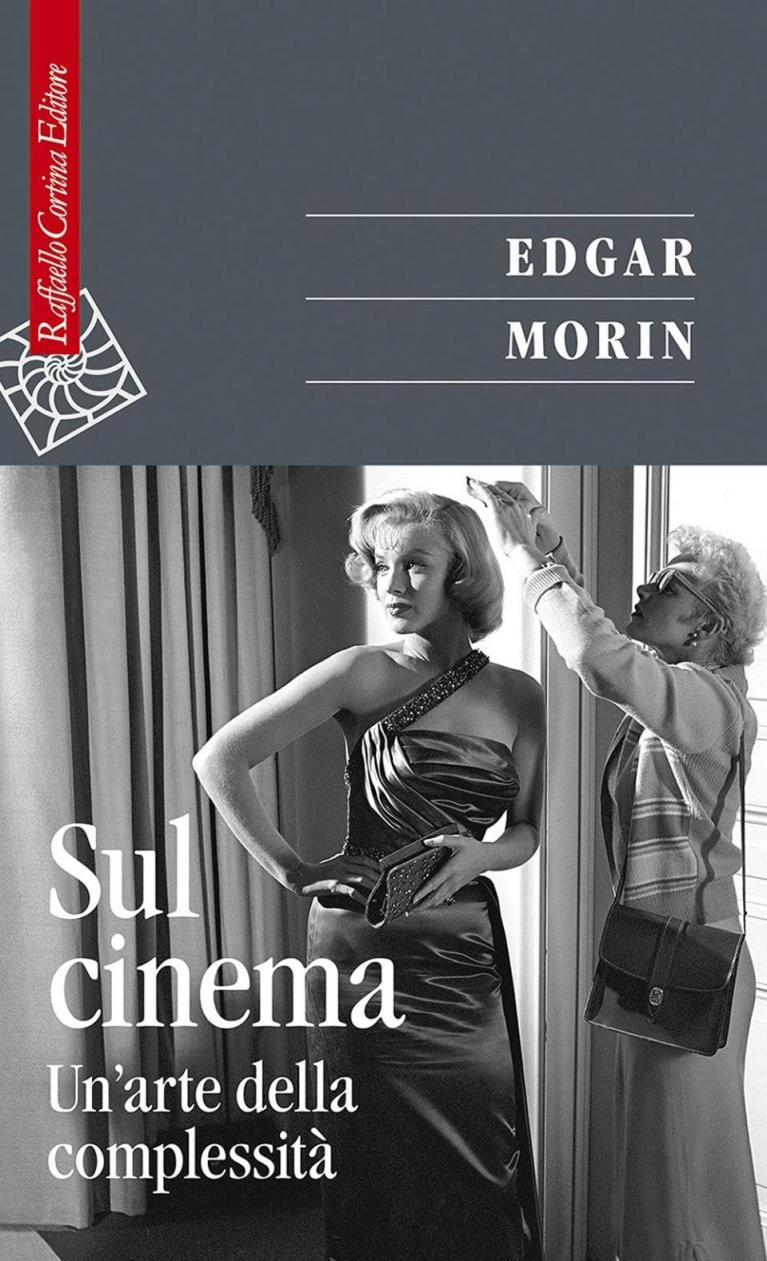“Da ogni spettacolo cinematografico mi accorgo di ritornare, nonostante ogni vigilanza, più stupido e più cattivo” scriveva Theodor W. Adorno. Nella sua critica radicale alla società e al capitalismo il sociologo tedesco invitava a diffidare di tutto ciò che è “leggero e spensierato, di tutto ciò che si lascia andare e implica indulgenza verso la strapotenza dell’esistente” (Minima moralia, 1954). Quando Edgar Morin, il filosofo francese oggi centenario (è nato nel 1921) scriveva i suoi articoli sul cinema, tra il 1954 e il 1960, ora raccolti in Sul cinema. Un’arte della complessità, a cura di Monique Peyrière e Chiara Simonigh, Raffaello Cortina editore, 2021), Marshall McLuhan non aveva ancora pubblicato Gli strumenti del comunicare, che uscirà in America nel 1964.
Ed è singolare notare che Morin, tesserato del Partito Comunista Francese, superando la critica alla società borghese della Scuola di Francoforte e anticipando i temi cardine del cattolico McLuhan, indirizzerà le sue riflessioni verso il rapporto dialogico tra l’immaginario del cinema e il “pensiero che si interroga”, contro una certa ideologia che guardava con sospetto “tutti i media che non fossero il libro” (McLuhan). Altre letture incrociate, per esempio le Lettere d’amore al cinema di Ennio Flaiano (1978), che raccoglie critiche ai film usciti in Italia dal 1939 al 1969 o la raccolta dei pezzi di Alberto Moravia sull’Espresso (Al cinema, 1975) testimoniano del fervore critico, negli anni ’60 e nel decennio successivo, per un mezzo che stava lasciando progressivamente e drammaticamente (perché inizierà da qui il suo lento declino) spazio all’egemonia della televisione.
Sempre agli anni ’50 risale l’introduzione dell’insegnamento di Storia del Cinema nelle università italiane, con le prime lezioni, a Roma, di Luigi Volpicelli, Umberto Barbaro, Luigi Chiarini e Mario Verdone. Affollatissimo, venti anni dopo, all’Università di Firenze, il corso di Storia del Cinema tenuto da Pio Baldelli, contemporaneo alla nascita del DAMS di Benedetto Marzullo, Umberto Eco, Renato Barilli, Adelio Ferrero a Bologna nel 1971. In Francia, come in Italia, il cinema diventava materia di studio, analizzato da Morin e nei seminari universitari per la “cultura d’anima” cui dava vita, come dice Morin, tra Freud e Jean Piaget, operando processi di metamorfosi e rigenerazione di miti, archetipi, topoi, simboli, icone, paradigmi “tutti allo stesso modo immessi in un perpetuo scambio con forme estetiche, narrative e drammatiche, antiche e moderne”. Nella prima parte del volume curato da Peyrière e Simonigh, Morin indaga lo stato “estetico ludico” che coinvolge lo spettatore al cinema, posto davanti a giochi di luce e ombra attraverso proiezioni-identificazioni che danno corpo ed esistenza a personaggi e trasformano lo schermo “in finestra aperta su un mondo vivo”.
Una riflessione sul “doppio” caratteristico dell’immagine cinematografica, dove lo spettatore entra “nell’azione del film fino all’identificazione con il protagonista ma restando, però, cosciente di essere solo uno spettatore…continuando a vivere in modo latente ma lucido, al di qua dello schermo”. Quando scriveva queste parole, nel 1961, Edgar Morin non faceva altro che preconizzare la così detta dissoluzione della mente lineare, la fine della tirannia del testo sui nostri pensieri e sui nostri sensi. Quando si comincia a discutere se gli effetti di un medium siano buoni o cattivi, è sul contenuto che veicolano che ci si accapiglia. Accade anche oggi, nel dibattito sui social network, lo stadio evolutivo della tecnologia radio-cinema-tv, che li fa sembrare ad alcuni un segnale importante di democratizzazione mentre ad altri appaiono come una preoccupante avvisaglia di corruzione della cultura. Il critico cinematografico americano David Thomson scrisse, in una introduzione a Mille Film (Have you seen, 2008): “i dubbi si affievoliscono di fronte alla certezza del medium”, intendendo che è il medium il più forte, che il cinema proietta immagini, sensazioni e sensibilità non soltanto sullo schermo ma anche in noi stessi.

Oggi è quello che fa la Rete, con i social, fruibili tenendo in mano uno smartphone: il suo schermo dissipa qualunque dubbio possa insorgere sul fatto che quel device è nostro padrone, mentre sembra al contrario servirci, accondiscendendo ad ogni nostro desiderio. È l’estetica “vigile-sognante” di cui parla Morin: nella vita estetica l’uomo è spettatore, fisicamente passivo; nella vita ludica interviene una praxis, “ma una praxis condizionata dalla sua partecipazione immaginaria”. È essenziale la coscienza di gioco, dice Edgar Morin, “doppia o tripla coscienza”, necessaria per manovrare anche oggi la nuova cultura digitale, per evitare di esserne manovrati. Il cinema si presenta come una totalità confusa, “un’industria formidabile… un’arte nuova e grandiosa e, come si dice, miti a profusione. Fenomeni di culto. Marchi indelebili sugli individui, su tutta una civiltà. Meglio: l’incontro finalmente realizzato dell’arte e dell’industria, del sogno e dell’utensile, dell’immaginario e della macchina”.
Morin, alle prese con questa realtà “profonda” non può non registrare che “questa realtà così seria in apparenza, è anche la più futile di tutte” essendo un passatempo, una distrazione. Lo stesso, si potrebbe dire, accade oggi nei social, uno stadio evolutivo del cinema, dove i protagonisti siamo noi, dove la realtà può essere modificata da uno storytelling artificioso, dove tra mezzo e fruitore si instaura un legame simbiotico molto stretto. Nel 1939 André Malraux, citato da Morin, scriveva: “il cinema è un’arte ed è anche un’industria”. Gli rispondeva Peter Bachlin “il cinema è merce, eppure è arte”. Non si può fare a meno di leggere questi scritti di Edgar Morin sul cinema senza avere la tentazione di attualizzarli, riportandoli alla Rete, tanto vicini appaiono all’era pionieristica che stiamo vivendo: allora era il cinema a suscitare il dibattito sull’arte dominata dal capitale, oggi è il nuovo capitalismo digitale che permea di sé rappresentazioni soi-disant “artistiche”, di espressione libera del nostro io. Una tecnologia intellettuale finisce sempre per esercitare la propria influenza cambiando il focus del nostro pensiero. “Far luce sul cinema attraverso la società e nello stesso tempo far luce sulla società attraverso il cinema.
Rinnovare la teoria del cinema con la scienza dell’uomo e arricchire la scienza dell’uomo con il cinema” scrive Morin nel 1954. C’è una zona d’ombra della civiltà e dell’avventura umana dove le discipline parcellizzate – storia, psicologia, sociologia, economia – si bloccano e il cinema sta in questa zona d’ombra. Secondo Morin non si può limitare lo studio del cinema al cinema: occorre un “metodo autoregolatore che non inaridisca il proprio argomento isolandolo – e così facendo perdendolo – ma che nemmeno lo disperda nel cosmo”. Non dimentichiamo, avverte Morin con una frase rivelatrice, che “il cinema è nella vita quotidiana. Gli ingressi al cinema si trovano fra i negozi”. È alla vita quotidiana che il cinema si rivolge. L’antropo-sociologia della vita quotidiana è inconcepibile senza un’antropo-sociologia del cinema. Una suggestione che rinvia a questi pensieri la fornisce la bella mostra di Treviso sui manifesti cinematografici realizzati da Renato Casaro (Treviso, 1935): l’artista-artigiano che dipinge le scene madri dei film per convincere il pubblico a comprare il biglietto, è totalmente calato in una realtà commerciale mentre il procedimento che lo guida nel compimento dell’opera è genuinamente artistico: le varianti dei bozzetti per il poster di I magnifici sette di John Sturges (1961), gli otto disegni preparatori per Il Tè nel deserto di Bernardo Bertolucci (1990). Il cinema non solo come arte, ma come specchio a due facce, interessa Morin che legge cosa scrivono i suoi contemporanei Raymond Barkan, Bèla Bàlazs, George Sadoul, Chris Marker, è “il periodo dei dibattiti critici sul realismo al cinema, sul ruolo sociale del cinema versus la sua dimensione artistica”.
Le ultime parti del libro offrono gli scritti di Edgar Morin su Chaplin, Antonioni, Fellini, Bergman; pagine rivelatrici su film come Hiroshima mon amour (di Alain Resnais, 1959), L’amante di Lady Chatterley (di Marc Allegret, 1955), Les amants (di Louis Malle, 1958), Peccatori in blue jeans (di Marcel Carné, 1958), fino a un ritratto di Marylin Monroe e Arthur Miller. Poi, nel 1960, Edgar Morin si reca a Firenze, alla prima edizione del Festival dei Popoli che presenta film etnografici e sociologici: è attraverso il cinema di finzione che quest’arte ha raggiunto le verità più profonde, dei sentimenti e delle passioni degli spettatori ma, in questi film-documentari, Morin scopre “una verità che il cinema di finzione non può contenere e che è l’autenticità del vissuto”. Se il cinema ha bisogno di “messa in scena, di messa in cerimonia, di un arresto della vita” a Firenze Morin ha l’impressione di intercettare un nuovo movimento in grado di interrogare l’uomo attraverso il cinema, senza attrezzature tecniche sofisticate, accettando l’imperfezione del suono e dell’immagine, con la rinuncia a un’estetica formale.
Un cinema che “scopre terre vergini, esistenze che quell’estetica la possiedono segretamente in sé”. La presa diretta sul reale, la verità del mondo dei consumi, la quotidianità mostrata nelle sue molteplici sfaccettature, la possibilità per un autore di portare a termine da solo il suo film, sono elementi di novità che spingono Edgar Morin a ipotizzare la nascita di un nuovo “cinema della fraternità”, che spezzi “quella membrana che ci isola l’uno dall’altro nella metro e per strada, o per le scale di un condominio”. Edgar Morin allude a una sorta di umanesimo tecnologico, dove la volontà umana è il motore di ogni cambiamento, perché ogni strumento tecnologico – e soprattutto il cinema, medium di massa – può influenzare il nostro modo di pensare e di vedere il mondo.