In montagna i paesi di crinale sono altro dall’essere semplici paesi di montagna. Paesi a un’ora di cammino dai passi e dallo svalicare, lì le strade sono sempre state più importanti della chiesa.
Sono i paesi più estranei alle città, paesi come altrettanti lontani limes, eppure la loro recente storia potrebbe essere in grado di insegnare qualcosa anche a chi vive esistenze solo urbane.
Su quei crinali, prima dei nostri giorni, sono sempre state economie di passo, passaggio e transumanze, le uniche possibili.
È così in ragione della realtà quotidiana, fosse legna da tagliare, vendere e trasportare, il pane da cercare altrove nel semestre invernale, le greggi da allevare, una mercanzia di contrabbando da far passare, semplici merci da scambiare e da comprare, così stagione dopo stagione, generazione per generazione, per secoli.
Per questo i paesi di crinale sono diversi, qui il genius loci non è infatti l’architettura del borgo o le sue vie interne ma il crinale stesso, qui non è stata la stanzialità dell’agricoltura a costruire l’umanità delle genti ma il loro errare; almeno così è sulla montagna mediterranea, dove il crinale è distinzione netta tra due mondi, due paesaggi, due vite; il mare di fronte ma lontano, il nord, il continente invece “dentro” e sulle spalle. È la montagna mediterranea di cui Fernand Braudel ebbe a scrivere che ha sempre unito quanto ha diviso; i paesi di crinale hanno espresso una loro specifica preziosa condizione esistenziale insieme all’essere stati un’economia di passo passaggio e transumanze.
Fin qui i tratti minimi, geografici e storici di paesi che potrebbero essere in grado di insegnare qualcosa anche a noi che viviamo esistenze cittadine.
La ragione? Anni luce lontano dalle montagne mediterranee, sorprendentemente la ritrovo nelle parole di Leopold Senghor – poeta, intellettuale e presidente del Senegal – durante il suo discorso di accettazione all’Académie Française: “La vera cultura è mettere radici e sradicarsi. Mettere radici nel più profondo della cultura natia, nella sua eredità spirituale. Ma è anche sradicarsi e cioè aprirsi alla pioggia e al sole, ai fecondi rapporti con le civiltà straniere”. Siamo nel 1983 e uno dei massimi esponenti della cultura africana coglie una realtà essenziale probabilmente valida ovunque. Radicarsi e sradicarsi, la cultura del luogo ma insieme anche la conoscenza di altri sguardi e altri “mondi” possono essere la base di una migliore conoscenza.
L’umanità nomade che per secoli ha travalicato i monti e i crinali della montagna mediterranea per poi ogni volta tornare è stata testimone di questa cultura e di questo sentimento universale.
Sì, è un sentimento quello di cui è impastata la cultura del radicarsi e sradicarsi.
Credo che sia il rivelarsi dell’esperienza di quello che per la filosofia greca era “il divenire”, che è poi la consapevolezza della fragilità della vita e insieme quella del suo ostinato persistere, della sua ricchezza e varietà.
È il sentimento che il premio Nobel Peter Handke (Canto alla durata, Einaudi 1995) cerca e trova in diversi “frammenti di vita” e luoghi; per lui uno su tutti, Porte d’Auteuil, una delle porte occidentali di Parigi: “numerose strade urbane da est, nord e sud confluiscono qui in una larga piazza a curva che si attraversa per andare verso Boulogne, Saint-Cloud e Versailles e di lì in Normandia e al mare… come se la Porte d’Auteuil fosse un passaggio immediato dalla metropoli alla foresta tropicale”.
Qui, anche qui, il sentimento della durata per Handke è l’esperienza del passaggio tra vie e destini diversi, tra radicamento e sradicamento, sempre nella percezione della fragilità della vita e del suo accanito resistere, del suo abbagliante persistere.
Di quei montanari di passo e passaggio ho conosciuto personalmente qualche brandello di memoria delle generazioni precedenti, sufficienti però a farmi conoscere il loro “alito” e sentimento, le differenze con chi sradicato non è mai stato e fa vite solo urbane.
Mio zio Agostino anni fa mi raccontava che ancora nel primo immediato dopo guerra, tornando al paese dopo i mesi invernali in Maremma, era uso fare atto di solidarietà a chi era restato a casa, ai casei, vale a dire chi tutto l’anno non si muoveva da casa e viveva di carbonaie, castagne e di sola agricoltura estiva. La lingua non mente mai e nell’attribuzione di un nome specifico c’è l’evidenza di una stranezza che meritava un nome, quella di umanità sedentaria nella normalità e nella cultura di un mondo nomade. L’atto di solidarietà era pagare in latte e formaggi il fogliame necessario a “impattare” il gregge, ovvero per preparare regolarmente la lettiera nella stalla. I casei, dallo stile di vita oggi diremmo “urbano”, arrivavano infatti stremati alla primavera avendo vissuto delle sole riserve estive.
E ancora tra chi cantava vecchie canzoni di montagna, o stornelli improvvisati (cos’è il canto se non la celebrazione struggente della fragilità e della bellezza della vita?) non ho mai conosciuto nessuno che non fosse appartenuto a quella umanità nomade, nessuno di quei canterini che io ricordi appartenente al genere dei casei, a famiglie e a consuetudini sedentarie.
Supposizioni, coincidenze ma forse no, forse intuizione di una realtà che abbiamo tutti perso.
Comunque sia, di quei paesi, di quella cultura, di quel sentimento oggi cosa resta? Resta solo l’apparente continuità geografica e fisica, quasi sempre ingentilita da restauri e ristrutturazioni, dalla limitrofa presenza di parchi e riserve naturali. Dappertutto la stessa immagine geografica più o meno linda o sdrucita ma sempre ad uso turistico, buona per gli occhi “educati” dall’urbanità e dalla modernità, delle sue abitudini e dei suoi riti.
Sui crinali siamo ormai pronti alle tentazioni affaristiche dell’Airbnb, quasi avvezzi ai tour gastronomici più o meno fittizi, alle apericene e agli spritz, alle finte sagre di disperazione e fantasia: un presente e un futuro di fugace intrattenimento sembra l’orizzonte più probabile della montagna di crinale.
Oggi insomma il crinale non è più un limes, un confine tra due vite diverse, un’unica umanità urbana sembra essersi impossessata delle sue case e del suo destino, ormai tutti casei, ormai quasi tutti ignari di quel sentimento che era anche il suo genio loci. Di quell’umanità in grado di parlarci e insegnarci qualcosa del nostro modo di vivere restano solo labili tracce di memoria per fare luce.
Ma questo è e questo c’è, questo è il presente con cui occorre fare i conti, amen e così sia.
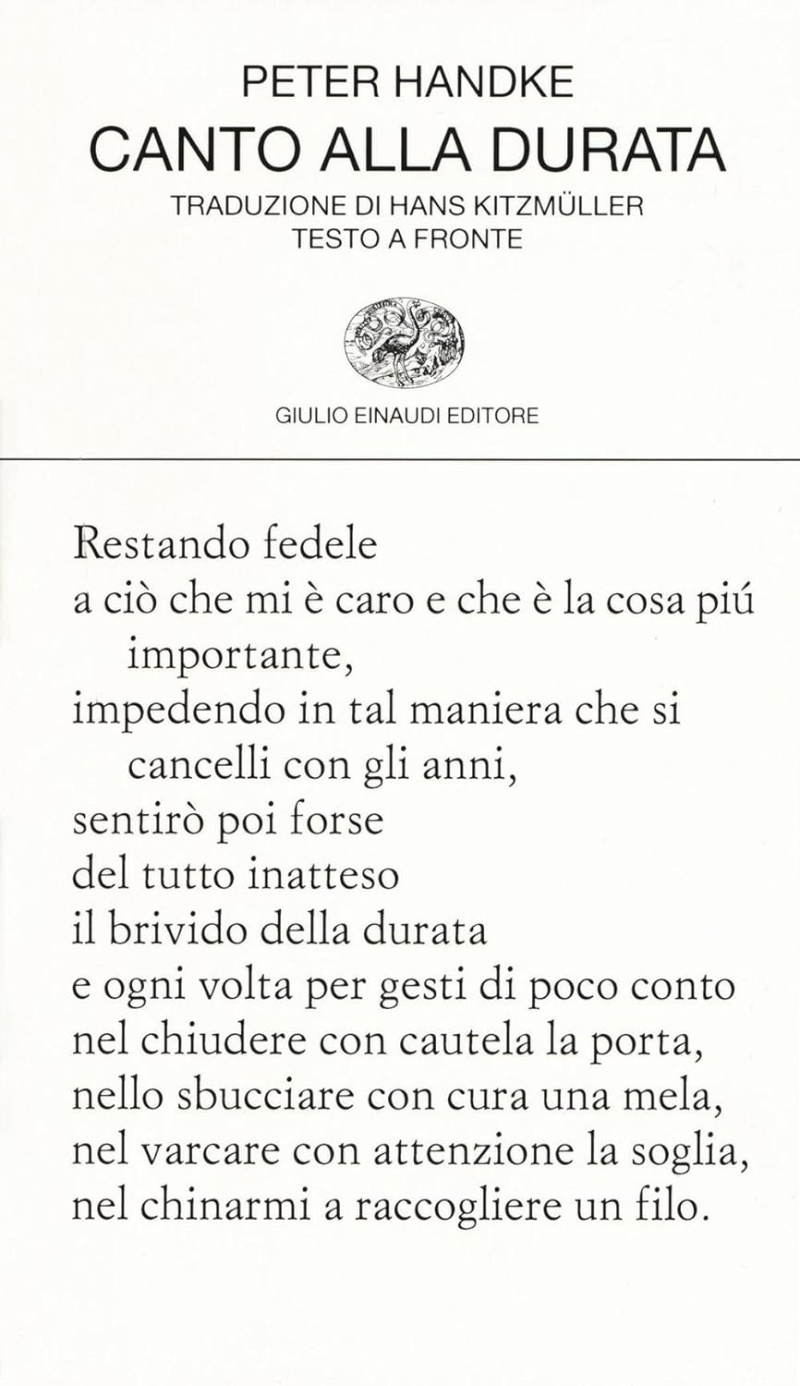
Dieci anni fa scrivevo in questi spazi un articolo (Turismo di comunità) su una cooperativa di lavoro e turismo di comunità operante al mio paese, nell’Alpe tra Toscana ed Emilia. Un paese di crinale come tanti sui monti mediterranei, non importa dunque ora il nome. Scrivevo tra l’altro che sette stipendi erano comunque un miracolo e concludevo che “Saranno probabilmente i prossimi dieci anni a raccontare se questa idea ha avuto un futuro”.
Dieci anni dopo possono esserci alcune risposte
Il 24 giugno scorso, San Giovanni, patrono del paese, nei giorni dei vent’anni della Cooperativa, invitato insieme a molti altri, festeggiavo in una bella aia quella ricorrenza lieta. Polenta di mais, polenta di castagne e carne di maiale, salumi, torte d’erbe, formaggio grana e pecorino, vini di diversa origine, torte in ogni maniera erano, insieme alle parole, il “cibo vivo” di quella giornata. Festeggiavamo San Giovanni e vent’anni di esistenza di una cooperativa in cui gli stipendi nel frattempo erano diventati nove. Peraltro unica realtà economica del paese, insieme a un eroico ristorante pizzeria, un paio di artigiani dell’edilizia, un paio di persone a tagliare e vendere legna, stop; il resto solo reddito da pensione. Quei vent’anni e quei nove stipendi erano ai miei occhi un miracolo ripetuto e confermato. Una festa perfetta, sarebbe sembrata dunque a un qualunque semplice invitato
Eppure… eppure c’era in quella festa solo metà dei residenti, segno di una divisione, segno evidente di una sconfitta, per tutti. Del resto – fosse stato questo il motivo della frattura – è impossibile chiedere a una cooperativa di servizi e di turismo di comunità di lavorare solo per quella comunità quando in dieci anni il paese si è ridotto a quaranta residenti e solo una nuova nata. Qui, il miracolo di nove stipendi va cercato fuori, oltre il crinale come sempre è stato; il pane, come sempre è stato, va cercato altrove. Oggi come ieri è impossibile in montagna un’economia stanziale… i casei un tempo potevano solo sopravvivere, oggi i più vivono di rendita o di pensione.
Poi, poi in quella festa si poteva avvertire intorno qualche increspatura di fragilità, qua e là un’atmosfera malinconica si insinuava tra quei festeggiamenti.
Forse la sensazione che in quella festa la sostanza di dieci anni prima fosse più lontana, mentre gli entusiasmi erano nel frattempo diventati altro in un paese che aveva cambiato pelle e sostanza.
Il turista infatti oggi vuole godere comunque dei suoi agi e delle sue abitudini ovunque vada: così nel tempo la solidarietà ha cambiato di segno… sono i casei tutto l’anno, sono cioè i turisti che rendono quattrini alla comunità che ha perso il suo seme originario.
Un mondo alla rovescia sta cercando le sue ragioni di sopravvivenza.
Così può capitare che un circolo votato ai piccoli servizi per la comunità – lo spaccio alimentare, qualche ora di apertura del caffè – sembra possa sopravvivere solo per le abitudini urbane dello spritz o dell’apericena, possa sopravvivere solo per i consumi d’agosto dei turisti urbani, con le loro abitudini, le loro voglie ed egoismi, i loro karaoke, il loro parlare con i cani…
Così capita che in un paese si possano creare due “partiti”, due modi diversi di vedere in fondo il mondo… Chi cerca di guadagnare un “pane moderno” altrove, travalicando il valico quasi tutti i giorni, andando e tornando, chi pensa che tutto debba essere mantenuto e difeso in loco; del resto, le epoche di passaggio sono sempre nebulose, traumatiche anche nell’infinitamente piccolo.
Altrove, i casei hanno probabilmente vinto, lo dice la storia, lo dice la globale rincorsa ai modelli urbani, lo dice la quotidianità delle nostre vite legate ai consumi e al vivere di un solo luogo.
Una vecchia favola attribuita ad Esopo ma forse di origine indiana sento che rappresenta in qualche modo il sentimento sotteso in quella festa, il sentimento che un cambiamento è alle porte e che è difficile resistere a un destino. La favola è quella della rana e dello scorpione che chiese alla rana un passaggio sulla schiena per attraversare il fiume. “Fossi matta a trasportarti di là, tu mi pungi e io muoio” fu la risposta della rana.
“Perché dovrei? Se lo facessi morirei anch’io.”
Convinta da quest’affermazione la rana accettò di trasportare lo scorpione sulla schiena fino a quando questo giunti a metà del guado la punse. “Mentre entrambi stavano per morire la rana chiese all’insano ospite il perché del folle gesto. “Perché sono uno scorpione…” rispose lui “È la mia natura!””
Ecco, se ci ripenso in questa favola c’è qualcosa che ha a che fare con l’orgogliosa e consapevole malinconia nascosta di quella festa, è il sentimento di vedere la trasformazione della comunità in qualcosa di diverso da come era sempre stata, la sensazione di essere sempre più circondati dalle abitudini, dai vizi, dai consumi, dagli egoismi urbani trapiantati nell’alpe: tutte come altrettante punture di scorpione che avvelenano, lentamente o meno poco importa.
Non importa il nome del paese, le trasformazioni che stiamo vivendo so che valgono per molti. Non importa il nome come non importò a Silvio D’Arzo quando ambientò il lungo racconto che Montale giudicò “perfetto” – Casa d’altri – in questo stesso paese di crinale. Non ne cito il nome ma da qualche tempo so perché quel racconto, pur molto bello, non mi è mai piaciuto fino in fondo. Ambientato soprattutto d’inverno parla sostanzialmente di un’umanità grigia e stanziale, i casei appunto che restavano tra neve, freddo e animali nelle stalle. L’altra metà del paese, quella che travalicava i monti e contaminava il piano e dal piano era contaminata, quella che ogni anno si radicava e si sradicava, che riportava canti e solidarietà, in quel racconto è del tutto assente o mal conosciuta.
Nelle comunità di allora, quel paese era una menzogna, settant’anni dopo, in forma aliena da contemporanea sta diventando realtà.

