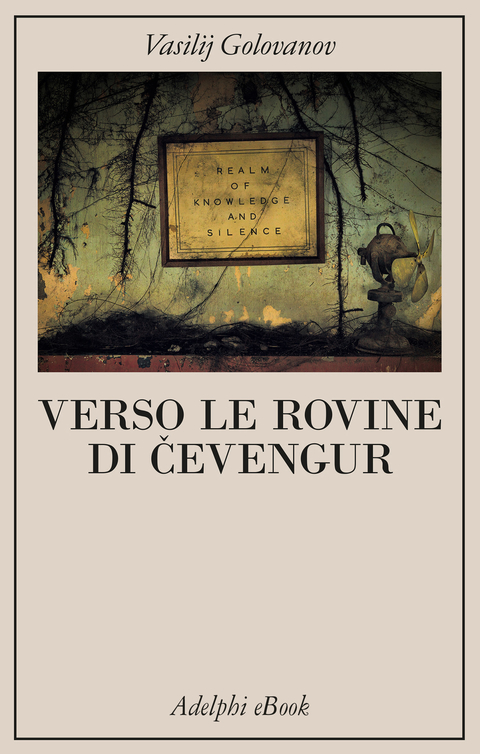Nel novero dei generi letterari, il racconto di viaggio è forse l’unico ad avvicinarsi al compimento della celebre formulazione retorica dell’ut pictura poesis, non tanto per la sua peculiare tendenza ad articolarsi per descrizioni, quanto perché il rimando di tali descrizioni a una realtà esperibile (il viaggio) ne trasferisce sul piano spaziale l’elemento temporale che sta alla base di qualsiasi narrazione. Ovviamente tale formulazione funziona a pieno regime qualora il racconto si muova seguendo un criterio di oggettività per così dire responsabile – le descrizioni, puntuali ed esaustive, di terre e popoli lontani osservati con i propri occhi tipiche della tradizione anglosassone – ma quando i luoghi descritti si fanno metafora di una condizione esistenziale, spirituale o politica che dir si voglia, l’avvicendamento della temporalità del racconto con la dimensione spaziale della realtà fenomenica assume un carattere di complessità tale da smuovere la terra stessa sulla quale lo scrittore si è messo in cammino.
Si pensi ai famosi Racconti di un pellegrino russo quale esempio di una analoga situazione, laddove, a una descrizione di viaggi (con ogni probabilità del tutto immaginari) attraverso l’immensità degli spazi della Russia, corrisponde l’approssimarsi a un ordine temporale di natura superiore, idealmente rappresentato da un centro metafisico che sarebbe, secondo i dettami della teoria esicastica che sostiene l’ideologia del racconto, la meta di qualsiasi pellegrinaggio verso l’ascesi spirituale.
La spasmodica ricerca di lenimento a un disagio esistenziale, che riflette il senso di smarrimento nel quale la Russia è sprofondata dopo il tramonto dell’utopia sovietica, è il tema che anima i pellegrinaggi riportati in Verso le rovine di Čevengur di Vasilij Golovanov (Adelphi, 2023), raccolta di racconti di viaggio meritevole di approfondimento pur a fronte delle sue vistose carenze formali e della banalità dei suoi contenuti; è in effetti da simili operazioni editoriali che si può ricavare una lezione circa il problematico rapporto intrattenuto dall’Occidente con la cultura russa, la cui natura è stata analizzata da Luigi Zoja, su queste stesse pagine, in un articolo puntuale ma che ci sembra trascuri un punto della questione ai nostri occhi assai importante, cioè a dire il problema delle modalità di ricezione della suddetta cultura in Occidente. Dato per supposto che l’inquietudine descritta da Golovanov trovi una sponda nel senso di smarrimento che attanaglia anche la nostra civiltà e che essa si possa assumere quale metro di giudizio per misurare la nostra perdita del centro (per usare un’espressione cara a Ernesto De Martino ripresa da Hans Sedlmyr) quel che colpisce, a una prima osservazione del testo, è il profluvio di luoghi comuni sulla Russia utilizzati dall’autore quali formule caricate di significato salvifico – luoghi comuni che, agli occhi del lettore appassionato di letteratura russa, subito richiamano alla mente un universo familiare. La steppa sconfinata e la piccola izba, l’ingenua sapienza contadina e la tendenza verso l’Assoluto, le armate a cavallo e l’odore di incenso, nulla manca in questo arsenale semantico per evocare il mondo dei romanzi di Tolstoj e di Dostoevskij, del cinema di Pudovkin e di Tarkovskij, del teatro e dei racconti di Čechov, della lirica di Puškin e di Blok. Una teoria di forme talmente riconoscibili da indurre il sospetto di una precisa volontà nel soddisfare le aspettative del pubblico occidentale, abituato a rapportarsi con l’alterità secondo canoni stereotipi. Inutile dunque vagheggiare circa affinità spirituali basate su archetipici bisogni, quando il nostro rapporto – mediato dal luogo comune – con la Russia ci appare storicamente verificabile; più utile e produttivo sarebbe invece sforzarsi di identificare quei meccanismi che, attraverso il luogo comune, orientano il gusto dei lettori verso la ricezione ideologica di manufatti culturali provenienti da paesi lontani. Nel caso di Golovanov, l’approccio marcatamente estetico al genere letterario in questione ci spinge a una valutazione più attenta della sua piaggeria, per non dire delle sue intenzioni.
Il viaggio come tensione verso un’origine inafferrabile, l’elogio del nomadismo quale stile di vita raccordato con un ritmo temporale propriamente umano, la scelta del vagabondaggio come antidoto allo sradicamento esistenziale, il bisogno di perdersi per ritrovarsi: il massiccio utilizzo da parte di Golovanov di questi futili cliché sembra voler riproporre il feticcio romantico del viaggio quale nostalgia di infinito e ritorno alle origini, articolato all’interno di una cornice narrativa viziata dalla presenza opprimente di un simbolismo iniziatico. In quest’ottica trova una spiegazione il ricorrente artificio retorico della nostalgia dei bei tempi andati che, nel corso della narrazione, si appoggia a una pletora di citazioni, più o meno esplicite, di autori quali Eliade, Guénon e Tolkien, a suggello di un orientamento decisamente retrivo nel considerare il concetto di tradizione culturale.