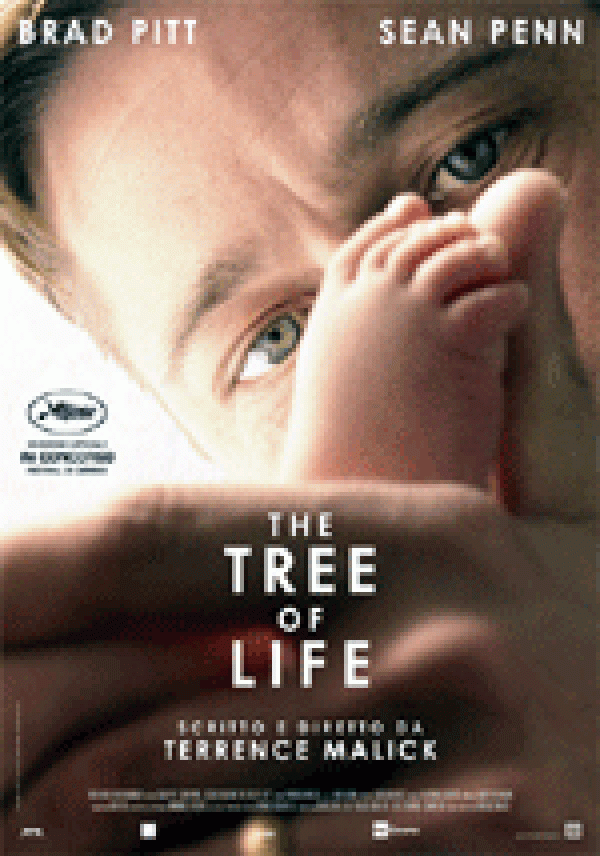Abbiamo visto The tree of life diretto da Terrence Malick.
Mallick è della generazione dei Coppola, degli Scorsese, degli Steven Spielberg, dei David Lynch, eppure – nonostante abbia fatto solo 5 film dal 1973 e siano passati ben vent’anni tra il secondo e il terzo – è circondato dall’aureola della genialità ed è entrato nel mito, sul genere di Salinger o di Bowles in letteratura. Già dal suo debutto alcuni addetti ai lavori pensavano di lui un gran bene. Il suo primo film La rabbia giovane ha avuto un certo successo mondiale ma non quei trionfi che si aspettavano. Quell’anno era uscito un film di Scorsese Mean street che gli aveva fatto ombra internazionalmente. Il film aveva dei tratti in comune con A sangue freddo famoso romanzo di Truman Capote, ma non riuscì a diventare una pietra miliare come invece è diventato il libro. Il suo secondo film I giorni del cielo (con una splendida fotografia del grandissimo e compianto Nestor Almendros e con partiture di Ennio Morricone) ebbe riconoscimento internazionale. Successivamente ha realizzato un film sopravvalutato dalla critica La sottile linea rossa, e anche in questo caso il film è stato ‘offuscato’ da un altro film, questa volta di Spielberg Salvate il soldato Ryan, uscito quasi contemporaneamente. Il quarto film è del 2005 The New Word e racconta l’avventurosa e sfortunata vita di Pocahontas morta a 22 anni. In questi giorni, nelle sale esce il suo ultimo lavoro The tree of life appena passato al Festival di Cannes e premiato – come per il passato – con la Palma d’Oro. Un film molto atteso, da alcuni definito un capolavoro prima ancora di essere visto, qualcuno ha asserito addirittura che avrebbe riscritto la storia del cinema. Tanta attesa fideistica non poteva essere che pericolosa nei confronti di Malick e del suo film. Ma cosa differenzia questo solitario e ritroso autore statunitense dai vari altri grandi registi internazionali? Probabilmente le sue attitudini estetiche, un amore per la fotografia, per una sapienza di montaggio emotivo sperimentale e quasi da avanguardia (ci sono voluti 5 montatori per quest’ultimo), per delle immagini che sono visibili normalmente più in una biennale d’arte che in una sala cinematografica; immagini di acque tumultuose, di ruscelli, di venti, di stormi, di nuvole, di rocce, con una voce fuori campo che fa da accompagno, da pensiero, da poesia e da sentimenti profondi in forme quasi metafisiche. E dove gli attori pensano più che parlano e dove i personaggi vivono malesseri e dolori come fossero una rappresentazione mossa a uso e consumo del regista. Tutto questo è ‘l’albero della vita’ e non si può dire che sia un film nuovo o sconvolgente, nemmeno un capolavoro, perché dare una definizione del genere a un’opera vorrebbe significare che non dovrebbe avere un certo compiacimento, una voglia anche di rimestare in cose già dette o viste. Malick in questo film parla dei massimi sistemi (per l’appunto, l’albero della vita) della vita, della morte, degli affetti, del dolore, della difficoltà di vivere, della difficoltà di conoscere e riconoscere i sentimenti e quindi di accettarli e mostrarli, della lotta tra cervello e cuore e quindi preferire il tentativo dell’affermazione sociale piuttosto che essere felici dei propri sentimenti. Il tutto è narrato con un naturalismo che percorre canali espressivi a volte ostici per lo spettatore, a volte difficili da comprendere, a volte banali nella loro componente simbolica (come la caduta della maschera nera nell’acqua o camminare sui bordi del mare vestiti ma con i piedi nudi – in un’immagine molto simile all’ultimo film di Eastwood). Malick in questo film ha radicalizzato l’estetica che c’era già nei suoi precedenti film, ha voluto estremizzare il suo intuito, la sua visionarietà senza curarsi troppo dello spettatore, volendolo trascinare su un lato emotivo, quasi che dovesse perdere la parte razionale.
Il film è ambientato negli Anni Cinquanta, in un paesino del Texas. C’è una famiglia composta da un padre anaffettivo, duro, autoritario ed esigente con se stesso e quindi con gli altri (Brad Pitt), una madre paziente, protettiva, buona e succube (Jessica Chastain) e da tre figli maschi adolescenti; tutto prosegue ‘normalmente’ fino quando giunge una lettera e la tragedia: il secondo fratello è morto (era malato da tempo e in un ospedale? – lo vediamo solo successivamente, in modo frammentario e con una parte dei capelli rasati come se avesse subito un’operazione). Pianti, disperazione, il funerale e con la tragedia iniziano le classiche domande sulla vita, sulla morte, sull’origine di noi e sulla natura. La storia si sposta per un breve tratto ai nostri giorni in una metropoli, Jack – il primo figlio – (Sean Penn) ha la vita che avrebbe voluto il padre, competitivo, affermato e forse solo. Riceve una telefonata: è morto qualcuno in famiglia? E inizia la parte – una ventina di minuti – visionaria e primordiale fatta di onde del mare, di uccelli in movimento e si giunge fino al giurassico. Si ritorna quindi agli Anni Cinquanta per ricostruire e ricomporre i rapporti e gli affetti di questa famiglia texana che vive nel dolore della morte del secondo fratello e della perdita nel padre di tutti i miti che ha rincorso e che non è riuscito ad afferrare come l’affermazione sociale e il riconoscimento di essere un uomo di successo. La storia termina su una spiaggia in cui si rincontrano genitori e figli nelle varie età con la consapevolezza che senza amore la vita scorre via più rapida.