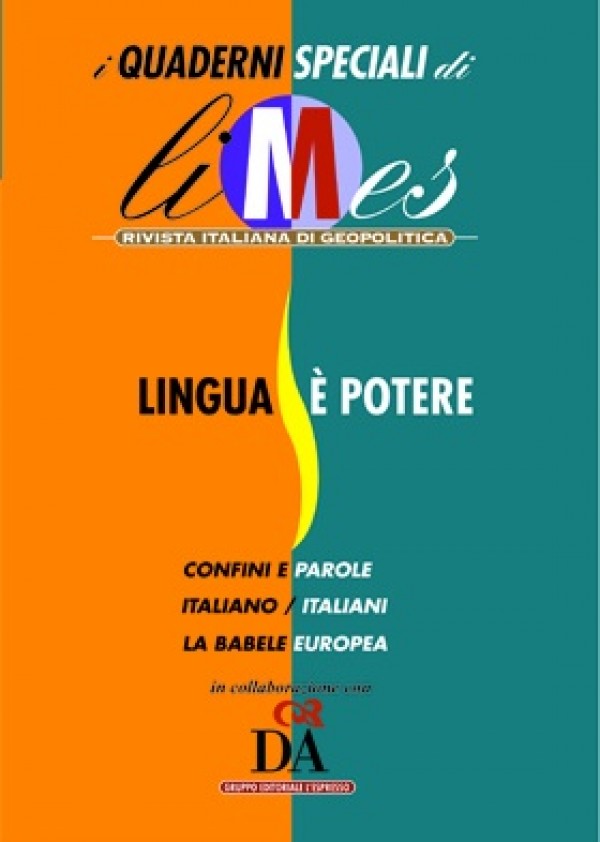Se la lingua è potere
L’Italia si appresta a celebrare i suoi primi 150 anni di unità in un clima sobrio, tendente a ragionevole depressione. Fin troppo evidenti, ripetuti – spesso ripetitivi – gli argomenti che possono inclinarci al pessimismo. Varrebbe la pena soffermarci anche sui successi. Tra i quali forse il più importante è l’affermazione dell’italiano come lingua della grandissima maggioranza dei cittadini della Repubblica.
Le stime di alcuni filologi indicano in una esigua cerchia, pari all’8% degli abitanti del Regno (altri optano addirittura per il 2,5%), gli italofoni all’epoca dell’unificazione nazionale. Gli altri si esprimevano solo nei vari dialetti, spesso fra loro incomunicanti. Sotto la monarchia sabauda la prevalenza dei dialetti diminuirà, senza però che l’italica favella si affermasse come lingua maggioritaria.
Solo con la Repubblica, grazie anche ai mezzi di comunicazione di massa, televisione pubblica in testa, si compie la svolta che porta oggi nove cittadini italiani su dieci a convergere verso la lingua italiana. Come ricorda Tullio De Mauro nel quaderno speciale che Limes, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, ha dedicato alla geopolitica delle lingue (“Lingua è potere”), “mai in tremila anni di storia le popolazioni italiane avevano conosciuto un simile grado di convergenza verso una stessa lingua”.
Non si tratta di pura ascesa culturale, né solo della rottura dei vincoli di classe che frenavano la vasta fruizione di uno dei più belli e ricchi idiomi del mondo. È soprattutto una conquista democratica. Raggiunta non per caso in età repubblicana, non con lo Stato oligarchico-liberale né sotto il fascismo.
Il fatto che la grandissima maggioranza dei nostri cittadini abbia accesso alla lingua comune – senza negare l’uso parallelo del dialetto o di altre lingue, minoritarie in Italia – è la premessa fondativa di qualsiasi società democratica. Perché permette di intendersi, di argomentare e di disputare a partire da una comune base linguistica e culturale.
Non così negli ambiti autoritari. Ad esempio nelle organizzazioni criminali. Dove il ricorso al gergo, spesso modulato su dialetti locali, aderenti a un territorio sottratto al controllo dei poteri pubblici, è usuale e distintivo. Su un piano molto diverso, la tentazione gergale si esprime in certe disposizioni burocratiche, private o pubbliche.
E sempre più nelle leggi, quando l’opacità espressiva serve a precludere al cittadino la comprensione delle regole del nostro vivere associato, riservata a superiori poteri. Fino al caso delle istituzioni comunitarie, che hanno sviluppato un eurogergo capace di attrarre l’attenzione di filologi irriverenti.
È proprio sul piano europeo, dove l’italiano è sopraffatto dalla triade linguistico-geopolitica dominante (inglese, francese e tedesco, in quanto idiomi dei cosiddetti “Tre Grandi” – Regno Unito, Francia e Germania), che si svolge oggi un formidabile conflitto di potere su base linguistica. Noi italiani non sembriamo interessarcene troppo, meno ancora il nostro governo.
A ricordarci che la convergenza linguistica è condizione necessaria ma non sufficiente della democrazia. Specie in Italia, dove l’italofonia diffusa non ha tuttavia prodotto quel grado di convergenza geopolitica e culturale che distingue i paesi usi a discutere, elaborare e difendere il proprio interesse nazionale, da quelli che vi hanno rinunciato. Così finiamo per rimetterci alla determinazione altrui. E svuotiamo di senso quella democrazia che la lingua ha contribuito a fondare.