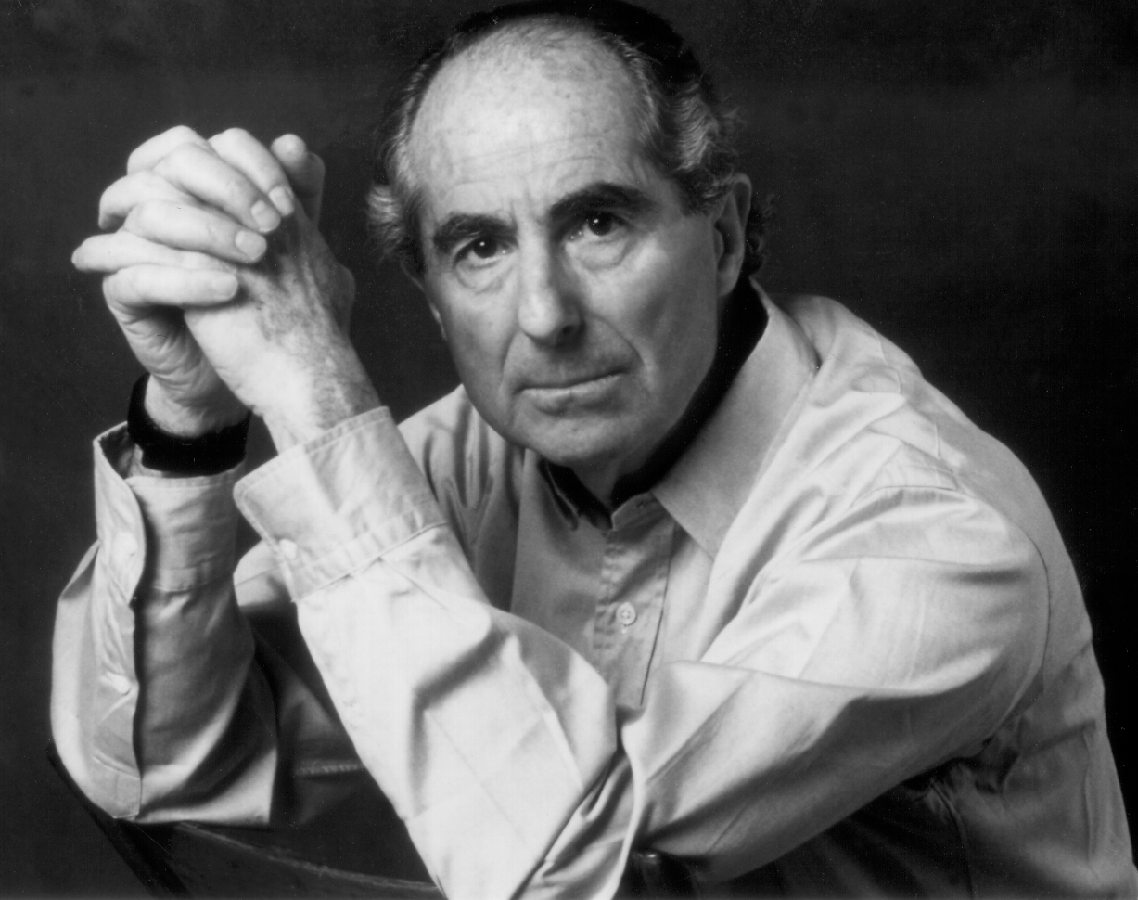Dopo la clamorosa decisione di Philip Roth di smettere con la scrittura, questa rubrica intende offrire uno sguardo retrospettivo sulla sua opera, dai grandi capolavori ai libri meno noti; l’omaggio parziale e appassionato di un lettore irrimediabilmente compromesso, ma anche l’onesto tentativo di analizzare dall’interno il segreto della sua magia, le sue contraddizioni, le doti di lealtà, ironia, umanità e sapienza letteraria: gli ingredienti che l’hanno portato a essere tra gli scrittori più visceralmente amati da due generazioni di lettori. Qui le puntate precedenti. (Fonte immagine.)
Nel momento in cui un narratore si accinge a scrivere un romanzo, non sempre ne ha ben chiara in mente la trama. A volte parte da una vaga intuizione, immagina un luogo, una frase suggestiva, un personaggio, e comincia a scrivere sulla base di quello spunto iniziale, senza sapere quale sarà l’evoluzione della storia. Se da un lato è vantaggioso disporre di un chiaro schema narrativo fin dalle fasi iniziali della stesura dell’opera – perché consente l’elaborazione di un intreccio più sofisticato e agevola la definizione di personaggi più robusti e meglio delineati –, d’altro canto la mancanza di coordinate diegetiche troppo definite aiuta l’autore a non cadere nella trappola del romanzo a tema, e lo lascia libero di inseguire l’auspicio hemingwayano del«dire la cosa vera», rappresentando «la successione dei movimenti e dei fatti che producono l’emozione».
Ci sono scrittori, come William Faulkner o – tra i contemporanei – Jonathan Franzen, la cui efficacia è fondata sulla costruzione di un intreccio lento e inesorabile, in cui il lettore è trasportato come in un vortice nel cuore palpitante della narrazione, secondo dinamiche centripete e avvolgenti: sono coloro che offrono il meglio di sé nella misura lunga, nelle storie corali, nelle saghe familiari di respiro generazionale. Ce ne sono altri poi che preferiscono puntare sulla rappresentazione accurata del singolo episodio piuttosto che sull’intreccio di storie differenti, sull’intensità piuttosto che sulla complessità, sulla precisione lessicale piuttosto che su strutture narrative articolate. (Con ciò non intendo affermare che l’attenzione allo stile sia una prerogativa esclusiva di questa seconda tipologia di narratori, ma solamente che essi, più attenti al dettaglio che alla visione d’insieme, sentono maggiormente l’esigenza di sfruttare al massimo i propri strumenti stilistici.)
Tra questi, troviamo principalmente scrittori di racconti, come Raymond Carver o Harold Brodkey, capaci di fotografare un destino in una frase, di fare intuire un intero universo dietro una scena lasciata in sospeso; ma anche autori eclettici, come Hemingway o Fitzgerald, che hanno dato prove memorabili sia nelle short stories che nei romanzi lunghi. E ci sono poi dei romanzieri puri, a testimonianza del fatto che la misura della narrazione non è un semplice fatto muscolare, quanto una questione di attitudine e speciale sensibilità.
Quando penso a questo modo di scrivere, non posso fare a meno di ricordare come Philip Roth abbia iniziato a comporre L’umiliazione sedotto dalla semplice bellezza di una frase («Aveva perso la sua magia»), costruendo il resto del romanzo intorno all’idea suggestiva di un attore che di punto in bianco perde la propria capacità di recitare. Se la predisposizione di un intreccio particolarmente elaborato tradisce l’intenzione dell’autore di celare un senso ben delineato all’interno della propria opera, la propensione a concentrarsi maggiormente sui dettagli della narrazione è spesso indizio di un certo scetticismo dell’autore nei confronti dell’opportunità stessa di trasmettere un significato tramite la propria opera.
Forse è proprio la rinomata allergia che Roth nutre verso quanto appare troppo rigidamente strutturato («quella inspiegabile esagerazione, il significato… l’inevitabile preludio a non capire») a costituire la caratteristica principale dei suoi romanzi. La sua cifra narrativa più rilevante non consiste tanto nella complessità della storia (che pure in alcuni testi raggiunge livelli notevoli), quanto nella creazione di situazioni narrative tese a evidenziare esplicitamente la perdita del senso. Nelle sue opere, la maggior parte degli avvenimenti non scaturiscono da un disegno preesistente, ma sembrano innescati da un enzima che ne catalizza lo svolgimento secondo procedimenti provvidenzialmente casuali, laddove il caso ha spesso i connotati di un’intrinseca drammaticità.
In un romanzo rocambolesco come Il teatro di Sabbath – nel quale il protagonista compie un viaggio avventuroso da un’immaginaria cittadina del New England fino a New York City, e dal New Jersey nuovamente in Massachusetts, ripercorrendo tutta la sua esistenza picaresca in un continuo andirivieni tra presente e passato –, ciò che si apprezza maggiormente (oltre allo stile magistrale) non è la complessità dell’intreccio, quanto la capacità dell’autore di dare vita a personaggi irresistibilmente compromessi dalla storia.
Il romanzo si apre con uno degli incipit più memorabili dell’autore americano: «Giura che non scoperai più le altre o tra noi è finita. Questo l’ultimatum, il delirante, improbabile, assolutamente imprevedibile ultimatum che la signora cinquantaduenne impose tra le lacrime al suo amante sessantaquattrenne, il giorno in cui il loro legame, di stupefacente impudicizia e altrettanto stupefacente riservatezza, compiva tredici anni. E adesso che l’afflusso di ormoni andava esaurendosi, e la prostata ingrossava, e forse non gli restavano che pochi anni di potenza relativamente affidabile, e forse ancor meno di vita; adesso, quando si avvicinava la fine di ogni cosa, gli veniva imposto, per non perdere lei, di stravolgere se stesso».
Lo stile è ostentatamente ampolloso, ricco di avverbi e di aggettivi che non ambiscono tanto a fornire indicazioni sullo svolgimento della trama, quanto a descrivere l’istante esatto dell’evento narrato. Sabbath e Drenka sono amanti di vecchia data che si ritrovano a un convegno amoroso per celebrare il tredicesimo anniversario della loro unione. Non sono più giovani, ma la natura della loro relazione è spudoratamente sensuale. Le reazioni dei protagonisti vengono amplificate tramite precise scelte lessicali («delirante», «imprevedibile», «stupefacente»). I personaggi rothiani hanno tratti distintivi sempre molto decisi, mai sfumati. La loro umanità non si rivela nell’uniforme normalità del quotidiano, quanto in una sorta di esasperazione nei confronti della precarietà. Anche – o soprattutto – i più remissivi, i meglio disposti ad accettare di buon grado le avversità dell’esistenza (personaggi assolutamente ragionevoli come lo Svedese di Pastorale americana, Marcus Messner di Indignazione o Bucky Cantor di Nemesi), finiscono sempre per scontrarsi con l’efferata intransigenza delle circostanze. La loro vita è un itinerario fatale verso il breakdown, una corsia preferenziale che conduce allo scontro inevitabile con il destino.
La ribalta è tutta per i personaggi, per le loro debolezze, le loro contraddizioni. Più che essere avviati da subito negli intricati viluppi di un intreccio ben architettato, essi vengono esposti al perturbante potere dell’imprevisto. Sono materia viva, cedevole, privi di una forma definitiva, abbandonati alla minaccia dell’incognito e della trasformazione. All’autore non interessa incanalare da subito il romanzo nei binari di una trama coinvolgente, nella quale condensare immediatamente un significato; egli, al contrario, intende mettere i propri personaggi di fronte al dramma della perdita del senso, a prescindere dal motivo e dalle conseguenze.
In Pastorale americana, Seymour Levov (lo Svedese) è un uomo che sembra capace di gestire al meglio ogni aspetto della propria vita; non solo i doni provvidenziali di cui la natura lo ha ricolmato (un fisico atletico, una naturale predisposizione per ogni tipo di sport, la bellezza, la simpatia, l’umiltà, la determinazione), ma anche le situazioni più difficili dell’esistenza: «Una bella moglie. Una bella casa. Un’azienda magistralmente gestita. Un padre difficile trattato abbastanza bene. L’aveva realizzata per davvero, la sua versione del paradiso. Così vivono gli uomini di successo. Sono buoni cittadini. Sono fortunati. Sono riconoscenti. Dio sorride loro. Se ci sono problemi, si adattano».
Poi, d’improvviso, tutto cambia. Meredith, la sua adorabile bambina, diviene dapprima un’adolescente odiosa e intrattabile, poi una convinta attivista politica, e infine una terrorista che si rende responsabile di un attentato mortale presso l’ufficio postale di Old Rimrock. Dawn, la sua splendida moglie, ex reginetta di bellezza – che nel matrimonio con quest’uomo magnifico sembrava aver appagato ogni aspirazione –, non regge allo sconforto e rimane vittima di un terribile esaurimento nervoso che la allontana progressivamente dal marito. Una famiglia meravigliosa va in pezzi, mentre sullo sfondo scorrono le drammatiche vicende della guerra in Vietnam, gli scontri razziali di Newark della fine degli anni sessanta, lo scandalo Watergate:«E allora chi riesce ad adattarsi? Ecco un uomo che non è stato programmato per avere sfortuna, e ancora meno per l’impossibile. Ma chi è pronto ad affrontare l’impossibile che sta per verificarsi? Chi è pronto ad affrontare la tragedia e l’imprevedibilità del dolore? Nessuno. La tragedia dell’uomo impreparato alla tragedia: cioè la tragedia di tutti».
L’uomo, posto di fronte alle conseguenze dell’imprevedibile, finisce per soggiacere di fronte agli eventi che non riesce a dominare. La sua precaria illusione di equilibrio –basata sulla formula semplicistica del sogno americano, che irretisce milioni di coscienze con la regola ingannevole «impegnati e riuscirai» – viene smentita dalla brutale efferatezza della storia: «La figlia che lo sbalza dalla tanto desiderata pastorale americana e lo proietta in tutto ciò che è la sua antitesi e il suo nemico, nel furore, nella violenza e nella disperazione della contropastorale: nell’innata rabbia cieca dell’America».
Il pregio principale dell’opera non consiste nella costruzione di un personaggio straordinario come lo Svedese, e nemmeno nelle vicende che conducono al crollo monumentale di un uomo così solido e strutturato. La trama del romanzo non acquisisce significato man mano che gli accadimenti ne svelano l’intreccio complesso e imprevedibile; al contrario, l’inaspettato dipanarsi degli eventi suggerisce una drammatica e inesorabile perdita del senso. Non è il romanzo della pastorale, ma quello della contropastorale.
La difficoltà di accedere a una comprensione autentica degli intricati grovigli dell’esistenza emerge anche in uno dei libri più recenti e più riusciti di Philip Roth: Indignazione. In quest’opera, Marcus Messner racconta le vicissitudini che lo hanno condotto a morire nella guerra di Corea all’età di soli diciannove anni. All’autore non interessa mantenere la suspense sull’esito tragico della storia (la fine della vicenda viene rivelata al lettore sin dalle pagine iniziali del romanzo), quanto analizzare le conseguenze dell’imponderabile nel destino dell’uomo.
Ci troviamo all’inizio degli anni cinquanta, l’America non ha ancora conquistato la libertà sessuale che otterrà solamente nel decennio successivo, e le norme morali che regolano i rapporti tra i due sessi sono rigidamente definite. Il massimo che un ragazzo può sperare di ottenere a un primo appuntamento è un petting assai moderato: nel migliore dei casi, guardare o toccare un seno nudo. In questo contesto, Marcus Messner esce una sera a cena con Olivia Hutton, una seducente compagna di corso conosciuta alle lezioni di storia. Dopo mangiato, i due si appartano in macchina vicino al cimitero, e la ragazza, senza nessuna sollecitazione esplicita, al culmine delle loro effusioni gli pratica una fellatio. Marcus rimane esterrefatto di fronte a una simile audacia, e invece di rallegrarsene, inizia a tormentarsi per tentare di comprenderne le motivazioni. Alla fine si convince che un atto del genere poteva essere causato solamente da un’anormalità, e l’unica spiegazione che riesce a darsi è che Olivia lo abbia fatto perché i suoi genitori erano divorziati.
Si tratta di uno snodo fondamentale del romanzo. Mentre Marcus si trova sotto morfina, in uno stato di sospensione tra la vita e la morte, egli rivà col pensiero a quegli eventi, rimanendo invischiato nella loro limacciosa incomprensibilità. È una delle rare pagine in cui Roth si abbandona a divagazioni sull’esistenza ultraterrena. Dopo la morte, l’uomo è condannato a rivedere in eterno il proprio passato, nel tentativo vano di comprendere quanto non ha capito durante la vita. Anziché liberarlo dalle oziose pastoie dell’ermeneutica, sembra che la morte ce lo sprofondi in maniera definitiva: «Anche adesso, oltre l’esistenza corporea, ora che qui io vivo come sola memoria, continuo a interrogarmi sulle azioni di Olivia. È a questo che serve l’eternità, a sguazzare nel pantano e nelle minuzie di una vita?… Se voi mi chiedete come ciò possa essere – memoria su memoria, nient’altro che memoria – io ovviamente non so rispondere, e non perché non esistano “io” e “voi”, non più di quanto esistano “qui” e “ora”, ma perché l’unica cosa che esiste è il passato ricordato, non ritrovato e – attenzione alla differenza – non rivissuto nell’immediatezza del regno sensoriale, ma semplicemente ritrasmesso».
Il termine utilizzato nella traduzione italiana, «ritrasmesso», probabilmente non lascia bene intendere il senso di quest’ultima affermazione. Nel testo inglese troviamo la parola «replayed», ovvero «visualizzato nuovamente», come in una sequenza cinematografica riprodotta all’infinito. L’immagine di Marcus condannato per l’eternità ad assistere passivamente alle azioni di Olivia, senza nemmeno avere la possibilità di riviverle «nell’immediatezza del regno sensoriale», è un contrappasso degno di un Alighieri particolarmente in vena.
I sensi, questi antichi e preziosi custodi dell’inadeguatezza, costituiscono l’unica possibilità di scardinare le rigide strutture razionalistiche nelle quali Marcus è rimasto intrappolato e per compiere quello strappo definitivo dalle proprie radici che gli consenta di incamminarsi finalmente lungo la strada aperta del cambiamento e della novità. L’erezione di barricate metafisiche che impediscono un’appagante pienezza sensoriale costituisce un’anomalia simile a quella di un romanziere che rinuncia a inseguire la «cosa vera» per aderire a uno schema narrativo troppo rigido. La pretesa di ricondurre a delle coordinate stabili di riferimento tutto ciò che sfugge a una comprensione razionale rischia di compromettere non solo la riuscita di un’opera letteraria, ma il senso di una vita intera. La verità non si misura in relazione a modelli predefiniti, ma sulla base di paradigmi inquieti e in continua trasformazione, e non essere in grado di comprendere le enormi potenzialità insite nel cambiamento ha delle conseguenze drammatiche che non possono essere ignorate.
Se Marcus Messner non è capace di godersi un pompino perché esula dagli schemi ordinari della mentalità dell’epoca, allora merita di rivedere Olivia Hutton china sul suo uccello per l’eternità, senza potersela spassare nemmeno per un minuto.