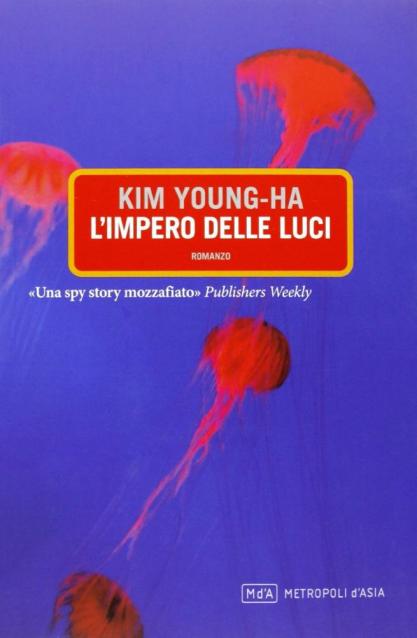L’impero delle luci (Traduzione di Andrea Benedittis, Metropoli d’Asia) è opera di uno dei più importanti scrittori sudcoreani, Kim Young-ha, ancora giovane (è nato nel 1968), le cui opere sono tradotte in tutto il mondo (da noi i racconti Cosa ci fa un morto nell’ascensore?, Trad.di Imsuk Jung , O barra O Edizioni) e “hanno ispirato film e serie televisive di notevole successo” (cito dal risvolto). Si presenta come una spy story ma ha l’ambizione, in buona parte riuscita, di essere molto di più: una riflessione sui rapporti tra le due Coree e sui relativi modelli di vita, anche il discorso è prevalentemente rivolto ai cambiamenti che il Sud ha vissuto negli ultimi decenni.
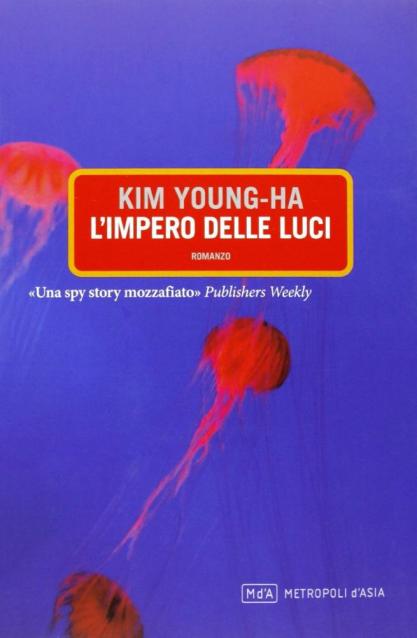
Niente di nuovo, per chi ha ormai acquisito la pretesa di thriller e gialli e compagnia bella di proporsi come formato privilegiato, se non esclusivo, di analisi della cosiddetta realtà (manifesta e soprattutto occulta, ovvio); con la differenza che qui la struttura e le tecniche di un romanzo di genere ben condotto, con radici peraltro in testi più nobili, e sguardo dettagliato su alcuni aspetti macroscopici della società della penisola coreana si motivano reciprocamente, a parte alcune sbavature nella gestione della narrazione e delle informazioni relative al passato dei protagonisti da parte di un narratore il cui statuto è a volte incerto, anche se in genere funzionale agli effetti della suspense (cosa che però a mio parere non basta: il rischio è che tali effetti decadano a trucchi risaputi), che si aggiungono ad altre, più strutturali, che nascono proprio dal desiderio di dire un po’ tutto a dispetto dell’equilibrio narrativo.
Desiderio peraltro benvenuto, per chi come me ignora quasi tutto di quei paesi e non fa certo lo schizzinoso se notizie e strumenti di comprensione che possano aiutare a conoscerli provengono da una spystory, specie se di livello come questa, invece che per le tradizionali vie ideologiche o mediante un’informazione stereotipa e sommaria.
Del resto, sia detto per inciso, la tenuta strutturale (la coerenza, le motivazioni di certe scene e azioni, la distribuzione misurata di ruoli e funzioni…), almeno secondo i nostri criteri che legano verisimiglianza e equilibrio a un certo rigore compositivo (per non dire a una certa rigidità, salvo poi l’allegro sbragamento di tutto il resto una volta salva questa forma di apparenza), mi sembra che non sia poi così fondamentale né per questo scrittore coreano, né per altri scrittori orientali che mi è capitato di leggere (anche se alcuni giapponesi contemporanei le rispettano con rigore: ma sono quasi tutti autori che hanno studiato in Occidente o ne hanno risentito in modo profondo l’influsso, come lo stesso Young-ha peraltro).
L’azione (come nel’Ulysses di Joyce, che è uno dei padri nobili a cui Young-ha afferma di essersi ispirato per questo libro: ma i prestiti non si fermano qui: i tre personaggi, la condizione di “esiliato” del protagonista – rappresentante della folta schiera di coreani del Nord fuggiti al Sud, numerosi in realtà spie come lui –, la moglie insoddisfatta…) si svolge nell’arco di un solo giorno, dalle 7 alle 7 del giorno successivo, ed è scandita ora per ora.
Il tempo circoscritto ha lo scopo di concentrare l’azione e i vari percorsi che dal passato confluiscono a dare un senso a ciò che accade e ad accrescere la tensione relativa agli eventi e alle decisioni che il protagonista Kim Kiyong, deve prendere prima dell’alba per dare una svolta alla propria vita troncando con il passato prossimo e riallacciandosi a quello remoto, o viceversa tradendo quello originario per continuare il filo della vita che sta vivendo.
Le decisioni principali riguardano solo lui, ma coinvolgono il futuro anche dei membri della sua famiglia, moglie e figlia adolescente, ognuna delle quali è a sua volta impegnata a prenderne altre nella propria sfera vitale, in relativa indipendenza reciproca. Questo porta a estendere i territori da descrivere e di conseguenza il ventaglio delle azioni e delle informazioni (dialoghi, notizie sulla storia e la politica coreana recente, cultura, cinema, letteratura, scuola, mondo del lavoro…) che vengono trasmesse al lettore.

Tutto prende avvio da un’email apparentemente innocua ricevuta da Kiyong, il cui significato e le cui implicazioni vengono rivelate poco alla volta, assieme alle informazioni sul suo passato che si allarga fino a diventare l’unico, insospettabile, orizzonte di comprensione, lineare nelle premesse ma complesso nelle implicazioni che un decorso temporale ricco più di pause che di episodi favorisce.
La premessa è semplice: il protagonista è una spia della Corea del Nord alla quale poco o nulla per moltissimo tempo è stato chiesto e che proprio per questo ha quasi dimenticato di esserlo, nell’illusione di essere stato a sua volta dimenticato dai suoi mandanti, che invece con quella mail cifrata lo richiamano in patria già il mattino successivo, per quali ragioni e con quali scopi non si sa.
È il destino che si fa vivo all’improvviso, cieco, capriccioso, che qui assume la forma occasionale, ma terribile, di un regime la cui logica sfugge anche a coloro che lo hanno fedelmente servito. Forse perché logica non ne ha: se un sembiante di coerenza viene abborracciato, in questi casi avviene, più ancora che nella vita comune, solo a posteriori.
Chiarimenti a posteriori, tecnica dell’effetto ritardato, reticenza, distribuzione misurata delle informazioni comportano la necessità, per il lettore, di rivedere in continuazione non solo le proprie interpretazioni ma di ristrutturare a fondo anche la stessa percezione dei fatti, presentati come “tali e quali” senza mai esserlo, a maggior ragione quando la paranoia diventa metodo. Dico “diventa”, perché a trasformarla in metodo è l’ingresso a piccoli passi nel mondo, e nella dimensione mentale, dello spionaggio man mano che si rivela fondativo, anche se per un coreano le motivazioni di base sono certo (o erano) più solide che per noi: per lui, anzi, l’interpretazione paranoica dovrebbe essere un “dato” naturale e non una visione acquisita o che si impone a un certo punto (della Storia: e qui della trama).
La rivelazione dei vari aspetti del passato dei protagonisti è centellinata in modo da accrescere la tensione, ma insieme anche per dotare retrospettivamente di senso eventi di cui sfugge in prima istanza la ratio (le strategie per verificare se i cassetti della scrivania sono stati aperti), o per disambiguarli, nello stesso gesto con cui si arricchisce e completa il loro senso (la mail) o le relazioni tra i vari personaggi, anche minori, e le loro storie, che affondano in passati differenti e in buona parte ad essi stessi oscuri, dal momento che si reggono su silenzi e menzogne reciproche.
Tutti sembrano chiusi nella propria separatezza: il non poter parlare (perché poi il farlo è certo che peggiora la situazione), il non riuscire a dire, la reticenza, il segreto che ogni personaggio racchiude, acuiscono l’isolamento che l’individualismo esasperato suscitato dai cambiamenti radicali e accelerati della società sudcoreana già favorisce.
La mancanza di rapporti è simile, se non identica, a quella delle due Coree, da pochi decenni divaricate in due direzioni opposte e conflittuali, tenute ancora insieme, oltre che dalla geografia e dalla lunghissima storia comune, proprio dall’attrazione che nell’opposizione conclamata si rifugia, ma in modo sempre più tenue ormai, se è vero che tra le nuove generazioni a desiderare la riunificazione non resta che una minoranza che si va facendo sempre più esigua.
I governi si spiano, ogni tanto si lanciano minacce, ma sembra una sceneggiata tenuta insieme dai rispettivi poteri alla quale le nuove generazioni rischiano di fare l’abitudine e di non prestare più orecchio. Come succede alla fine, alla figlia, che sembra intuire che tra i genitori qualcosa, forse anche di grave, è accaduto, ma insomma, lei di indagare il mondo incomprensibile degli adulti non ha voglia né tempo: ha la sua di vita da vivere, e deve andare a scuola. Certe cose, in fondo forse non sono così rilevanti.