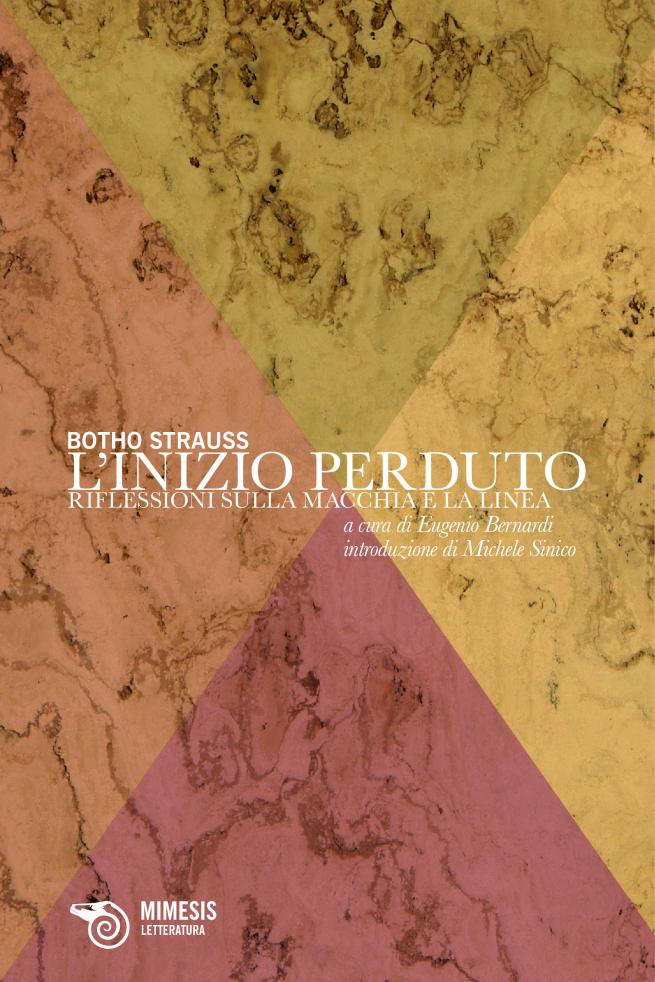Nell’Inizio perduto di Botho Strauß – testo del 1992, da poco tradotto in italiano per i tipi di Mimesis (a cura di Eugenio Bernardi) – le «riflessioni» annunciate nel sottotitolo vertono su un concetto che a una considerazione sommaria potrebbe apparire anodino. «Beginnlosigkeit», letteralmente l’«assenza di inizio», è infatti l’argomento centrale della riflessione straußiana. Titolo «geniale» secondo Eugenio Bernardi, curatore dell’edizione italiana, inseritosi in maniera inattesa nella poliedrica produzione di un autore, classe 1944, noto a livello internazionale soprattutto per le sue virtù di drammaturgo abile a cogliere per mezzo di sagaci strutture dialogiche le tendenze profonde della contemporaneità senza il beneficio della distanza storica.

Osservando da vicino la morfologia del titolo, si ricava immediatamente una tesi – ammesso che di tesi si possa parlare – fortemente assertiva, si direbbe quasi perentoria: non esiste inizio. Vi è, piuttosto, un’ineluttabile assenza di inizio, una carenza radicale di principio, di origine. «Beginnlosigkeit», appunto. Il sostantivo utilizzato – «un vocabolo di invenzione straussiana», sottolinea Bernardi – è tanto ardito linguisticamente quanto preciso concettualmente. È in effetti capace di trasformare il convenzionale concetto di «inizio», inteso come atto o processo, in un predicato o attributo generale dell’esistente, un predicato in absentia, atto a delineare una visione delle cose che rinuncia all’idea che si possa dare – in assoluto – un inizio cronologico e logico di ciò che è.
A supporto di questa posizione, avanzata in maniera recisa sin dal titolo, il testo introduce disinvoltamente il lettore in una selva di considerazioni desunte dalle più accreditate dottrine della cosmologia e dall’astrofisica odierne. Con un esibito penchant per tecnicismi acri e di conio recente o recentissimo, si susseguono annotazioni aforistiche che compendiano (ad uso dei profani?) la «teoria dello stato stazionario» elaborata negli anni Venti da Fred Hoyle in contrapposizione al modello ben più noto del «Big Bang». Nell’«Introduzione» al volume, Michele Sinico chiarisce il punto centrale della questione: la teoria di Hoyle «escludeva» l’idea di un «luogo spaziale e temporale privilegiato, come nel Big Bang, in cui l’universo ebbe inizio». In tale prospettiva l’«inizio dell’universo» appare «perduto»: «l’universo si espande», «eterno e immutabile» (pp. 7-8). Ricorrere alla nozione di «inizio» equivale dunque a una fallacia.
 ph. Oliver Mark
ph. Oliver Mark
Strauß trapianta questo assunto a vocazione cosmica (e cosmologica) nel terreno dell’estetica e dell’esperienza estetica, dunque in uno spazio retto dalla categoria della singolarità. Chiama in causa diversi nomi, da Gottfried Benn a Cesare Pavese, da Josef Albers a Josef Beuys, tutti evidentemente accomunati dalla distanza reciproca. Il testo di Strauß muove da una tacita convinzione, indispensabile per coglierne le dinamiche motrici: a livello di macro e microcosmo vigono le stesse leggi. Un monismo epistemico di antica data e consolidato rodaggio si riaffaccia dunque nel testo straußiano con un lessico aggiornato, calando in un contesto contemporaneo un approccio conoscitivo che cerca nei risultati di accreditate teorie scientifiche la via d’accesso a fenomeni, quali quelli estetici, apparentemente distanti. Con inopportuna approssimazione si potrebbe evocare – per analogia tecnica e strutturale – lo «Zibaldone» leopardiano. Mentre per una maggiore equità si dovrebbero ricordare certi diari di poeti-scienziati del primo Ottocento tedesco, mossi dalla «libido scientiae» e magistrali nella loro manieristica farraginosità (sia lecito pensare a Novalis o, prediligendo la finzione, a Faust).
Per capire in che modo Strauß trasformi la ricerca del principio ultimo e originario in un alternativo programma estetico basti questo esempio: «Si cerca l’interazione unitaria, l’unità della natura. La gravità in primo luogo, poi l’energia nucleare forte, milioni di milioni più forte della gravità. […] Ma qual è l’energia unica, quella che viene prima ed è insita nelle quattro energie elementari? Ebbene, dicono certuni, se c’è un elemento primo e unico, si dovrà pur arrivare a scoprirlo. L’inizio del mondo che è nascosto dentro il mondo stesso e che fino ad oggi nessuno è riuscito a scoprire. […] Altri contestano che si giunga a tanto e si arrivi a possedere in una formula l’elemento primo e unico. […] Se però contro ogni aspettativa si arrivasse a cogliere l’unità della natura, allora, dopo quest’ultimo e supremo atto conoscitivo, dovrebbe iniziare un grande rallentamento, un afflosciarsi dell’attività della mente: quell’elemento primo e unico prenderebbe possesso di noi e fonderebbe tutto in un’unità» (pp. 43-44).
Contro l’unità, l’uno e l’unicità; a favore di una dispersione proliferante – le coordinate ideologiche che orientano il discorso straußiano sono palesi ad ogni sua pagina. Le conseguenze riguardano anzitutto la strutturazione concreta del testo: impensabile una diegesi lineare: se non vi è inizio, le storie non hanno inizio; non vi sono storie dell’inizio; non vi sono storie dell’origine; non vi sono storie originali. Solo rielaborazioni, adattamenti, un continuo rimestare. Contro la valorizzazione romantica della creazione originale e del genio creativo, già Walter Benjamin scriveva nel saggio «Il narratore» che l’«arte di narrare storie è sempre quella di saperle rinarrare ad altri». Ma su questo aperçu Strauß stende un’ombra scura: l’arte deriva solo da altra arte; le storie nascono solo da altre storie. La differenza del «nuovo» non è una categoria da prendere in considerazione. Più coerente, invece, sarà proporre un’espansione di eterogenei materiali montati a collage, in stereofonia.
Così si mostra infatti il testo dell’Inizio perduto: come un vasto organismo che vive di frammenti di pensiero e brandelli di racconto separati da uno spazio bianco che, come nota Bernardi, «non è sempre facile da attraversare» perché chi legge «non è rassicurato da un racconto che lo prenda e lo seduca»; quel bianco «può essere una trappola, offrire pensieri da proseguire per conto proprio, o non significare nulla, solo un’incertezza o la perplessità dello stesso autore» (p. 136 sg.).
Nella dimensione inarticolata del bianco si affaccia, a sorpresa, una terza persona (al maschile) che solo a stento può inseguire un suo percorso di creatività. Essa si fa largo tra una desolata molteplicità di citazioni, echi, ecfrasi e descrizioni scientifiche che impongono talvolta reazioni di rigetto. Eppure, in questo sforzo, tale soggettività offre al lettore notevoli pezzi di bravura, come con il «tramonto» finale, in cui gli attributi cromatici si svincolano dalle forme ben delineate del paesaggio e nella loro purezza di «macchie» assumono valore autonomo: «Nel grigio del cielo che stava impallidendo si scorgeva la lunga risacca, piccole increspature di onde, le stesse che l’acqua scava nella fanghiglia e che il vento getta sulla sabbia, tenui, morbide e smorzate e con marezzature delicate e informi che si fondevano una nell’altra come fossero creme colorate, di un colore azzurro pallido e turchese argenteo» (pp. 131-2).

Cosa resta dell’opera d’arte, del suo «fondamento», se inizio non c’è, se può darsi solo ri-elaborazione? La risposta del testo di Strauß muove in direzione del «conflitto». Un conflitto, definito a più riprese «lotta», tra la memoria dell’ovvio e del vieto, da un lato, e le possibilità dell’inarticolato, dall’altro; una lotta tra lo stereotipo e l’informe, tra la «linea» e la «macchia». Della figura in terza persona che punteggia il testo si legge infatti: «Si ribellava contro ogni abbozzo che di colpo gli si presentava come qualcosa che già conosceva, qualcosa a cui era preparato e per cui aveva già pronto il modo di inquadrarlo; quello che voleva era il TESTO prima della scrittura, il messaggio prima del codice, la macchia prima della linea, quello che desiderava era un modo di comprendere le cose che scivolasse via all’infinito e sulle cui onde la mente potesse lasciarsi andare senza meta e senza dover trarre delle conclusioni, senza figurazioni premature, quello che desiderava erano frasi che diffondessero un’eco, un alone, frasi che immediatamente precipitassero a vicenda nell’oblio» (p. 25).
Ciò che per Lord Chandos, il crucciato protagonista della celebre Lettera di Hofmannsthal, appariva come la più terribile delle maledizioni, ritorna qui come meta del desiderio. In questa poetica, la verticalità lineare di «conclusioni» e «figurazioni» ben articolate non può che risultare spregevole rispetto all’orizzontalità disinibita e irriflessa di un’«eco» effimera o alla melodia di un’onda in espansione che scivola via «all’infinito».