A questo punto il lettore, assecondato dalla forza realistica della scena descritta in una delle pagine iniziali del romanzo, sente le risate di scherno degli aggressori elettrizzati e vede persino gli stracci che avvolgono le bottiglie di benzina che useranno poco dopo, quando usciranno dall’edificio. Le vittime, tutti stranieri, cercano un nascondiglio nella penombra, si riparano dalle botte sotto le coperte scozzesi, accovacciate negli angoli delle stanze, vicino alle brande.
Forse, continuando a fare congetture, perché il lettore è agevolato dalla dura vividezza della prosa dell’autore che ha molto mestiere, c’è chi prova a mettersi in un armadietto di quelli in dotazione ma è troppo stretto, ci sta solo un bambino lì dentro, che infatti ci si è appena infilato. Allora di corsa verso i bagni, dove è possibile accucciarsi sui water, come nei film, con le gambe sollevate per non essere traditi dalla fessura tra il pavimento e la porta. Lì i picchiatori non avranno il tempo di arrivare, qualcuno magari ha già chiamato aiuto, ma non è detto, perché la struttura è fuori dal centro abitato.
Intanto ecco il lancio della prima bottiglia, che passa da un lucernario e atterra sul materasso di un’anziana. Le divora la gamba in pochi secondi. Se si sente l’odore della carne che brucia, si va istintivamente verso l’uscita, ma la corsa è inutile perché la maniglia è stata bloccata dall’esterno con una catena.
Una cosa è certa: chi, da lontano, ha assistito alla scena, non testimonierà, per paura, per menefreghismo o perché, in fondo, se la sono andata a cercare: che tornino da dove sono venuti e che ci lascino in pace, tanto qui non c’è lavoro!
In quale parte del mondo sia ambientata la vicenda appena descritta è ancora troppo presto per specificarlo. I lettori un po’ più in malafede, quelli che non si accontentano delle panzane esterofobe, se non esplicitamente razziste, che intercettano alla fermata dell’autobus o dal fruttivendolo, potrebbero nutrire il forte sospetto che sia successo nell’Italia delle recenti spedizioni punitive, delle aggressioni istigate dall’odio razziale e dal malessere, della violenza poliziesca, degli sgomberi abitativi che sembrano rastrellamenti e dei respingimenti nel Mediterraneo coordinati con la Libia. Va invece detto, a discolpa di tutti, dal Ministero dell’Interno in giù, fino ad arrivare al vecchio zio repubblichino, che si tratta del Nord America, più precisamente del Messico. Meno male: c’è chi può fare peggio. Sì perché anche lì vanno a caccia di stranieri, anche loro usano il fuoco, li bruciano vivi addirittura, dentro quegli edifici coloniali di pietra destinati alla prima accoglienza. Lo racconta Antonio Ortuño nel suo quarto romanzo, La fila indiana che, dopo Risorse umane (Neri Pozza, 2007), è il secondo a essere tradotto in italiano, con grande perizia, da Silvia Sichel, questa volta per i tipi di SUR.
Ortuño affida la descrizione del blitz punitivo con cui apre il suo romanzo a una voce anonima in terza persona, una delle focalizzazioni che si avvicendano componendo i quarantaquattro brevi capitoli in cui è narrata la storia di Irma.
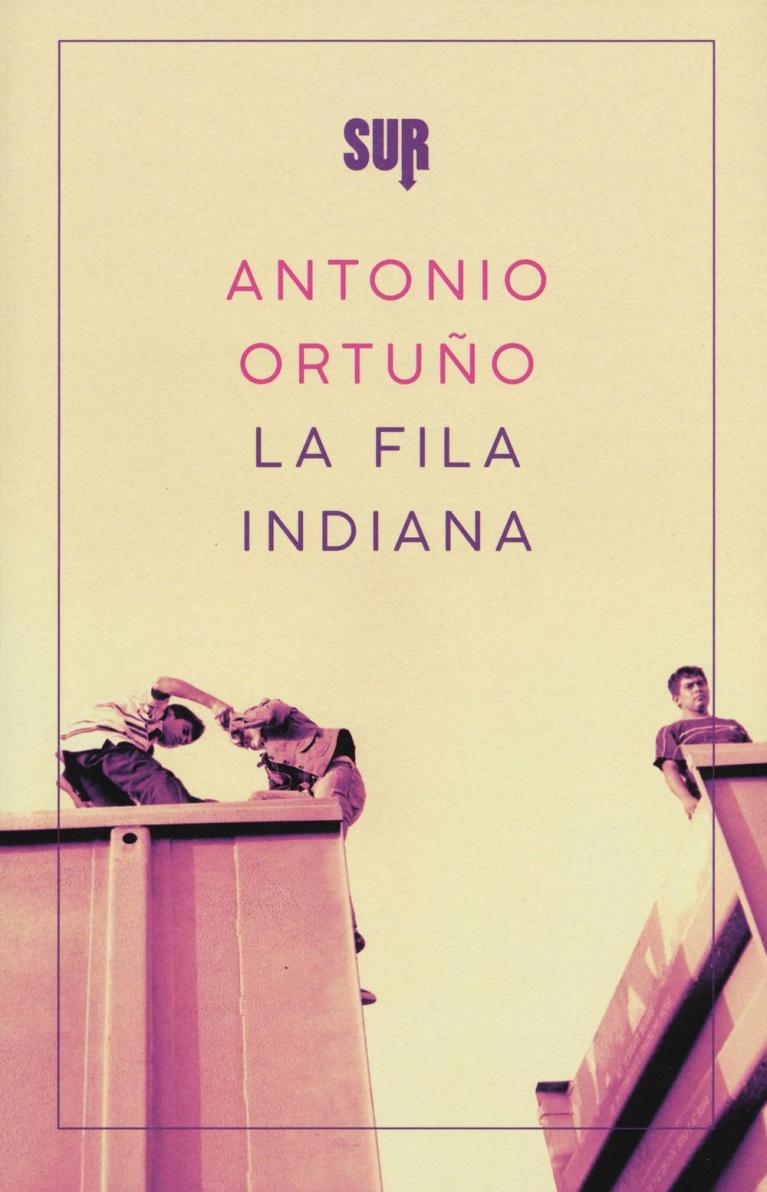
Irma è un’assistente sociale inviata a Santa Rita, nella parte meridionale del Messico, un posto (fittizio) in cui è impossibile ambientarsi:
[…] mi sembrò una città dalla cui mappa avessero cancellato le coordinate indispensabili: non c’erano rotonde, palazzi, università, aree industriali, viali, zone residenziali né centri commerciali; mancava tutto, tranne la piazza centrale, con chiosco, arbusti e panchine e, intorno, venti strade di solide case in muratura e duecento e passa scavi e tettoie di lamiera, abitate da straccioni. (p. 27)
Santa Rita è una di quelle città dolenti della tradizione letteraria messicana in cui non ci si può fidare di nessuno. La protagonista deve gestire la morte di decine di migranti dopo un incendio doloso in una delle strutture della Commissione Nazionale Migrazione, ma è un compito molto pericoloso perché la linea che separa le bande criminali, gli affiliati ai cartelli della droga, i polleros – il corrispettivo terrestre degli scafisti del Mediterraneo, vale a dire chi traffica in migranti senza documenti – e la polizia locale s’incrina a colpi di mazzette o minacce.
Nell’affresco che dipinge la città e i suoi abitanti sono ben visibili gli stessi colori che Roberto Bolaño usò per la rappresentazione di Santa Teresa in 2666, centro metafisico del male universale, luogo immaginario e pur tuttavia visione premonitoria degli orrori del Messico contemporaneo in cui, giornalisticamente parlando, i massacri tolgono visibilità agli omicidi.

Antonio Ortuño.
A Santa Rita si trema senza mai avere freddo, come dovrà constatare suo malgrado Irma. È un luogo in cui le frasi a effetto di Octavio Paz sull’esistenza di una presunta antropologia del messicano contenute ne Il labirinto della solitudine troverebbero senz’altro una collocazione incise sui calci delle pistole.
Come a Comala, il famoso villaggio creato da Juan Rulfo nel suo capolavoro Pedro Páramo, la percezione del confine tra la vita e la morte è mediata da un sistema di regole autonome rispetto a quelle abituali. Tuttavia qui la rappresentazione della morte non ha alcun legame con i miti tradizionali, è sempre violenta e per mano altrui. La Santa Rita di Antonio Ortuño (come la Santa Teresa di Roberto Bolaño) non rimanda a qualche epoca precedente in cui i suoi abitanti stavano meglio. Sembra invece essersi materializzata con l’arrivo del funzionario di turno, dei suoi fedelissimi in fila indiana nella loro scalata sociale fatta di sottomissione e incompetenza, e con l’arrivo dei migranti centroamericani – guatemaltechi, honduregni, salvadoregni – senza documenti che affidano il loro destino alla via ferrata. Si mettono sui carri dei treni merci su cui patiranno ogni genere di sofferenza e di abuso per cercare di raggiungere gli Stati Uniti: “Ovvio che ai polleros [così come ai membri delle maras o ai narcotrafficanti, con la connivenza e il silenzio della polizia locale] non piace che la merce scappi sulle proprie gambe, polli congelati, costate di maiale che vanno in giro per strada. Per cui fanno secchi quelli che riacciuffano e giocano al tiro a segno con i centri delle ONG” (p. 41).
È come partecipare alla lotteria, solo che se si perde non si perde e basta, si muore. Se si vince, le probabilità sono bassissime, quasi paragonabili alle chances di sopravvivenza dentro un lager nazista, in palio c’è la possibilità di ricostruirsi una vita in “Gringolandia”, nomignolo di fantasia usato per indicare la parte centrale dell’America Settentrionale, quella in cui anche se un centroamericano si spennellasse il viso di bianco e arrivasse all’impossibile traguardo di una parlata da bostoniano doc, non sarebbe mai preso per uno di loro, perché “una particolare sfumatura di sporcizia, di disfatta o di scetticismo, lo impedisce” (p. 43).
Tra il Guatemala (ma anche l’Honduras, El Salvador e il Nicaragua) e gli Stati Uniti ci sono “i sette gironi dell’inferno messicano” (p. 73) da attraversare in fila indiana, chinati per nascondersi meglio tra gli arbusti, attenti a non farsi catturare dalla Migra, la polizia di frontiera, o dai delinquenti.
È a quest’ultima evenienza che si deve far fronte fin da subito in Terra bruciata (La Nuova Frontiera, trad. di Natalia Cancellieri). Ciò che colpisce di entrambi i romanzi, La fila indiana di Antonio Ortuño e Terra bruciata di Emiliano Monge, è lo straordinario ritmo con cui le voci narranti scortano il lettore negli abissi infernali di un Messico che ha tutta l’aria di essere un gigantesco tritacarne, un’enorme fossa comune.
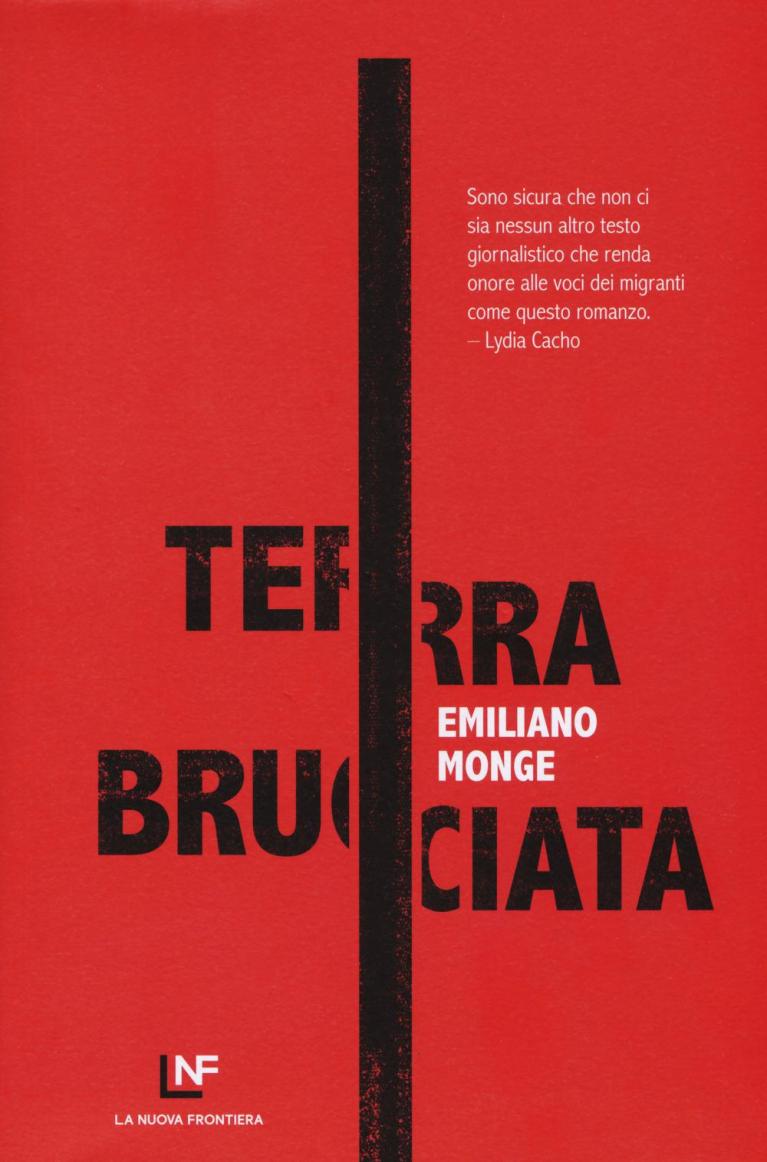
A differenza di Ortuño, con Emiliano Monge non abbiamo il tempo di controllare se abbiamo allacciato le cinture di sicurezza. Le porzioni di monologo interiore disseminate nelle pagine de La fila indiana tracciano esaustivamente le coordinate di una società xenofoba e classista per bocca di un benpensante molto credibile. Le righe delle testimonianze, tutte vere, dei migranti che punteggiano la storia principale di Terra bruciata arrivano invece dal dominio dell’invisibile. È un invisibile completamente umano, fatto delle atrocità sottaciute compiute dai trafficanti di corpi e dagli “sfasciacadaveri”. Sono i professionisti dell’orrore, cui tocca il lavoro sporco delegato da un sistema sociale che riversa la propria rabbia e la propria inadeguatezza sugli ultimi, e sono anche i protagonisti di questo romanzo, tutti orfani. Il loro capo è il parroco che gestisce l’orfanotrofio Il Paradiso, in cui si allevano bambini marchiati e addestrati a compiere crimini di varia natura, che in seguito saranno riammessi nel mondo grazie al grembo prodigo della criminalità organizzata.
Emiliano Monge ha una scrittura ferocemente aliena da qualsiasi enfasi e retorica, il linguaggio non prova a contenere la violenza. Il coro delle voci dei migranti, che Monge a volte alterna ai versi della Divina Commedia, intervalla con la sua drammaticità una prosa asciutta e veloce. Sia la dimensione pubblica, la guerra di tutti contro tutti per detenere il potere nelle sacche d’illegalità di cui si nutre il capitale, sia la dimensione privata, la storia d’amore tra i capibanda Epitaffio e Stele, sono narrate in modo distaccato, sebbene Monge sia tutt’altro che un entomologo: il suo sguardo sulla realtà è sì spietato ma sempre partecipe.
Inoltre, la passione nuda ed elementare dei due capibranco, così come le loro operazioni illecite, non sono soggette ai giudizi della voce narrante, che infatti non ne emette mai. Il romanzo è privo di insegnamenti morali e se il lettore commette l’errore di abbassare la guardia, rischia addirittura di compatirli e di anelare con essi alla loro unione imperitura, nonostante Monge non abbia lasciato nulla che giochi a loro favore: la ragazza non è bella, i messaggini che si inviano sono sgrammaticati e patetici, le scene di sesso non ci sono. Tuttavia al peggio ci si abitua velocemente in luoghi dove le relazioni umane si basano sul disprezzo mutuo.
Terra bruciata, con cui Emiliano Monge ha vinto il Premio “Elena Poniatowska” nel 2016, non è un resoconto cronachistico ma un’opera complessa, sorretta da un lungo lavoro di ricerca sul campo e di documentazione. Il materiale raccolto è stato poi articolato in una struttura narrativa complessa, valorizzata dai continui rimandi letterari e dall’uso di registri diversi grazie ai quali l’autore esplora un ampio spettro linguistico, dalle vette auliche dantesche (di cui viene offerta anche la parodia grottesca nella comunicazione tra i due amanti illetterati) fino ad arrivare alla lingua berciata dei malviventi. A questo proposito, come già segnalato da Francesca Lazzarato (“Amore e demoni nel Messico dei migranti violati”, Alias, 15 ottobre 2017), “nonostante l’eccellente lavoro della traduttrice, nella versione italiana qualcosa si perde, ritmo e suono si alterano o si affievoliscono”: forse si sarebbe potuto osare di più, ferma restando la qualità del lavoro svolto.
Nella terra bruciata messicana nessuno ha un nome, i migranti spesso sono identificati in base al tipo di violenza subita, come se dovessero sempre salire di livello, via via verso la perdita totale della propria identità, in un percorso di formazione che porta alla conoscenza di tutte le gradazioni del male senza però raggiungere l’acquisizione del Bene Supremo, la visione dantesca di Dio. L’oltretomba in questo caso è un “abisso circolare”, come lo chiamerà Stele a pagina 309, completamente terreno, in cui non c’è esperienza di liberazione dal peccato perché non c’è nulla verso cui tendere.
I criminali hanno tutti un soprannome che è legato al campo semantico del rito funebre – oltre a Epitaffio e Stele, anche Padre Loculo, Funerale, Cimitera, Ossaria – ma gli stessi a volte sono ribattezzati dalla voce narrante in base ai sentimenti provati o a un’azione appena compiuta: Sentosolociòchevoglio, ColeicheadoraEpitaffio, ColuicheamatantoStele, ColeichecredeancorainDio. Un espediente efficace, per due motivi. Il primo riguarda il piano narrativo: si marcano i contorni di una prosa che è tutta azione. Il secondo riguarda invece la concezione del soggetto che emerge dal romanzo: un’interiorità diversa o complementare alle nostre azioni non esiste. Si è ciò che si fa, senza alternativa, come in questo passaggio, particolarmente duro e rappresentativo:
«Quindi abbiamo ampliato il nostro giro… oltre a smontare macchine oggi smembriamo corpi» spiega ridendo ancora più forte Canuto. «O ti adegui o lo fa qualcun altro e ti fotte i clienti.»
«Comunque… non abbiamo rinunciato al passato» avverte Tinto smettendo improvvisamente di ridere: «Insomma, non abbiamo abbandonato quello che facevamo prima… oggi la carne è importante quanto la lamiera.» (p. 230)
Se esistesse una verità interiore di certo non potrebbe giustificare certe azioni, anzi, Monge sembra suggerire che un’operazione di questo tipo, il disvelamento della soggettività dei personaggi, non gli interessa: la verità è tutta fuori, non dentro. Di una qualsiasi autenticità intima non se ne farebbe nulla, la verità non è lì: oltre la violenza esercitata sui corpi inermi non c’è nulla, o meglio, ci sono le menzogne che ci raccontiamo quotidianamente per essere in grado di vivere immersi nella miseria di cui facciamo parte.

