In uno dei suoi ultimi racconti, The Crack-Up, Francis Scott Fitzgerald fa un’affermazione, destinata a incontrare, nel tempo, una grande fortuna, finendo per risultare tra le cose più note e citate dello scrittore americano. «Il segno di un’intelligenza di prim’ordine – scrive Fitzgerald – è la capacità di fissarsi su due idee contraddittorie senza però perdere la possibilità di funzionare».
Un’affermazione che mi è sempre parsa capace di fissare la condizione minima per ogni pensiero che desideri misurarsi, in qualche modo, con il peso della contraddizione – lavorarci dentro, lavorare con essa, lavorarla.
Porsi in un confronto serrato con la contraddizione vuol dire, innanzitutto, avere la capacità di individuarla, circoscrivere luoghi e tempi della sua maturazione, modalità e conseguenze del suo dispiegamento. Il che significa, per prima cosa, impegnarsi, «attraverso una dura fatica, un lavoro continuo» (E. Fachinelli, Su Freud, a cura di L. Boni, Adelphi, Milano 2012, p. 42) nell’interrogazione di tutta una serie di opposizioni sbrigativamente confinate nella forma deterministicamente cristallizzata di un dualismo che rende impossibile, o improduttiva, una qualsiasi loro ulteriore presa in esame. Solo un’analisi di questo tipo, infatti, consente di creare “nessi”, di tratteggiare uno spazio di confronto tra due elementi rigidamente distribuiti l’uno di fronte all’altro senza possibilità di dialogo, di prendere il dualismo “alla radice”. Vale a dire scoprendo e interrogando la contraddizione su cui esso si fonda, nella convinzione che un suo «superamento è possibile solo attraverso il reperimento e la definizione di un campo pratico-teorico, di un luogo specifico della realtà umana, irriducibile a ciascuno dei termini della coppia» (p. 42).
Mi sembra che l’esperienza della rivista L’erba voglio – della quale è stata recentemente riedita per DeriveApprodi un’antologia a cura di Lea Melandri (originariamente pubblicata per l’editore Baldini&Castoldi nel 1998), dal titolo Il desiderio dissidente. Antologia della rivista «L’erba voglio» (1971-1977) –, «coi suoi 28 numeri bimestrali, dal 71 al 77» (p. 10), abbia provato a esercitare sul reale una pressione di questo tipo e costituisca, pertanto, un ottimo esempio di quello che, prendendo in prestito un’espressione di Alenka Zupančič, definirei un «pensiero che avanza come pensiero della contraddizione» (A. Zupančič, Che cosa È il sesso?, tr. it. di P. Bianchi, Ponte alle Grazie, Milano 2018, p. 187).
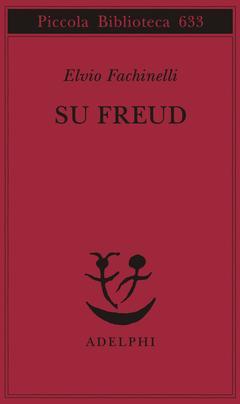

Nel laboratorio teorico-politico che tale rivista ha rappresentato, infatti, quest’ultima è interrogata di continuo, mediante un preciso sguardo topologico sulla realtà, in grado di produrre un’analisi il più possibile accurata delle sue strutture al fine di rilevare, al loro interno, quanto, avrebbe detto Lacan, non cessa di non scriversi – i punti di frattura, le insofferenze, i sintomi –, nella convinzione che «sono gli inceppi del quotidiano […] a offrire una sponda di resistenza» (p. 17), a rendere visibili tutta una serie di soggetti “invisibili”, che agiscono all’interno di tali strutture nella forma dell’“inesistenza”, ma anche tutte quelle «energie umane che, confinate dentro i margini di una soggettività ritenuta trascurabile, non hanno mai smesso di costituire, per le istituzioni del vivere sociale, un alimento e una minaccia» (Ibid.).
Tale tendenza, che trova espressioni multiformi ed eterogenee nei differenti lavori apparsi, lungo gli anni, sulla rivista, è immediatamente comprensibile anche solo gettando uno sguardo sui titoli di almeno due delle cinque sezioni di cui l’antologia si compone. Essa si apre con una sezione intitolata Contrappunto, un «termine musicale [con cui] si intende designare un elemento essenziale del lavoro della rivista», ossia «la non subordinazione dei diversi linguaggi incontrati nella realtà […] a un momento centrale, predominante […]» (p. 29) e si chiude con una sezione intitolata Il detto e il non-detto dove trova posto «ciò di cui non si parla abitualmente – la vecchiaia, la follia, la morte – e ciò di cui, per varie ragioni, non si può parlare e che parla allora in altri modi» (p. 213), rivelando «la cornice sottesa a tutta l’esperienza di “L’erba voglio”» (p. 23).
Nei materiali raccolti nelle restanti tre sezioni – Chi siamo, La vispa e il focoso e L’occhio storto – tale condotta viene ulteriormente specificata. In quella più ampia, La vispa e il focoso, trovano posto una serie di lavori che testimoniano la centralità che il femminismo e i suoi interrogativi, «visti, rispetto alle tematiche non autoritarie, come il segno di una radicalizzazione nuova e imprevista» (p. 21), hanno progressivamente assunto all’interno della rivista. Nelle sezioni restanti, più brevi, sono proposti materiali che definiscono i contorni dell’identità di L’erba voglio, di quel “noi” da cui, secondo il noto adagio femminista, qualsiasi pratica politica che si voglia radicale deve partire (Chi siamo), e la sua propensione a non chiudersi dentro i propri schemi, ma a conservare «un occhio anche di fuori, di lato, sotto il tavolo delle discussioni e dei dibattiti» (p. 203), grazie al lavoro dei molti corrispondenti (L’occhio storto).
Tra i vari dualismi all’interno dei quali la contraddizione è interrogata, ce n’è uno che sembrerebbe rivestire una funzione fondamentale (da intendere in senso etimologico), senza che ciò significhi che possegga una qualche priorità d’indagine rispetto agli altri, quanto piuttosto che ne descriva la cornice trascendentale, che agisca come “prisma pratico-riflessivo”, per dirla con Foucault, a partire dai quali tutte le altre contraddizioni prendono corpo e possono trovare una loro specifica declinazione: quello tra «ciò che sarebbe politico e ciò che non sarebbe politico» (p. 35).
Una discriminazione che si fonda sua una precisa definizione di cosa è politico e cosa non lo è e che possiede, a opinione di chi scrive, una specifica origine storica riconducibile alla diffusione di un particolare dispositivo epistemico-politico, quello moderno, che ha nei concetti di sovranità e rappresentanza – i vettori mediante cui tale discriminazione viene fatta agire – il proprio baricentro. Ma anche una discriminazione che non è venuta meno (e tende a non venir meno), anzi si è riproposta, perfino all’interno di tutta una serie di esperienze politiche rivoluzionarie, generalmente d’ispirazione marxista, che proprio verso tale dispositivo epistemico-politico avevano rivolto la loro attenta disamina critica.
Ne sono derivate, da un lato, la progressiva delimitazione di un teatro dell’agire politico da cui sono escluse le ragioni più elementari del comportamento individuale e collettivo» (sogni, fantasie, “resti notturni” «che penetrano costantemente nella vita vigile, considerati “scarto” o “residuo irrazionale” da tenere a bada» (p. 10)), dall’altro l’allineamento a una «militanza politica [che] somiglia spesso a una specialità di mutilati volontari», dove parrebbe si sia costretti a «mutilarsi delle molte ragioni particolari del proprio fare politica» (p. 37).

L’interrogazione di tale dualismo, consci del fatto che «non basta trovarsi d’accordo sulla generica affermazione “tutto è politica” per pensare che non esista una discriminante» (p. 35), mi sembra costituire l’architrave su cui si è sviluppato il complesso edificio concettuale diramatosi attorno all’esperienza di L’erba voglio. Interrogare tale dualismo ha significato, infatti, concentrare l’attenzione su «tutte le condizioni materiali del vivere, prima fra tutte quella che la storia aveva cercato di dimenticare: il corpo, la sessualità, la vita affettiva, la storia particolare di ogni individuo» (p. 12), senza cedere alla tentazione di pensare che questo “altro luogo” dimenticato rappresentasse «quello in cui si affaccia la figura della nostra umanità piena e felice» (p. 182).
Questo “altro”, una volta reso visibile, una volta chiamato con il suo nome, doveva, al contrario, essere interrogato a sua volta nelle contraddizioni da cui era attraversato.
È all’interno di questo complesso reticolo di scandagli – delle esperienze e delle pratiche che essi, a loro volta, pongono in essere – che emerge la peculiarità di un’esperienza come quella di L’erba voglio, che di tali tentativi di sovversione (da intendere, ancora una volta, in senso etimologico – subvĕrtere: capovolgere, rovesciare, mandar sopra quello che era sotto) della realtà rappresentava una sorta di megafono e coordinamento orizzontale.
L’antologia di Il desiderio dissidente ha certamente il merito di fornire una cartografia per quanto possibile completa del vasto panorama di tali interrogazioni.
Gli articoli di Giovanni Losi, Mario Casari e Paolo Gambazzi propongono delle incursioni nelle contraddizioni vive concernenti la sfera del lavoro, che riescono a inquadrare bene le metamorfosi di un governo della forza lavoro che permane disciplinare e fordista (Viaggio attraverso la catena di montaggio e Il rumore del tempo di lavoro) e, al contempo, si apre a modelli di razionalità neoliberale e post-fordista fondati sull’(auto)controllo e la (libera) messa in gioco di se stessi in quanto capitale umano (L’uomo Ibm). L’articolo di Antonio Prete (La disciplina dei corpi) prende in esame la scuola come luogo di esercizio di una specifica azione di disciplinamento dei corpi, dando spazio a una delle indagini – quella riguardante la scuola come spazio d’intervento politico – più presenti all’interno della rivista, nonché filo conduttore del volume, a cura di Elvio Fachinelli, Luisa Muraro Vaiani e Giuseppe Sartori, L’erba voglio. Pratica non autoritaria della scuola (che esce per Einaudi nel 1971 e raggiunge le 5 ristampe in pochi mesi), depositato di due convegni milanesi dedicati a “Esperienze non autoritarie nella scuola”, all’interno del quale la storia della rivista trova le sue radici.
Nello scambio tra Liliana De Venuto e Lea Melandri e nell’articolo di Antonella Nappi sono affrontate, con sguardo innovativo, questioni concernenti la sessualità e il corpo, mentre in quello tra Nadia Garattoni e Giuseppe Leonelli e nell’articolo di Sandro Ricci sono interrogate le contraddizioni che attraversano lo “sguardo medico” tramite, rispettivamente, le considerazioni di un medico a partire dalla sua esperienza della «situazione degli anziani» (p. 217) e di quelle di un collaboratore della rivista – morto suicida a 31 anni – recluso in un reparto psichiatrico in seguito a un primo tentativo di suicidio, sventato. In un lungo intervento, scandito in tre puntate, intitolato Il deserto e le fortezze (successivamente ripubblicato, nella sua interezza, nel 1973, all’interno della raccolta Il bambino dalle uova d’oro, con il titolo “Il paradosso della ripetizione”), poi, Elvio Fachinelli (una delle figure più note dell’entourage della rivista) prende in esame con straordinaria acutezza tanto le contraddizioni rispetto alle quali la proposta freudiana di una “scienza dell’individuo” dovrebbe costituire un superamento, quanto quelle interne a tale proposta e alle istituzioni psicoanalitiche, l’analisi delle quali si protrarrà, in modo originalissimo, all’interno della riflessione dello psicoanalista italiano, fino alla sua morte.
Negli articoli raccolti all’interno della sezione intitolata La vispa e il giocoso, infine, come si è anticipato, una serie di contraddizioni concernenti il genere, la sessualità, il corpo, l’inconscio, la psicoanalisi e, più ampiamente, anche la contraddizione “originaria” politico/impolitico sono trattati da un punto di vista femminista con tutta la radicalità sovversiva di cui questo tipo di discorso si è fatto portatore (e che, in un presente a noi più contemporaneo, sembra si torni a respirare all’interno di un movimento come Non Una Di Meno che di questo discorso sembra avere ereditato, tra le altre cose, tutta la potenza innovatrice).
Una serie di interrogazioni che, nella loro specificità, condividevano l’appartenenza a una medesima logica. Una logica – elemento di per sé già molto rilevante – «che non aveva più il suo centro nel “bisogno”» (p. 12), una logica «diversa da quella dei pretesi movimenti rivoluzionari» (E. Fachinelli, Il bambino dalle uova d’oro, Adelphi, Milano 2010, p. 181), che Elvio Fachinelli, in un articolo di una straordinaria lucidità, ha definito “desiderio dissidente”.
«Il desiderio dissidente – ha dichiarato lo psicoanalista italiano in un’intervista nel 1988 – era una manifestazione veramente rivoluzionaria […]. Ma proprio perché era così rivoluzionario finiva per porsi addirittura in un’altra logica» (E. Fachinelli, Al cuore delle cose. Scritti politici (1967-1989), a cura di D. Borso, DeriveApprodi, Roma 2016, p. 38).
Il movimento degli studenti, e la successiva ondata degli operai, nel 1968 avevano richiesto, per essere compresi nella loro peculiarità, l’elaborazione di una nuova logica, rendendo in tal modo operativo uno strumentario che consentisse di elaborare «un sapere inquietante, e sapere dell’inquietante (das Unheimliche), come fu quello di Freud, rispetto alla coscienza della società occidentale del suo tempo; un sapere che, come quello, [fosse in grado di scoprire e dire] l’inquietante in ciò che in apparenza ci è più familiare e consueto» (E. Fachinelli, Il bambino dalle uova d’oro, cit., p. 12) e, al contempo, di cominciare a pensare quell’“alternativa” ai processi di settarizzazione, che in uno scritto intitolato Gruppo aperto o gruppo chiuso? sempre Fachinelli, aveva denominato “processo di accomunamento”, definendolo una soluzione «non irreale, ma certamente rara» (Ivi, p. 176).
La conclusione dello scritto parrebbe riconfermare fino a che punto lo psicoanalista italiano fosse conscio delle difficoltà che a tale “alternativa” potevano opporsi. «Il regime del desiderio, sorto dal lungo dominio del bisogno – scrive Fachinelli – si è dimostrato reale e intransigente, ma transitorio. La rivoluzione non è stata vittoriosa – e qualcuno potrebbe sostenere […] che nessuna rivoluzione è mai vittoriosa, perché è troppo forte la spinta dei bisogni da cui nasce e a cui viene inevitabilmente ricondotta». Ricattura all’interno di gruppi settari e di bisogno e «dissoluzione a breve scadenza», sulla spinta dell’«idealizzazione che è all’opera, con la continua minaccia di veder sorgere all’orizzonte, e poi dentro di sé quel negativo che [si] intendeva eliminare» (p. 74), sembrano minacciare, da due lati differenti, la possibilità reale del darsi di un’alternativa. Tuttavia, appena dopo, lo psicoanalista italiano chiosa: «Ma si dovrebbe però aggiungere, nello stesso tempo, che la rivoluzione, come il desiderio, è inevitabile, e non finirà mai di sconvolgere i custodi del terreno dei bisogni» (E. Fachinelli, Il bambino dalle uova d’oro, cit., p. 183).
Ancora una contraddizione.
Probabilmente la più radicale.
Si potrebbe dire che, in un certo senso, in tale contraddizione l’esperienza di L’erba voglio ha fatto qualcosa di più che riporre una speranza; a partire da essa ha cercato di mettere in pratica un agire. Un agire che fosse in grado di spezzare «la separazione tra sogno (impossibile) e realtà (più che possibile)» (p. 34), di affermare che “l’impossibile esiste”, per dirla con Badiou, e dimostrare che esso, per dirla con Basaglia, può diventare possibile. Generare un nuovo e diverso possibile.
Il segno di un’intelligenza di prim’ordine, abbiamo visto, è la capacità di fissarsi su due idee contraddittorie senza però perdere la possibilità di funzionare. Subito dopo, Fitzgerald aggiunge: «Si dovrebbe poter capire, ad esempio, che le cose sono senza speranza, eppure essere decisi a cambiarle».
Poi, magari, qualche volta succede che, a cambiarle, ci si riesce anche.

