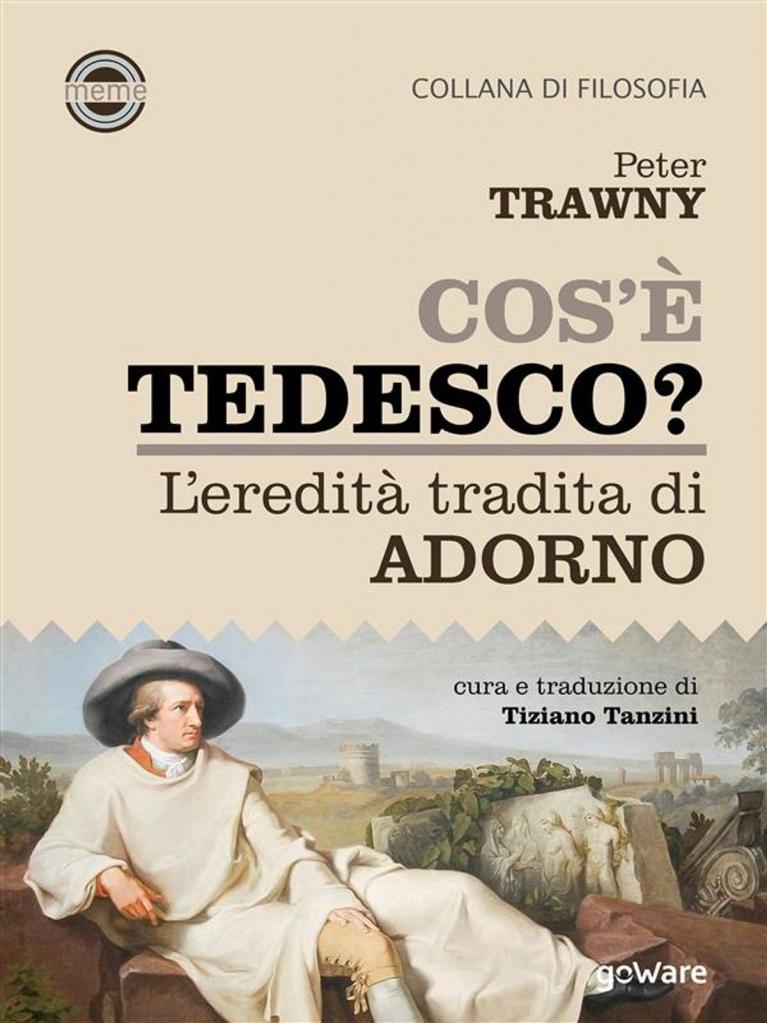Nella semifinale dei mondiali di Italia ’90, la Germania ha sconfitto ai rigori una sorprendente Inghilterra e Kenneth Clarke, allora ministro della sanità, ha chiesto a Margaret Thatcher “non è terribile aver perso coi tedeschi nel nostro sport nazionale?”. “Vedi Kenneth” ha risposto il Primo Ministro “loro possono averci battuto nel nostro sport nazionale, ma nel Ventesimo secolo noi siamo riusciti a batterli due volte nel loro sport nazionale”. E sempre a quell’anno risale la freddura di un altro formidabile battutista della politica, Giulio Andreotti, che incalzato sulla sua presunta avversione per i tedeschi aveva risposto “io amo la Germania. La amo a tal punto che ne preferivo due”.
Il periodo in cui sono state pronunciate queste battute – i dintorni del 1990 – non è casuale. Dopo un quarantennio di silenzio dovuto in parte anche alla ferita di quel muro che la attraversava, la Germania, come nazione, tornava a presentarsi al mondo con una orgogliosa pretesa identitaria. Per la prima volta dopo tanti anni, le strade tedesche avevano visto spuntare timidamente qualche bandiera nazionale e l’afflato patriottico dovuto all’unificazione aveva portato alla riscoperta di un orgoglio che per molti anni era stato sopito, vale a dire l’orgoglio di essere tedeschi. Già. Ma cosa significa essere tedeschi?
La stessa domanda se la pone Peter Trawny, filosofo classe 1964, in un saggio recentemente tradotto in italiano (Cos’è tedesco? L’eredità tradita di Adorno, goWare, Firenze 2019, 115 pp.). E se la pone in un periodo, quello attuale, in cui la caratterizzazione di ciò che è tedesco non è al riparo da ambiguità e tensioni. La crescita dei nazionalismi europei che identificano nella Germania il paese egemone e responsabile per gli assetti politici dell’Unione, la formazione di movimenti apertamente nazionalisti sullo stesso suolo tedesco, sono solo alcuni dei fenomeni che fanno sì che proprio oggi la domanda su cosa significhi essere tedesco rivesta un’importanza decisiva.
Del libro di Trawny colpisce il sottotitolo – l’eredità tradita di Adorno – e colpisce in particolare l’orecchio non tedesco, abituato a pensare al filosofo francofortese come a un intellettuale magari pungente, ma lontano dai fatti concreti della politica. Mentre Sartre e Foucault scendevano assieme agli operai davanti ai cancelli della Renault, mentre Enzo Paci marciava a fianco degli studenti a Milano, Adorno denunciava l’ala radicale del movimento che occupava la sua aula e veniva colpito dei famigerati Busenattentate: attacchi mirati nei quali, come provocazione, le femministe mostravano i seni scoperti all’accigliato filosofo.
Nel suo saggio, Trawny assegna ad Adorno una centralità nella cultura tedesca che ha pochi omologhi in Europa. Azzardando un paragone, qualcosa di simile può forse essere detto in Italia per Pasolini. Intellettuale decisamente più versatile di Adorno, Pasolini ha affiancato all’analisi rigorosa della società gli strumenti dello scandalo e della provocazione per mettere in crisi l’autoritarismo che le istituzioni italiane avevano ereditato dal Ventennio. Di Il Pci ai giovani tutti ricordano la difesa (presunta) del poliziotto, e pochi osservano l’importanza di quel “Ma prendetevela contro la Magistratura, e vedrete!” con cui punta il dito sul passato fascista di quell’istituzione. Adorno, per Trawny, assomiglia a quello che per noi italiani sarebbe un Pasolini che ha saputo integrarsi pienamente nella vita della Repubblica Federale, anche perché la sua critica elitaria della borghesia si è sposata alla perfezione con un sistema istituzionale che non voleva spazzare via lo spirito borghese, ma distillare il meglio di ciò che dal Reich guglielmino era filtrato nella Repubblica di Weimar passando indenne attraverso lo sconvolgimento nazista.

La presenza di Adorno all’interno del panorama culturale della Germania del secondo dopoguerra, e Trawny ne offre un resoconto, è profonda e capillare. Non si tratta solamente dell’attività accademica, di studioso, saggista e articolista che Adorno ha sempre svolto. La sua incisività è stata persino più netta se ci si rivolge a quei mezzi di comunicazione di massa da lui così aspramente criticati e soprattutto alla radio, la cui importanza nella formazione dell’opinione pubblica gli era chiara già negli anni dell’esilio americano, quando analizzava i discorsi di propaganda antisemita nelle emittenti statunitensi.
Proprio questa presenza diffusa di Adorno come formatore di discorsi culturali pubblici ha fatto sì che si potesse parlare della Germania postbellica come di una “Repubblica Federale Adorno”, dice Trawny citando Philipp Felsch (p. 9), vale a dire di una Repubblica Federale in cui la massa degli operatori culturali nel senso più ampio si era formata secondo una speciale forma di fedeltà al pensiero di Adorno.
Ciò che è tedesco aveva finito per coincidere con una serie di principi e di modelli intellettuali nei quali si poteva riconoscere nettamente l’impronta francofortese e che davano luogo a “una Germania che si concentra su se stessa in modo critico, senza unilateralizzare la propria storia” (p. 51). A caratterizzare quel che è tedesco era un senso di apertura critica, di rinuncia a una posizione culturale monolitica, che derivava da una riflessione profonda e sofferta sugli eventi che ne avevano caratterizzato la storia, con particolare riguardo all’orrore di Auschwitz. Quando Trawny si riferisce a quel che era tedesco nella Repubblica Federale, ha in mente un percorso in cui “viene così alla luce un’intuizione dolorosa di ciò che è tedesco. In essa, ogni tentativo di rimuovere il ricordo della Shoah si dimostra essere un presagio dell’impossibilità della sua rimozione” (p. 54).
Proprio questa eredità adorniana è quel che secondo Trawny la Germania unificata ha finito, fatalmente, per tradire. E il processo di unificazione sembra avere avuto un ruolo non marginale nell’accantonamento di quella tradizione culturale. Il muro che trent’anni fa si è abbattuto così violentemente su tutto il movimento socialista ha portato con sé conseguenze che allora erano difficilmente immaginabili. All’iniziale entusiasmo, ha fatto seguito un senso di smarrimento culturale che ancora oggi fatica a dissiparsi. Non solo i vecchi Länder dell’est hanno perso gran parte dei riferimenti nei quali avevano vissuto cinquant’anni, anche l’ovest è stato privato di una componente non marginale: “l’altro” che stava al suo interno. Venendo meno questo altro, anche ciò che è tedesco in senso “federale” ha finito per pagarne le conseguenze. Testimonianza, oggi, è il libro di Thilo Sarrazin, che Trawny elegge a simbolo della rottura di quegli argini culturali che l’adornismo tedesco aveva eretto con fatica. Nel volume La Germania si indebolisce. Come mettiamo a repentaglio il nostro Paese (Monaco 2010) dell’economista dell’SPD Trawny vede lo sdoganamento di una serie di argomentazioni di orientamento razzista che negano nel modo più chiaro e netto proprio quel ciò di tedesco ispirato alla critica della propria storia e all’apertura all’altro.
Ciò detto, che senso ha oggi domandarsi, ancora, che cos’è tedesco? Il libro di Trawny non offre una risposta netta a questa domanda. Si imita a porre il problema. Se la fine della teoria critica pronosticata da Sloterdijk, il suo progressivo accademizzarsi, il suo adeguamento ai canoni della cultura liberale abbiano davvero influito in modo decisivo sulla crisi di ciò che è tedesco, non trova una risposta inequivocabile. Di certo, ed è questa una lezione che si apprende al di là dell’insistenza di Trawny a legare il congedo da Adorno all’imbarbarimento culturale, tra i due fenomeni esiste un nesso che, se anche non è causale, possiamo descrivere con la stessa metafora che Weber riprendeva da Goethe per spiegare il rapporto tra l’etica protestante e lo spirito del capitalismo, vale a dire quella di una profonda e innegabile affinità elettiva.