“…abbiamo bisogno di un’educazione sentimentale per gestire e indirizzare l’affetto e la passione – e spesso non basta un’esistenza per venirne a capo…”. Così scrive Salvatore La Porta in Elogio della rabbia. Perché dovremmo incazzarci di più e meglio, Il Saggiatore, Milano 2019; p. 50.
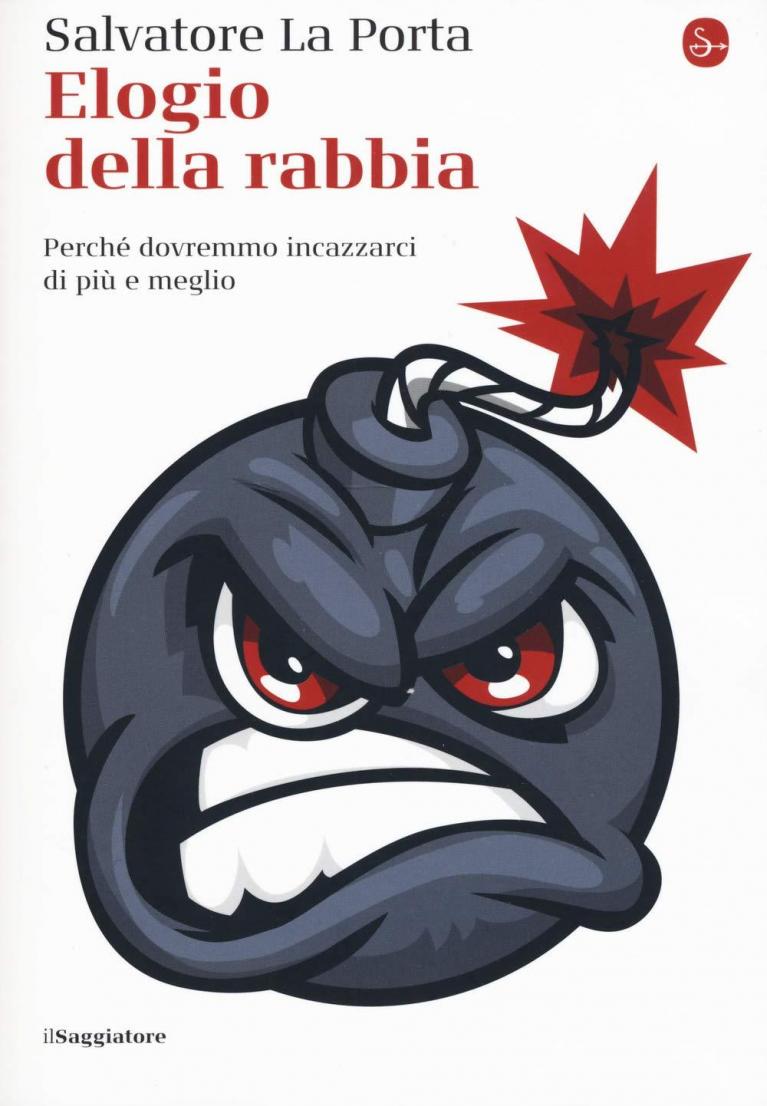
Ma come, verrebbe da dire, se non si assiste ad altro che a gente arrabbiata? Dai talk-show televisivi al linguaggio della politica, agli stadi, alla gente per strada, alla vita familiare, ovunque si sentono imprecazioni e incazzature. Allora cosa può voler mai dire che “dovremmo incazzarci di più e meglio”? Le rabbie che si vedono in giro quasi mai sfociano in progetti e in forme efficaci di emancipazione e innovazione. Nella maggior parte dei casi si esauriscono e implodono in esiti rancorosi e in conferme dell’esistente.
Viviamo un tempo in cui ognuno deve esaltare la propria dimensione pubblica e teatrale esibendo la propria vita. È un dovere a cui non è facile sottrarsi. Ce lo impone una certa struttura a dominanza nelle nostre relazioni sociali odierne. Nella posizione affettiva e relazionale in cui si ritrova oggi ognuno di noi, non sollecitiamo con quel “deve” una posizione insostenibile e molto angosciosa per il vissuto di impotenza che può mobilitare? Non è che fissiamo l’io in una posizione idealistica antistorica, mentre si trova a fare i conti con le sabbie mobili del diffondersi di posizioni di indifferenza? L’io non esiste da solo. La singolarità e la solitudine in cui ci ritroviamo spesso produce quello che forse è il tratto più evidente della nostra contemporaneità: l’indifferenza. E cosa comporta l’affrontare lo stato di indifferenza? Dal riflettere sull’oltre-umano (tutta la letteratura intorno al cyborg) ora ci troviamo a considerare fenomeni che mostrano un’implosione nel non-umano (la negazione della nostra natura relazionale).
È difficile non associare la rabbia e le manifestazioni che le sono affini, come l’indignazione, le esplosioni aggressive verbali e non verbali, alla compressione che l’indifferenza ci fa sperimentare.
La rabbia, del resto, come ogni altra emozione di base, per noi umani non è una scelta. Non decidiamo, cioè, di arrabbiarci, per quanto a prima vista possa sembrare strano. Certe cose di noi sono diventate un poco più chiare in questi ultimi anni. Le emozioni, non facili da definire, soprattutto se sono quelle che ci accomunano agli altri animali e appartengono alla nostra lunga storia evolutiva, hanno una caratteristica: prima si manifestano a livello corporeo e poi ce ne rendiamo conto a livello di consapevolezza e cognizione. La Porta perciò sembra suggerirci che se non possiamo decidere di non arrabbiarci o di arrabbiarci, perché il nostro sistema corporeo, il sistema sensomotrio e il cervello, esprimono l’emozione della rabbia di fronte ai fenomeni del mondo, gli altri e le situazioni, forse possiamo educarci a gestire quello che sentiamo per gestire l’emozione della rabbia.
Tutto ciò vale, del resto, per tutte le altre emozioni di base.
Potrà apparirci strano. È come se qualcosa ci precedesse, anticipasse la nostra volontà e le nostre intenzioni, a cui mostriamo di fare così tanto affidamento. Verrebbe quasi da chiedersi se siamo noi o non siamo noi quando ci comportiamo in un certo modo. Eppure a noi stessi accade, riflettendo dopo certi nostri comportamenti, di dire: “non so come mai, non sembravo io!”. Ma eravamo noi o no? Dal punto di vista giuridico, se quel comportamento ha prodotto conseguenze per qualcun altro, si procede, come si dice, oltre ogni ragionevole dubbio, a dimostrare che eravamo proprio noi, sulla base di prove non confutabili. Dal punto di vista psicologico e comportamentale, però, le cose non stanno così semplicemente, si fa per dire. Quella persona che dice “non sembravo io”, allora com’è fatta?
Potremmo dire che è fatta in modo da essere allo stesso tempo lei e non lei, in un modo e anche in un altro, che è plurale, molteplice, una federazione di istanze, insomma; o per dirla con Pirandello: una, nessuna, centomila. Non solo, ma per parafrasare un altro grande, Freud, non è padrona in casa propria. Come tutti noi. E per approfondire ancora, tramite uno che di comicità e di ironia se ne intende, Woody Allen: ci capita spesso di non essere d’accordo con noi stessi.
Cosa vuol dire essere preceduti e in una certa misura determinati da se stessi. Siamo una storia che è figlia di storie e la nostra ontogenesi partecipa di una filogenesi di cui siamo un’espressione. Le nostre azioni sono emergenze intrecciate di una qualche persistenza di personalità, ma anche della contingenza empatica e neuroplastica, cioè, direbbe Vittorio Gallese, della nostra simulazione incarnata con gli altri e il mondo. Di volta in volta, quindi, pur su una base di una certa continuità noi diventiamo quello che esprimiamo nelle relazioni che stiamo vivendo.
In quelle relazioni si sprigionano le nostre emozioni a livello preintenzionale, prelinguistico e prevolontario. Possiamo filtrarle mediante l’educazione e l’etica di cui siamo pure fatti, e il nostro effettivo comportamento sarà di volta in volta quello che emerge dal crogiuolo o dal bricolage che ci costituisce.
Così la rabbia e l’aggressività, che pur essendo affini non sono la stessa cosa, pare che si dipartano a livello cerebrale da un centro di smistamento chiave che è l’«area di attacco» ipotalamica, un piccolo ammasso di neuroni dove il cervello riceve i segnali che regolano l’accelerazione del battito cardiaco e le altre risposte fisiologiche che precedono gli atti violenti. In altre aree, l’amigdala riceve dai sensi dell’area decisionale sulla superficie del cervello i segnali che indicano la presenza di una minaccia. La corteccia tiene sotto controllo gli impulsi imprevedibili. I circuiti della rabbia e quelli della ricompensa sono collegati [R. Douglas Fields, Meccanismi dell’aggressività umana, Le Scienze, agosto 2019, n. 612; pp. 43-49]. Gli esperimenti più recenti sugli esseri umani e animali hanno cominciato a chiarire come i comportamenti hanno inizio nel cervello [R. Douglas Fields, Why We Snap: Understanding the Rage Circuit in Your Brain, Dutton 2016]. Dal punto di vista psicologico appaiono davvero infiniti i fattori che possono scatenare l’aggressività umana: provocazioni e motivi possono provenire da diverse fonti e cause. Allo stesso tempo sono pochi e specifici i circuiti neuronali che nel cervello sono responsabili del comportamento rabbioso e aggressivo. Mentre non sono state dimostrate connessioni tra malattie cerebrali, rabbia, aggressività e violenza, sembra che i principali fattori di rischio che predicono rabbia e comportamenti violenti siano strettamente legati ai comportamenti gregari nelle relazioni sociali, dove nei processi di individuazione psichica e collettiva si creano condizioni per cui l’aggressività emerge e prende le diverse forme con cui si esprime nell’esperienza.
È necessario non dimenticare che stiamo parlando di un’emozione di base, la rabbia, che dà vita a comportamenti aggressivi e che la stessa aggressività è associata a fenomeni gratificanti e positivi e a fenomeni mortificanti e distruttivi. È noto da tempo che anche l’accoppiamento è controllato dall’area di attacco nell’ipotalamo e che la stimolazione con elettrodi impiantati in questa sede può indurre la copulazione o l’aggressione distruttiva.
La stessa connotazione ambivalente della rabbia e dell’aggressività vale per molti altri comportamenti, come l’aspetto gratificante dell’aggressione, nel quale sono incluse sensazioni di superiorità e dominanza, ma anche per le componenti edonistiche e brutali di violenza, fino alle forme psicopatiche. Tra queste ultime vi sono anche le molteplici forme implosive della rabbia che si ritorcono solo contro che la prova e si esauriscono in depressione e altri tipi di sconfitte.
La molteplicità delle regioni cerebrali coinvolte nei comportamenti aggressivi permette al cervello sia di pensare velocemente che lentamente in risposta a una minaccia. Un numero significativo di ricerche evidenzia come le reazioni lente e riflessive siano più complesse e coinvolgano l’attivazione della corteccia prefrontale che ha un ruolo critico nel processo decisionale relativo all’elaborazione dell’aggressività in modi non distruttivi.
Come fa opportunamente La Porta, è utile distinguere tra rabbia, aggressività, rancore, ira, violenza, distruttività, lotta, fuga e altri comportamenti similari. Possiamo ipotizzare che sia il sistema della rabbia, in quanto sistema emozionale di base, a reggere le espressioni delle molteplici modalità con cui emergono i comportamenti umani effettivi.
Una verifica della decisiva determinante biologica della rabbia è la differenza sessuale: forse il sesso è il fattore predittivo più importante del comportamento aggressivo. Nelle prigioni il numero dei maschi è di circa il novanta per cento rispetto alle femmine. Nel regno animale l’associazione tra genere maschile e comportamenti aggressivi è evidente.
Quella che Jonathan Gottschall chiama «la danza della scimmia», un’infinita varietà di competizioni ritualizzate e vincolate da regole precise [J. Gottschall, Il professore sul ring. Perché gli uomini combattono e a noi piace guardarli, Bollati Boringhieri, Torino 2015; p. 13] sembra collegata alla parte più ancestrale della psiche maschile.
D’altra parte la rabbia e l’aggressività sono alla base delle molteplici forme del combattimento rituale che, mentre produce esiti che possono andare dal ridicolo alla tragedia, come nei duelli e negli sport da combattimento, svolgono allo stesso tempo una funzione vitale: aiutano gli uomini ad elaborare i conflitti e a fissare delle gerarchie, riducendo al minimo gli spargimenti di sangue e il caos sociale. Secondo Gottschall, “senza i codici vincolanti della danza della scimmia, il mondo sarebbe un luogo molto più tetro e violento”.
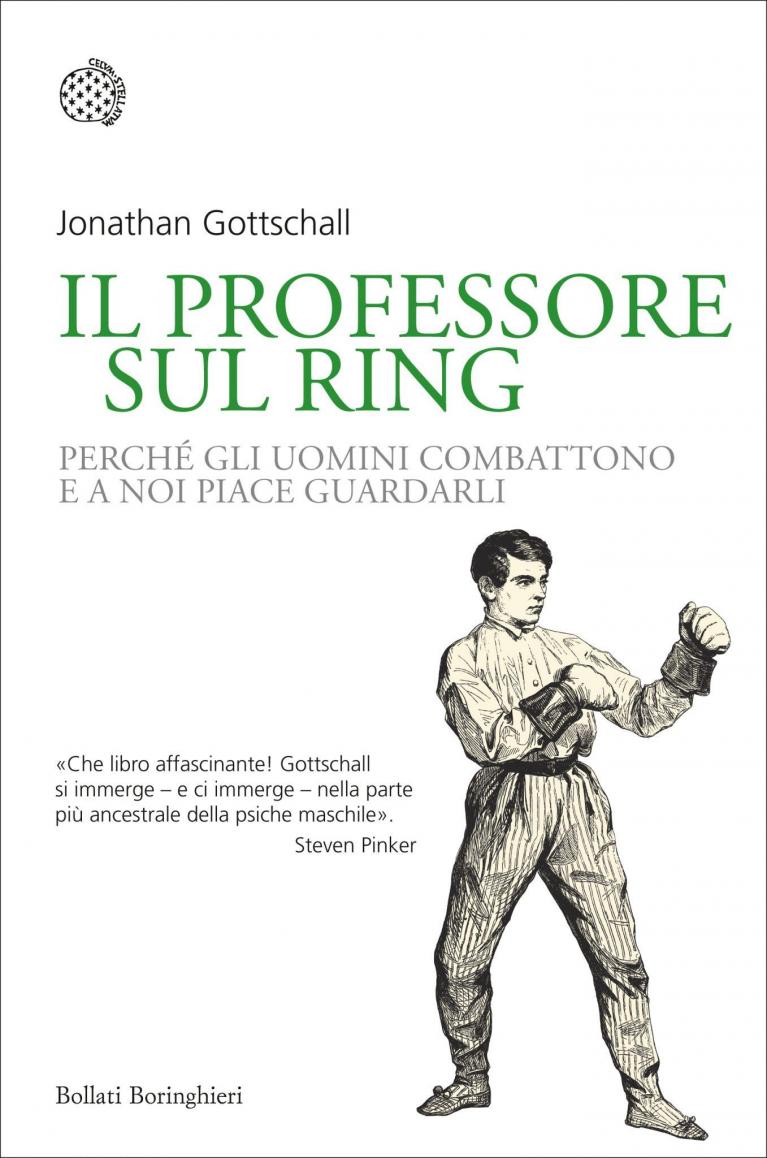
Distinguendo tra rabbia, rancore e ira, La Porta sviluppa una considerazione che merita di essere approfondita. Il punto di partenza è che noi dovremmo arrabbiarci di più e meglio. Secondo questa prospettiva il rancore e la paura distruggono le nostre vite, in quanto generano implosioni e ritiro dal conflitto inteso come confronto e dialogo per l’elaborazione delle differenze di interessi, di culture, di valori, di conoscenze.
Secondo La Porta “dev’esserci un modo migliore di vivere, che renda la nostra rabbia uno strumento utile al mondo” [p. 17]. L’ipotesi che in altri tempi e in altre civiltà la rabbia sia servita a generare progetti di liberazione e di emancipazione, si combina con la proposta che si tratti oggi di riabilitare la rabbia, “liberandoci dalla meschinità delle catene in cui l’abbiamo costretta”. Di fronte all’ingiustizia e al sopruso, o di fronte alle tragedie della storia “è stata la nostra rabbia migliore a tirarci fuori dalla caverna in cui c’eravamo infilati”. “Se vogliamo alleviare il nodo che ci sveglia ogni mattina, dobbiamo avere cura della nostra rabbia: dobbiamo usarla per migliorare i luoghi che viviamo, pubblici e privati” [p. 18].
Appare evidente che la rabbia sia intesa in questa prospettiva come l’antidoto più significativo contro l’indifferenza che è uno dei tratti più problematici della nostra contemporaneità.
In questo modo l’atto di arrabbiarsi assume le caratteristiche di un filtro per selezionare il valore effettivo delle relazioni e dei sentimenti. Citando Dickens: mordiamo le monete con cui ci pagano le emozioni per capire se sono davvero d’oro. Un esempio su cui La Porta si sofferma è l’amore: “l’amore è rarissimo e, vista quanta gente ne fa sfoggio, i conti non tornano affatto” [p. 24]. La rabbia che può aiutare a filtrare la sua effettiva natura ha la caratteristica di non chiedere verifiche, in quanto mette in campo un’immediata schiettezza che non tradisce chi la prova. Insomma la rabbia è sempre sincera.
Nel tessere l’elogio della rabbia, La Porta pone una distinzione necessaria: se la rabbia sembra il telaio principale dei populismi, egli propone di distinguerla nettamente dall’ira e dal rancore. Questi ultimi sentimenti sarebbero una degenerazione della rabbia non vissuta e non espressa, così come è necessario non associare l’odio alla rabbia, perché è piuttosto il compagno dell’amore. La possibilità appare legata al bisogno di un’educazione sentimentale per gestire e indirizzare affetti e passioni e canalizzare la rabbia verso la progettualità e il cambiamento. Dalla rabbia, com’è accaduto più volte nella storia, può scaturire la gioia e la lotta comune, divenendo un momento d’amore e di felicità. La differenza col rancore sta nel fatto che la posizione rancorosa imprigiona chi ne è portatore, come se si incatenasse al proprio nemico, rischiando di vivere tutta la vita rinchiuso in quella posizione.
Allo stesso tempo “scivolare attraverso la vita con il muso sul terreno” [p. 70], induce al conformismo e a un quieto vivere che fa perdere la capacità di giudicare e di prendere posizione, di avere una determinazione e un discernimento, che sono oltremodo necessari per ogni vita che valga la pena di vivere e per la costruzione di una civiltà degna di tale nome.
La rabbia può dar vita, però, anche all’ossessione del controllo. Ci disponiamo a tenere ossessivamente sotto controllo ciò che amiamo per difenderlo da minacce vere o immaginarie che provengono da coloro che non sono “nostri”.
“La rabbia si ammala in molti modi in questi anni, ma tutti i rami della sua degenerazione convergono su questo: il controllo, e c’è un motivo; è sicuramente accanto a voi, certamente nella stessa stanza, se non sopra il cuore, addosso” [p. 84]. L’ossessione di controllo è frutto della nostra rabbia ammalata, indirizzata verso tutto ciò che è diverso da noi e orientata alla negazione di ogni sollecitazione che potrebbe provenirci da ciò che è diverso e magari più debole.
L’ossessione per la protezione ci porta alla negazione suprema, quella della morte e genera una vita infernale vissuta all’insegna di un delirio di eternità misto a rabbia per la finitudine certa. Una condizione esistenziale davvero angosciosa e difficile.
“Ecco qual è il principio, il ceppo virale da cui scaturiscono le degenerazioni della nostra ira?”: “dietro il tentativo di controllare la fine della vita, insito in ogni religione – dall’ebraismo al transumanesimo – c’è in agguato un furore ossessivo”, che insegue l’eterno con molteplici manifestazioni.
“La rabbia ci rende persone libere e indipendenti, lega le nostre azioni alla razionalità, perché per provarla bisogna giudicare, e il giudizio è l’azione fondamentale dell’intelletto umano, il più importante atto d’indipendenza che possiamo compiere su questa terra” [p.110].
Perché ciò accada, perché possa essere valido l’elogio della nostra rabbia migliore, come la chiama La Porta, deve essere guidata dall’intelligenza – non cieca ma argomentata, non meschina o contorta ma in piena luce diretta, non comandata ma indipendente, non per amore, interesse o paura, ma per giustizia e nient’altro [p. 158]. La conclusione di La Porta è che se non sapremo appropriarci della buona gestione della nostra rabbia ci rimarranno solo l’odio e l’amore e, quindi, guerre e confini.
A pensarci bene il modo di intendere la rabbia da parte di La Porta richiama molto da vicino il tema del conflitto e della disobbedienza.
Se la negazione della rabbia rischia di indurre al consenso, alla sottomissione, al conformismo e all’autorità costituita, allora la disobbedienza e la gestione generativa del conflitto possono essere sodali con la valorizzazione efficace della rabbia. Così come Salvatore La Porta ritiene necessaria un’educazione sentimentale per aumentare la capacità di gestire e vivere efficacemente la rabbia, Frédéric Gros sostiene l’importanza e la necessità di disobbedire a un mondo ingiusto che va a rotoli come un’urgenza bruciante. La disobbedienza per Gros è soprattutto un’affermazione di umanità [F. Gros, Disobbedire, Einaudi, Torino 2019].
Nel riprendere la straordinaria vicenda della leggenda del Grande Inquisitore da I Fratelli Karamazov di Dostoevskij, Gros si domanda quale rapporto si possa stabilire tra obbedienza e disobbedienza, a partire da alcune caratteristiche proprie degli esseri umani. Ovvero, come accade nella narrazione di Dostoevskij, la questione cruciale diventa quanta e quale libertà gli esseri umani sono in grado di sostenere. Si torna alle caratteristiche distintive umane per domandarsi quale sia la nostra capacità di elaborare le emozioni fondamentali in maniera più o meno appropriata ed equilibrata. A ben vedere, ad essere messa in discussione è proprio quell’educazione sentimentale che sembrava di per sé una soluzione. Se per educazione sentimentale si intende, alla maniera di Kant, l’educazione all’obbedienza incondizionata per poter accedere al processo di umanizzazione necessario per diventare cittadini; se, cioè, si tratta di preparare il futuro soggetto politico ad accettare leggi con le quali non sarà d’accordo, questa diventa né più né meno che un’educazione alla rassegnazione politica. In questa prospettiva, per dirla con Michel Foucault, siamo di fronte a un’educazione come disciplinamento e un’emozione di base come la rabbia o come il desiderio divengono sentimenti da ricondurre alla morale dominante, neutralizzandone il più possibile la portata di discontinuità, di disobbedienza, di messa in discussione dell’ordine costituito. Gros considera, tra gli altri, il tema delle disuguaglianze nel mondo attuale: “Le disuguaglianze sono arrivate al punto che soltanto un’ipotesi di doppia umanità potrebbe giustificarle” [p. 7].
Riprendendo il cuore della lezione di “Il Grande Inquisitore”, il confronto serrato sta tra il fatto che Cristo non viene a portare obbedienza, ma esige da ognuno che sposi la libertà nella quale ritiene che abiti la dignità dell’umano, assumendosene il costo e la responsabilità, e il fatto che quella libertà gli umani mostrano di non volerla, in quanto insostenibile, responsabilizzante, appunto, insopportabile. Secondo l’Inquisitore, che chiederà a Cristo che era riapparso sulla terra di non tornare mai più, gli umani ben volentieri si rimettono a chi si prende il fardello di guidarli e proteggerli, togliendo loro il peso della libertà. In nome di questo orientamento la disobbedienza è connotata negativamente e la stessa sorte, come abbiamo visto tocca alla rabbia, secondo le morali di volta in volta dominanti, come rileverà Michel Foucault occupandosi, nel suo corso al Collège de France del 1975, di «incorregibili».
La disobbedienza e la rabbia a questo punto pongono una domanda fondamentale: sono la nostra condizione primaria, la nostra natura di cui non fidarsi e, quindi, da domare; oppure sono la via per renderci umani, in quanto capaci di reagire e istituire discontinuità e comportamenti inediti di fronte all’ingiustizia e all’orrore?
La domanda si fa particolarmente urgente oggi quando la contrapposizione non è più, di fatto, tra l’uomo e l’animale, ma tra l’uomo e la macchina, tra l’uomo e la tecnica. Dall’elaborazione di questa domanda si può ricavare un’etica della prassi che sia capace di sottrarsi ai limiti dei moralismi. Gros, opportunamente, sostiene che “l’etica è la maniera in cui ciascuno si rapporta a se stesso, costruisce con sé un certo «rapporto» in base al quale si autorizza a perseguire una certa cosa, a fare questo piuttosto che quello. L’etica del soggetto è il modo in cui ciascuno si costruisce e lavora” [p. 24]. Insomma obbedire o disobbedire è dare forma alla propria libertà.
Per comprendere la disobbedienza è necessario definire con una certa precisione l’obbedienza. Nel caso dell’obbedienza stiamo parlando di “un rapporto (in cui sono diretto, dominato, comandato, governato e così via) che mi obbliga ad agire secondo il volere di un altro, tanto che pur agendo rimango passivo” [pp. 27 – 28]. Quell’obbedienza è frutto di un’impossibilità di reagire, pena sanzioni e punizioni fino alla morte, e diventa un generatore di rabbia e di potenziale ribellione. Nell’obbedienza, l’agente non è l’autore: “Si crea una separazione: lo faccio, ma non sono io veramente” [p. 33]. Un effetto problematico, con conseguenze di particolare importanza, dell’obbedienza è la deresponsabilizzazione, in quanto è come se chi agisce non fosse e non si sentisse l’autore di ciò che fa.
Una distinzione di una certa importanza è quella che Gros stabilisce tra obbedire e “superobbedire”, considerando che sarebbe perlomeno opportuno cominciare a smettere di obbedire. La libertà si trova sulla perpendicolare della responsabilità e siamo prima di tutto responsabili verso noi stessi, verso ciò che ce ne facciamo di noi. “Non siamo responsabili perché liberi, ma liberi perché responsabili” [p. 41]. Oltre a smettere di obbedire, un passo importante è cercare di passare dalla subordinazione al diritto di resistenza. Non poteva mancare in un libro sulla disobbedienza, costruito con chiarezza e determinazione di intenti, un capitolo su Antigone e la sua posizione, che non si limita a richiamarsi a una legittimità superiore o ad affermare che si obbedisce ad altre leggi, ma mette in discussione il principio stesso di una legittimità. “Nella disobbedienza”, scrive Gros, “può entrare una parte di trasgressione pura: ecco il fulgore di Antigone” [p. 70].
Proprio la trasgressione pare un riferimento importante per parlare di rabbia e disobbedienza, in quanto la prima ragione di servitù volontaria pare proprio essere l’abitudine. Metterla in discussione vuol dire trasgredire prima di tutto un ordine e un equilibrio interiore basati sul cosiddetto “quieto vivere” e in secondo luogo agire verso il mondo per trasgredirne le consuetudini e le forme consuete con cui si esprime la realtà che ci circonda. Esiste però una “colla del gruppo” che tende a far prevalere la forza dell’abitudine e che neutralizza le possibilità di espressione della rabbia e della trasgressione. L’interiorizzazione dell’ordine e di ogni ordine costituito è analizzata da Gros ricorrendo al processo ad Eichmann tra l’aprile e il dicembre del 1961. Ricorrendo alle giustificazioni sulla propensione al conformismo e alla subordinazione agli ordini e all’ordine costituito derivanti dai noti esprimenti di Salomon Asch e di Stanley Milgram, Gros evidenzia come vi sia anche una perversione etica, una deresponsabilizzazione, che Hanna Arendt chiama “stupidità”, nel rinunciare a intervenire con la disobbedienza e la trasgressione di fronte all’ingiustizia. “Ma è una stupidità attiva”, scrive Gros, “deliberata, cosciente. Questa capacità di rendersi ciechi e stupidi, questa caparbietà nel non voler sapere, è questa la ‘banalità del male’”[p. 103].
Possiamo giungere a una indifferenza che dipende dalla cura del nostro ego, ma dal dimenticarsi della nostra responsabilità etica: i nostri comportamenti saranno allora corretti e conformi alla morale dominante, ma non terranno conto di quanto ha detto Socrate, citato da Gros: “a forza di curarti del tuo ego non rischierai di dimenticarti di te?” [p. 179].
L’obbedienza, insomma, non è una virtù, come aveva sostenuto da par suo Don Milani; e la rabbia può diventarla, a patto che si consideri la complessità della questione.
Un certo automatismo corre tra le righe del lavoro di La Porta, di cui pure il contributo di Gros mostra di risentire. Che un processo individuale e collettivo sia ritenuto necessario, non vuol dire che basti invocarlo. Perché la rabbia rimanga spesso un’esplosione che non si traduce se non in rancore, ira e risentimento e che altrettanto spesso subentri o la paralisi o la forza dell’abitudine, che si traducono in sconfitte dolorose per gli arrabbiati, è un’evidenza purtroppo tanto diffusa da richiedere una più approfondita riflessione. Come sostiene Carla Weber, riprendendo i contributi sul tema di Luigi Pagliarani, l’educazione sentimentale è una via per evolvere dalla ragione affettiva alla ragion poetica, trattata in un precedente contributo su doppiozero. Quell’evoluzione è molto impegnativa. Un bambino neonato preso da rabbia nella suzione del latte, può mordere, sputare e annichilirsi fino alla perdita di sé, e se non è aiutato, può non farcela a dosare le proprie capacità per riuscire finalmente ad alimentarsi. Lo stesso vale per la forza dell’abitudine che può portare a vivere tutta la vita nella dipendenza tiepida dal conformismo e non sfociare in un progetto di emancipazione, come accade in tante situazioni.
Un aspetto da considerare è che le cause della perdita e dell’autotradimento non risiedono solo fuori di noi. Già Platone, nell’Apologia, 29D, 30C, sostiene che “il tempo impiegato a preoccuparti del tuo corpo, dei tuoi beni, della tua carriera, può farti dimenticare di te stesso”. E Valdimir Jankélévitch ci ricorda che siamo un “plurale in prima persona” [V. Jankélévitch, Le Sérieux de L’Intention, Flammarion, Parìs 1997]. Le cause interne che ostacolano la buona elaborazione delle emozioni e trattengono nel rancore e nel conformismo meritano una considerazione più estesa e necessaria per comprendere perché così spesso riduciamo a “uno” la nostra pluralità e quell’uniformità parassiti di fatto la nostra pluralità, facendo in modo che la parte di noi che mette a tacere la spinta attiva a praticare la poiesis parassiti le altre che potrebbero fare di noi stessi un progetto e un’invenzione.

