Scrivere è sempre un dialogare con la morte, calarsi in un antro di voci che in realtà chiedono insistenti di esistere e di far esistere il mondo, a dispetto di tutto, e che, sospendendo la vita, domandano per una follia loro propria di far brillare ancor più la vita – di farla viva e tenace – come se passare per quello strano gorgo di parole tra l’ironico e il beffardo che sottrae il tempo e lo consuma, non sia che il modo necessario per ritornare a vivere, per dirsi vivi.
È il potere di evocazione, di richiamo, proprio della scrittura che può fare della morte non il tragico evento di una perdita, il gambo reciso di una dipartita, ma la distanza in cui la parola si confronta per tenere insieme, per ricondurre ai viventi le loro perdite – per salvare – in un territorio in cui vita e morte davvero convivono.
E questa morte, già inscritta in vita dentro il doloroso presentimento di un abbandono, nella cognizione di una perdita, in ogni triste cenno di congedo, appare di volta in volta nelle storie di quei personaggi ortesiani – bambini, innamorati, esclusi e poi principi, folletti e maghi, fanciulle impenetrabili, animali parlanti – che continuamente perdono, abbandonano, ricapitolano la loro esistenza, afflitti e turbati, finché il mondo non ricomincia a splendere in un subitaneo abbaglio di cui tornare a sorprendersi: grati di una minima dolcezza inaspettata, sollevati da un imprevisto cambio di vento, incantati da una nuova sprezzatura nel cielo.
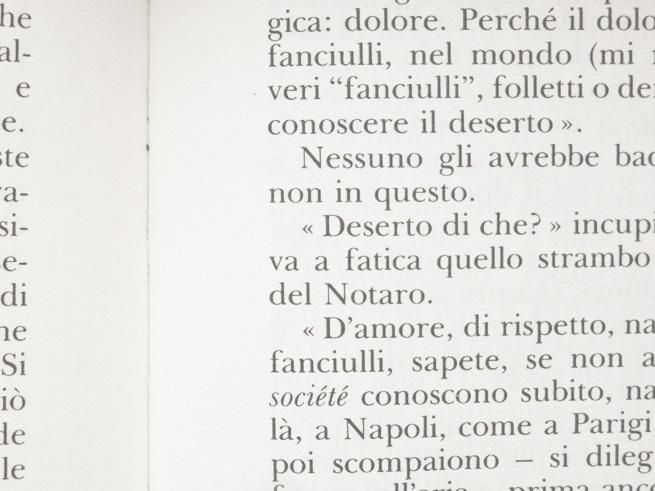
È quanto Ortese, nella sua opera che attraversa silenziosamente tutto il Novecento, ha chiamato visione; e visionari (come nel titolo del suo ultimo romanzo) sono gli eroi che vivono sprofondati nelle regioni di un sentire che sorge come pura emozione e come interrogazione, che si insinua in un reale che non è mai astratto o oggettivo, ma che esiste come masticato nella parola, fatto di turbamenti e presagi: un mondo che esce come voce o sentimento pregno dell’emozione dei suoi abitanti, dove l’esterno si lega indissolubilmente a una visione intima, quasi che tutto fosse in grado di vibrare, spegnersi o ridestarsi, contemporaneamente: i movimenti dell’anima come quelli dell’aria.
Allora appare la vera costruzione poetica di questa scrittura: luogo attraversato da un’intensità dentro cui guardare, in cui immergersi, percorso da una voce che riesce a scardinare l’impianto della narrazione, per deflagrarlo e moltiplicarlo in generi e stili con l’uso di una sintassi dilaniata e scomposta: le frasi sospese e un vero e proprio svenimento della parola che cede al silenzio, il buco in cui ogni possibilità di linguaggio sembra collassare.
Così veniva scritto Il porto di Toledo, tra il ‘69 e il ‘74, all’insegna di una reinvenzione linguistica dettata dall’eccesso paralizzante di un’intuizione amorosa, un trasporto che aveva il suo culmine nelle sospensioni, nelle balbuzie, presto dilatate nei mutismi di cui tante figure ortesiane sono affette.
Solo Alonso, il puma, sarà la pacificazione di questo sentire che silenziosamente risorge, non visto, ad un minimo gesto di cura.
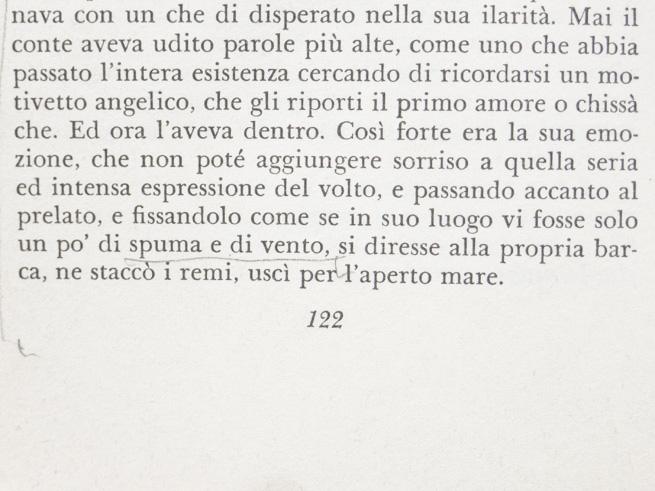
Ma noi viviamo perlopiù, se possibile, come i bellissimi eroi ortesiani, fulgidi e splendenti, e come illuminati da un’amarezza che li guida: dalla costernazione, dalla paura e dalla gelosia, dai moti d’amore mai compresi che sempre vibrano di rabbia, presi nel territorio del dubbio e del rimpianto, frastornati dallo scorrere della vita, e come segnati da un divenire che non lascia nessuno e che tutti conduce in un rosario molteplice e cangiante di nomi, forme, figure e apparenze.
Forse ad uscire in ultimo è la bellezza di questa grazia tutta umana dello sbando, insicura, permalosa e dolente, calata come un’esule in una Terra che non si può capire. Qui è stato scavato il sentire sin nelle radici che straordinariamente coincidono con la sua insorgenza: un moto iniziale di comparsa, il momento in cui l’anima trabocca turbata dall’esterno, e si muove con la paura di un’emozione cieca, a cui sfugge la presa sul mondo, e che miracolosamente, preziosamente, continua a rimanere nascosta a se stessa.
È dalle soglie di una giovinezza mai finita – che è poi questa incapacità di riconoscere il proprio sentimento subìto come uno smarrimento timido e selvaggio di fronte alla grandiosità del mondo – che parla Ortese: di un canto (e incanto) d’inizio così ardente e così fragile, così eroico perché sfuggente; di un’umanità febbricitante, persa nel flusso delle proprie passioni che vive interrogando le ragioni di un mistero attorno a cui conduce, insistente, la propria fatale avventura. Un sentimento che mai abbandona, che mai lascia soli: come se tutto fosse trattenuto – complice quella scrittura antica, “antichissima”, di cui raccontava la scrittrice alla ricerca delle sonorità necessarie ai suoi ultimi romanzi – in una voce votata solo ad una devozione testarda al proprio sentire, un’aderenza cieca e insistita che sa sempre di pegno e di colpa attorno a cui si rinnova la metamorfosi di ogni apparire.
Il male che resta in Ortese è il dolore che apre allo strazio, qualcosa di cui il corpo non si può liberare e in cui la mente, irretita, si arrovella, perché è l’umano messo di fronte alla vita come a un prodigio, troppo grande e stupefacente; e, dentro, un dolore che insinua persino la bellezza in cui non trova pace: non l’approdo di un affetto duraturo, né una felicità capace di resistere al tempo e alle cose – perché le cose caduche se ne vanno – ma come se il vivere passasse sempre attraverso un’incrinatura dello sguardo, una spezzatura, uno scarto che è immagine, sempre, di qualcosa di assente, di una distanza, di un venir meno: una perdita impressa in ogni cosa, e di cui ogni cosa si fa, nelle sue sembianze, testimone.
Da qui il pianto, lo strazio, l’angoscia.
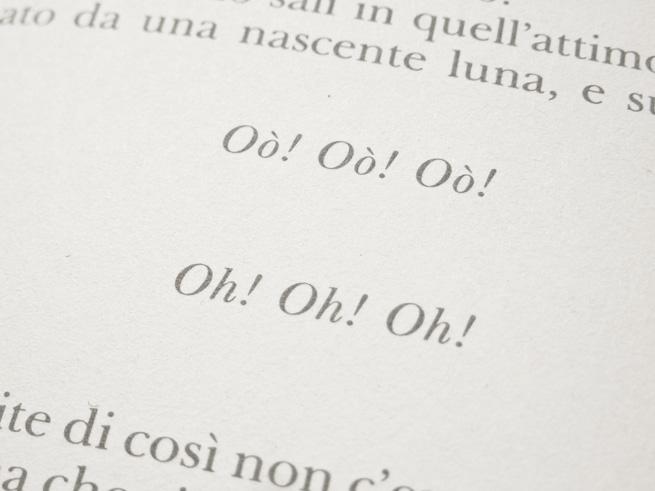
E la scrittura ha il potere benefico di sopportare, di sostenere l’assenza, per farne la materia sottile sui cui lembi le parole possono girare: lambendo, scavando. Per questo la lingua di Anna Maria Ortese non è mai cruda, ma sempre compagna come fatta di voci multiple: un testo corale che ha bisogno dello spazio in cui risuona e che per quanto dolorante, o dolente, rifugge il dramma e chiama e tiene vicino anche nella perdita, dentro la morte, facendo spazio e affidandosi al non visto, all’invisibile che la parola sa portare con sé.
Toccando qualcosa di assente, la scrittura (chiamata anche espressività o espressione, in Toledo) ha la consapevolezza (peso e grazia dello scrivere) che non tutto il reale sia afferrabile, ma sempre soggetto alle intemperie, sempre incerto e sprofondato a più strati, dirà il Daddo de L’Iguana, in pura e profonda immaginazione.
È quanto si produce di grandioso in questi scritti costruiti tutti attorno a un vuoto centrale che, inavvicinabile, si rivela per tangenze dove la separazione e l’attesa diventano la lente scura che ancora può mostrare le cose nella loro interezza, nel loro silenzio. E il rimpianto, parola qui cara, si mostra per quello che è: l’intimo gorgoglio di un lamento che prende corpo nell’esterno, portato da una lontananza di cui si è persa da tempo la ragione.
Scrivere, allora, per preservare e tentare di riavvicinare le cose dell’umano, ricucendo addosso all’uomo quanto può esserci di divino o di sacro nel suo agire. Si intrattiene così, nell’affannosa esistenza dei suoi protagonisti, un continuo discorso con gli déi, che richiama a sé quella parte invisibile del mondo, quell’invisibile denso che spira nell’aria e che richiamato nomina e avvicina. Come in quegli ultimi paragrafi dei tre romanzi della fiaba (L’Iguana, Il Cardillo addolorato, Alonso e i visionari) che si aprono al di là della pagina verso un infinito: un po’ dedica, un po’ dono, un po’ preghiera.
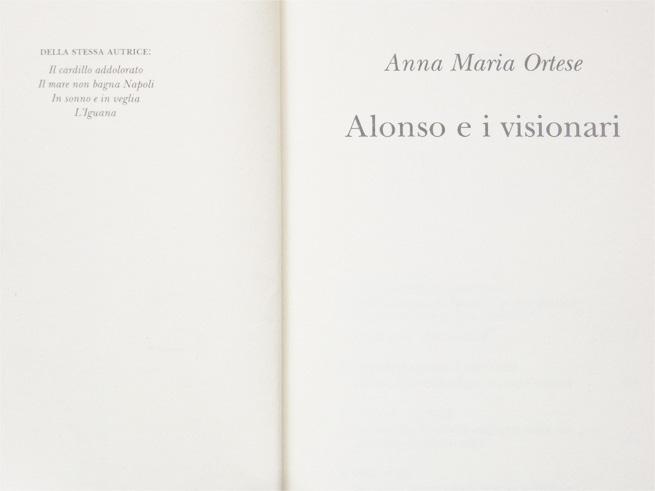
Ecco perché in queste storie possono sopravvivere gli déi, seppure morti a un primo sguardo, adagiati su un letto nelle fragili sembianze di farfalla (L’Iguana), o dispersi nella mutevole forma di un puma cane malconcio e rinnegato tra le pietraie della periferia romana (Alonso); ecco perché sono storie di sparizioni e di apparizioni, di resurrezioni, di fraintendimenti, di immagini che si accavallano e scritture che magistralmente non tengono più il conto di luoghi e situazioni, ma si sciolgono, un’immagine nell’altra, con una visionarietà autentica, dove l’esaltazione della vita sprofonda nel gesto più minuto: “in tutto quanto di umile si sveglia e muore ogni giorno”.
Un racconto fatto per eccessi e intensificazioni, un tracimare del sentire che libera l’immaginazione e la fa passare nei territori dolorosi della sofferenza. Sono, quelli ortesiani, romanzi e racconti affidati, sin dagli esordi, ad una malattia tutta visionaria, tesa attorno a figure la cui potenza e bellezza è racchiusa nel loro fallimento e nella fragilità in cui sono perduti.
Anche l’intelligenza di qui esce sconfitta perché sono gli idioti, i piccoli, e chi non ha parola, a custodire intatto il segreto del mondo, lontani, loro, “dall’indifferenza e dallo sgarbo” che, dice il Professore americano di Alonso, “sono le colpe di cui si macchia l’uomo di fronte agli déi”. E il sapere, “l’orgoglioso sapere, potere, possedere”, in questa luce è costretto a un’altra strada, chiamato a ritrarsi di fronte ad ogni mistero, che è bene contemplare – come la luna – sconosciuto nella sua distanza. Forse dentro le pieghe, si interrogava Ortese, di una non Storia.
Nell’epoca della prossimità, fatta di immediatezze e presenze, di una conoscenza onnivora che vuole farsi completa, quasi fosse possibile guardare solo attraverso il filtro splendente e nitido – sempre assoluto – di una luce da laboratorio, Ortese ripercorre, invece, la precarietà delle forme cangianti, come se in fondo l’apparire e lo sparire delle cose, portate via dai rivolgimenti dei tempi o dalle intemperie dell’animo umano, andassero riconosciute e prese come parte di una natura necessaria e inesplicabile, che porta con sé le incertezze, le sfocature dei bordi, e soprattutto le ombre dentro a cui occorre guardare: il dolore, il male, la paura, la morte.
Così è il pianto (e canto) che il Cardillo depone trasvolando tra una calda Napoli di magiche visioni e la nordica Liegi della Ragione: pura voce presaga di felicità e di sventura, di speranza e di amarezza, che passa come una eco a cui è impossibile dare direzione o senso perché raccolta tutta nel suo stesso mutare: come un tremito, una svista, un battito d’ali.
E, come diceva di Correggio lo Stendhal messo in luce da Gianni Celati, “la cosa intravista che ci sfugge è quella più vicina al nostro cuore”.
Così cala l’abbaglio vertiginoso della visione nel centro vitale di un sentire amoroso, questo sì, duro, inestinguibile, ardente, a cui si deve, sembrano dire il buon Daddo, il timido Neville, il pietoso Op, una fedeltà assoluta

