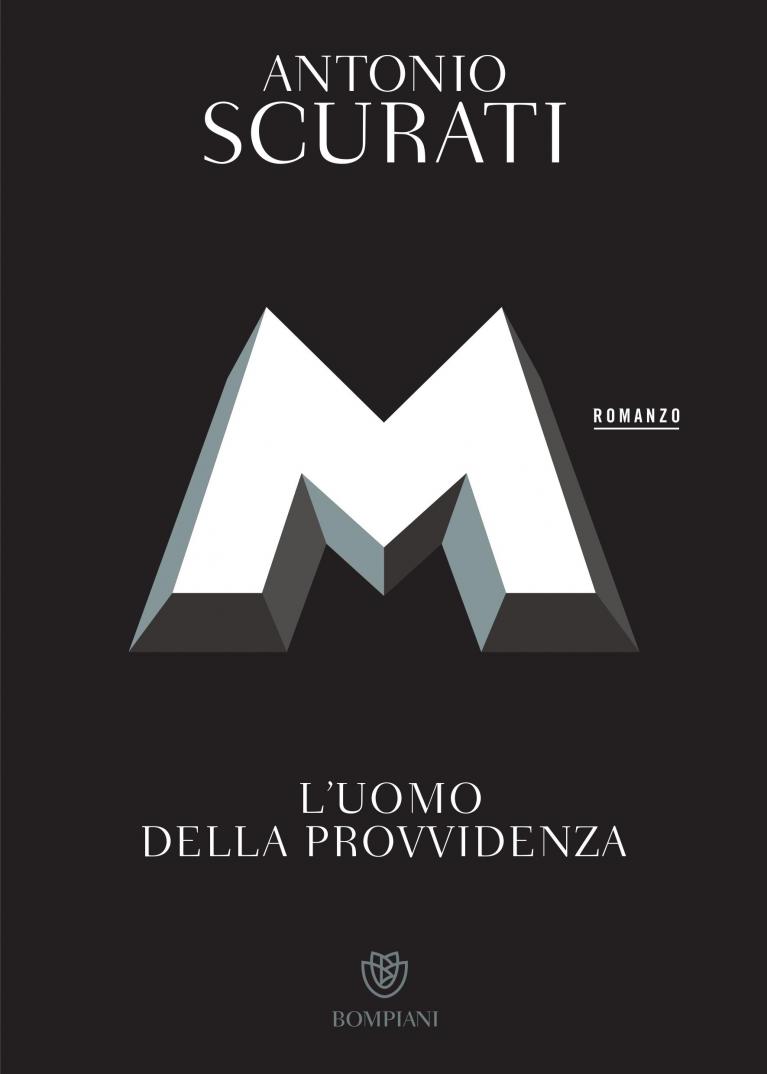Diciamo subito che dal punto di vista narrativo questa fase della vita di Mussolini è forse quella che offriva il materiale meno promettente. Il processo di consolidamento del potere non ha la suggestione «eroica» della conquista; e, d’altra parte, gli eventi più drammatici sono ancora di là da venire. Nell’insieme, però, Scurati se l’è cavata piuttosto bene. Due i suoi meriti principali. Innanzi tutto, dà giusto risalto a una zona sciaguratamente trascurata della storia patria, la riconquista della Libia: un’impresa durata quasi un decennio, durante il quale l’esercito italiano, sotto il comando del generale Rodolfo Graziani (e del governatore di turno, prima Emilio De Bono, poi Pietro Badoglio) fece uso di armi chimiche, come il fosgene e l’iprite, già proibite dalla Società delle Nazioni; inaugurò la prassi del bombardamento delle popolazioni civili, che tanta parte avrà nella Seconda guerra mondiale; e si macchiò di numerose atrocità, non solo durante le operazioni militari ma anche a guerra finita, nei campi di concentramento in Cirenaica. In secondo luogo, Scurati investe parecchio su una figura un po’ in ombra del ventennio: Augusto Turati, giornalista, schermidore, fervente ammiratore di Mussolini e segretario del PNF nei cinque decisivi anni che seguono il delitto Matteotti.
A lui si deve gran parte dell’opera di «normalizzazione» del fascismo, che in questa nuova fase deve dismettere lo spontaneismo e la violenza squadrista per assumere una fisionomia più istituzionale; non a caso, il suo principale avversario è il predecessore, Roberto Farinacci («il ras di Cremona»), che anche nella memoria pubblica più distratta è rimasto come il volto squadristico del regime. Senonché, di epurazione in epurazione, Augusto Turati finisce per costruire una macchina che finisce per stritolare anche lui. L’accentramento estremo del potere nelle mani di un despota isolato è infatti un sistema in cui le pratiche della calunnia e della diffamazione prosperano. Di qui un destino che ha qualcosa di tragico: perseguitato da accuse pretestuose e infamanti, quello che era stato uno degli uomini più potenti d’Italia viene internato in un ospedale psichiatrico.
In verità, l’aspetto più interessante di questo secondo volume consiste proprio nella galleria degli esponenti del regime: personalità molto diverse tra loro, accomunate dalla vocazione – o dalla disponibilità – a farsi strumenti nelle mani dell’uomo forte. Oltre ai già menzionati, potremmo citare Luigi Federzoni, Arturo Bocchini (il potentissimo capo della polizia), Galeazzo Ciano (che avrà ovviamente una parte di rilievo nella prossima puntata). Attenzione maggiore ci si sarebbe invece potuta aspettare per Giovanni Gentile; ma sappiamo che molto manca ancora al compimento dell’opera. Quanto alla figura mite e dimessa di Quinto Navarra, cameriere personale del Duce, è un utile spioncino per inquadrare scene private. E, a proposito, a fronte di tante caratterizzazioni riuscite non si può non segnalare l’eccesso di enfasi sulla corporeità di Mussolini: l’insistenza sugli effetti dell’ulcera duodenale è quasi grottesca. Molto più efficaci, in termini narrativi, le immagini del Duce lontano – «sempre più sordo, sempre più solo» – che ripudia o ignora o lascia andare in rovina persone fino a poco tempo prima a lui vicinissime. Analogamente, meritano una segnalazione i prelievi dai discorsi pubblici in cui fa capolino, ben prima dell’avvento di Hitler (che qui fa solo le prime, pallide apparizioni), il concetto di «razza».
Nell’insieme, anche per questo secondo volume non si può che confermare l’apprezzamento di principio già espresso sul primo. M. offre ai lettori italiani un’ottima occasione per acquisire cognizioni storiche importanti. Scurati potrà piacere o non piacere agli specialisti e ai palati fini, ma è solo un bene se, leggendolo, qualche nostro connazionale prenderà coscienza di cosa fu il patto di palazzo Vidoni del 2 ottobre 1925, o di cosa accadde nell’oasi di Cufra nel 1931; e di cosa pensavano e scrivevano a proposito di Mussolini, in quegli anni, Winston Churchill o il «Washington Post». A ciò si aggiunge l’opportunità di apprendere dettagli forse meno insignificanti di quanto d’acchito possa sembrare. Ad esempio, una delle più proverbiali frasi del Duce è un prestito dalla storia francese: «Si j’avance, suivez-moi; si je meurs, vengez-moi; si je recule, tuez-moi» aveva sentenziato nel 1793 il giovanissimo generale vandeano Henri de Larochejaquelein (sarebbe morto ventiduenne l’anno dopo). Più in generale, seguendo il corso della narrazione di M. è istruttivo verificare gli effetti di quella che potremmo chiamare inerzia storica. Una volta superate le fasi critiche, dove qualunque sviluppo sembra possibile, una volta cioè che una direzione è stata presa, cambiare strada è difficile.
L’Italia della seconda metà degli anni Venti sembra muoversi su un piano inclinato, scivola nella dittatura come in un destino inevitabile. L’opposizione è indebolita e dispersa; la macchina poliziesca funziona a pieno regime, sotto l’occhiuta regia di Bocchini; gli attentati di cui il Duce è oggetto sono goffi e improbabili, e di fatto giovano alla propaganda fascista; e quanto ai non-fascisti, sembrano paralizzati o inebetiti. Così si arriva, anche grazie all’impegno del devoto (doppiamente devoto) fratello Arnaldo, ai Patti Lateranensi. È in quell’occasione che l’arcivescovo di Praga in visita a Roma elogerà Mussolini chiamandolo «l’uomo della Provvidenza»: definizione ripetuta poco dopo da papa Ratti (Pio XI) all’Università Cattolica, e divenuta subito celeberrima.
L’acme del ventennio non è arrivata ancora, ma già si addensano ombre. Qualcosa più di un presagio è la diversa presenza di Gabriele d’Annunzio, ormai sottrattosi alla politica, e dedito a celebrare sulle rive del lago di Garda le esequie del suo mito personale, fastose e lunghissime. Ma anche Mussolini comincia a essere insidiato dai dubbi. Il 28 ottobre 1929 il Duce, spostata a Palazzo Venezia la sede del governo, è solo nell’immensa Sala del Mappamondo; mentre sceglie il posto dove dovrà essere collocata la sua scrivania è colto dall’umor nero. Il suo presente non potrebbe essere più fulgido, ma il futuro gli appare incerto. Della nazione su cui è arrivato ad imporre un assoluto dominio ha un giudizio negativo.
«Che puoi farci, domani, con questo scadente materiale umano? Con questo popolo di adulatori e di mugugnatori, di delatori accaniti, diviso tra calunniatori esaltati e calunniati avviliti, con gli avidi faccendieri, con questi famelici servi, con questi infoiati precari del presente assoluto che consumano ogni giorno come se fosse il primo degli ultimi. In vista del domani, servirebbe innanzi tutto una classe dirigente ma, per crearla, bisognerebbe fidarsi degli uomini. E tu non ti fidi. […] Nelle masse hai smesso di credere da anni, ora tocca prepararsi alla delusione delle élite». Dalle pagine di Scurati non mi pare risulti chiaro se si tratta di un moto di estemporanea tetraggine o di un’intima e profonda convinzione, più o meno consapevolmente occultata: o meglio, repressa dalla frenesia attivistica che da sempre infiamma il personaggio, dalla sua sovreccitata, testosteronica brama di comando. Ma al lettore attento non dovrebbe sfuggire che qui Mussolini – o il Mussolini di Scurati, non importa – aveva ragione da vendere. Non c’è come una dittatura per far emergere gli istinti peggiori, negli individui e nei popoli.