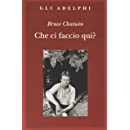Era una cosa che aveva imparato studiando le epidemie. La storia delle malattie infettive era una storia di uomini che si crogiolavano nella loro sporcizia. Osservò anche che il vaso di Pandora era un’urna di coccio del Neolitico.
“Dammi retta” – disse – “le epidemie faranno sembrare le armi nucleari tanti giocattoli inutili”.
È un breve accenno di dialogo, estratto dai taccuini di viaggio di Bruce Chatwin e riportato nel suo Le Vie dei Canti (Adelphi, 1998). Poche parole – folgoranti nel significato che sarebbe stato – in grado di mostrarci come non tutte le verità con cui abbiamo a che fare quotidianamente ci appaiano sempre riconoscibili.
Un frammento di un dialogo letterario che inaspettatamente può farsi presagio e rivelazione: “…La storia delle malattie infettive era una storia di uomini che si crogiolavano nella loro sporcizia…”.
L’impensabile si fa pensato, l’invisibile si fa visibile, l’imprevedibile diventa certo...
Poche parole in grado di mostrarci alcune delle qualità della scrittura di Chatwin, capace di muoversi tra aree culturali differenti, in grado di contaminare la letteratura di antropologia e viceversa, di storia dell’arte, di scienze naturali. Celebre in proposito la sua polemica con Konrad Lorenz (sempre in Le Vie dei Canti) a proposito dell’interpretazione evoluzionistica di alcuni comportamenti umani.
Bruce Chatwin ha operato come scrittore soprattutto negli anni Ottanta sul finire dei quali avrebbe terminato una vita troppo breve: un decennio quello non qualunque per osservare luci e oscurità dei nostri giorni.
Chi ha vissuto e in qualche modo goduto di quegli anni oggi sa che sono stati uno spartiacque esistenziale per almeno due generazioni. Quelle dei ventenni, nati in pieno boom economico e quelli che negli anni Sessanta avevano vent’anni e che in quell’ultimo decennio di consumismo sfrenato, inseguivano una seconda giovinezza. I “favolosi anni Sessanta” che venivano celebrati allora dai quarantenni non erano solo il ciclico revival di una generazione verso la propria gioventù, vent’anni dopo erano anche l’inconsapevole celebrazione della fine di un’epoca fatta di sogno di ricchezza, leggerezza dei costumi, irresponsabilità ecologica, esibizione narcisistica, cieca fiducia nello sviluppo economico perpetuo, nella tecnologia.
Cosa resterà degli anni ’80 cantava quasi profeticamente Raf nell’Italia del 1989 mentre pochi anni più tardi nel mondo occidentale, Streets of Philadelphia sarà la perfetta espressione dell’amarezza e del disincanto degli anni ’90 l’AIDS , la prima crisi finanziaria globale, la paura della terza guerra mondiale sulla crisi dei missili Cruise, l’abbattimento del muro di Berlino, l’affacciarsi della Cina sullo scenario mondiale avevano causato i primi fremiti sulle comode certezze delle generazioni nate e cresciute nel benessere consumista. Il felix Occidente che amava i Beatles e i Rolling Stones non era più tale, mentre i Rolling Stones, sopravvissuti a se stessi, potevano continuare stancamente a replicare il modello sex drug and rock&roll. Ancora per poco la musica dei padri sarebbe stata quella dei figli.
Poco più in là, Donald Trump, che in quegli anni si stava arricchendo, forse stava già pensando a loro e a Start me up – “accendi” la vita come si accende una corsa in auto, cosa ci può essere di più “boomer”, di consumatore, di anni ’80…? – per la colonna sonora della sua futura campagna elettorale.
Bruce Chatwin è stato autore che come pochi hanno segnato la letteratura degli anni Ottanta per poi, lentamente, essere quasi dimenticato. Ne è stato anche una sorta di icona, per quanto involontaria. Vita glamour nella modernissima London City, bello e biondo come un Dio, dandy, morto giovane come una rock star, bisessuale, collezionista e occasionale mercante d’arte in proprio, esperto d’arte al servizio della famosissima Sotheby’s, ripudiata ancora giovane per i viaggi e le lettere.
È stata, la sua, una scrittura sospesa tra ricerca antropologica, sensibilità da umanista, modernità dello sguardo.
In quegli anni, che hanno vissuto l’ultima fase in cui venne celebrato irresponsabilmente il trionfo della società consumistica, così come il culmine della sua arrogante inconsapevolezza, Chatwin ne diventò per certi versi involontario testimone, lui viaggiatore instancabile nel decennio in cui il viaggio diventa consumo e stile di vita da esibire. Ma oltre ogni apparenza e fraintendimento da consumatore, tutta la sua opera è stata anche un tentativo colto e insieme pop di riflettere sulla società contemporanea e i suoi mali strutturali a partire dalla sedentarietà.
Sessant’anni dopo il boom economico e “l’ultima transumanza” verso la società dei consumi, quarant’anni dopo gli anni ’80 e dopo Chatwin quei mali strutturali si sono aggravati, più acute le nostre paure e il nostro disincanto, più grandi le nostre incertezze.
Tradiscono i decenni cantava Amedeo Minghi nel 1998; espressione che può essere sintesi poetica non solo della memoria legata alla perduta giovinezza ma dove si può leggere anche la continuità che ci lega a un malessere che deve avere radici lontane. E se in una strofa la canzone pare alludere proprio agli anni Ottanta e ai suoi “valori” – Decennio che volò Nell’auto e sulla moto Su quei modelli andò Stilistico volò – è in realtà in una continuità di più lunga durata dove è necessario cercare ragioni…sempre sperando nei rimedi.
Del resto, i cocci del vaso di Pandora a cui Chatwin alludeva sembrano ancora tra noi – spesso ignorati, talvolta drammaticamente evidenti…– perché il mito non scherza, il mito, invisibile, digerito in innumerevoli generazioni è letteratura profonda, la sola che riesce a sussurrare qualcosa ai geni della nostra specie.
Bruce Chatwin visse certamente gli anni dell’effimero, della moda, del glamour, delle piste di cocaina, degli amori promiscui e del trionfo consumistico, ma la sua sensibilità era rivolta anche indietro e all’essenziale; lì ha talvolta saputo riconoscere la storia profonda e le verità del mito, del mito che si confonde con la specie…
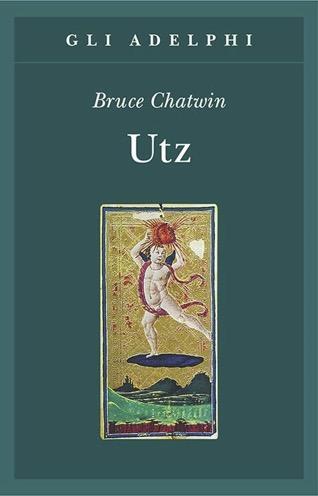
Nel 1988, un anno prima della sua morte, Bruce Chatwin consegnò alle stampe un piccolo romanzo, Utz, storia di un collezionista di maioliche di Meissen. Un collezionista che accumula e difende i suoi tesori nella Repubblica Sociale Cecoslovacca. Letto pochi anni più tardi non mi aveva particolarmente impressionato, diverso dai suoi libri di viaggio, colti e zeppi di suggestioni.
Solo in seguito mi è stato evidente come quel romanzo potesse essere una sintesi della sua vita e di altro ancora. Le forze residue che l’AIDS gli aveva lasciato forse consentirono solo quelle pagine ma comunque sono state un ultimo tentativo di narrare i temi, gli interessi, le stesse contraddizioni della sua vita.
Oggi la vedo diversamente; credo che in realtà quel libro abbia a che a fare con l’esistenza di tutti.
È possibile pensare che per Chatwin raccontare la vita e le ossessioni di un collezionista sia stato anche parlare delle sue. L’interesse per l’arte e la frequentazione di collezionisti è stata del resto la sua prima esistenza, esperto d’arte presso Sotheby’s, lavoro infine ripudiato per i viaggi, le lettere e un interesse pervasivo per il mondo nomade.
Le lettere, già… come nella scelta del nome del protagonista del romanzo, probabilmente non casuale, Utz ha infatti lo stesso suono di Uz, la regione da cui proveniva Giobbe. “C’era nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe: uomo integro e retto, temeva Dio ed era alieno dal male. Gli erano nati sette figli e tre figlie; possedeva settemila pecore e tremila cammelli, cinquecento paia di buoi e cinquecento asine, e molto numerosa era la sua servitù. Quest’uomo era il più grande fra tutti i figli d’oriente” (Giobbe 1,1-3).
Uomo timorato e benestante, benedetto dal signore, ma talmente ricco di possedimenti da essere già in odore di sedentarietà, lontano dalle tende scure dei pastori nomadi e dei patriarchi. Pensando all’ossessione di Chatwin per il nomadismo o alle sue contraddizioni, compresa l’attrazione per la ricchezza, la scelta di Uz non pare casuale.
E poi in quel libro dell’antico testamento sembra quasi materializzarsi la cupidigia alla base di ogni ricchezza e di ogni collezionismo, come l’attitudine alla brama di possesso che l’antico testamento associa alle civiltà sedentarie già a partire da Caino.: “…Una terra, da cui si trae pane, di sotto è sconvolta come dal fuoco, le sue pietre contengono zaffiri e oro è la sua polvere…e su quanto è prezioso posa l’occhio: scandaglia il fondo dei fiumi e quel che vi è nascosto porta alla luce” (Giobbe 28, 5-11).
In un testo del IX sec. a.C dove il mito si confonde alla religione (Giobbe sarebbe uno dei libri più antichi del Vecchio testamento), è sotto il suolo “da cui si trae il pane” ed è nel rame, argento, oro, berillio, zaffiri, cristalli e topazi d’Etiopia che si materializzano altrettanti oggetti della cupidigia umana.
Utz/Uz dunque potrebbe essere una metafora delle contraddizioni dell’autore prima di essere la storia di un personaggio di finzione.
Ma perché Chatwin avrebbe scelto la storia di un enigmatico e oscuro collezionista dell’Europa dell’Est per le forze che gli rimanevano e per il suo epitaffio culturale?
E se Utz/Uz non fosse nient’altro che una metafora profonda sotto la cui ombra siamo tutti compresi?
E se la condizione di Utz, il collezionista di porcellane di Meissen, fosse in realtà in grado di rivelare qualcosa di noi… di tutti noi?
Che altro potrebbe essere?
In un libro del 2012 Elio Grazioli (La collezione come forma d’arte, Johan & Levi editore) racconta magistralmente la natura delle collezioni e dei collezionisti attraverso le diverse epoche. Fin dall’inizio l’autore mette in chiaro la caratteristica di ogni vera collezione che non è tanto possessiva quanto creativa “…Possiede il carattere degli organismi complessi, non riducibile alla somma delle loro parti fino agli equilibri instabili… passando per il ruolo attivo del posto vuoto… del pezzo mancante…”
Un processo creativo quello del collezionista che a differenza dei musei e delle collezioni pubbliche gode di una più ampia libertà e che in ogni serie di oggetti sa riconoscere “…dell’arte che c’è in ogni disciplina, di nodi che si creano fra gli ambiti di studio, della loro forma della bellezza e del senso che sconfinano dallo specifico e non si pongono come modello ma come incontro sul percorso…”

Negli ultimi tempi, avvicinandosi la fine, Chatwin accumulò e tentò di accumulare una sorta di “madre di tutte le collezioni”, tra gli oggetti preziosi un bracciale dell’età del bronzo, un pezzo del Forte Rosso, un bozzetto in cera del Nettuno del Giambologna; un coltello inglese di giada di origine preistorica; un’ascia norvegese di selce, un’incisione di Giorgio Ghisi, XVI secolo, intitolata La malinconia di Michelangelo, un altare portatile del XII secolo proveniente da Losanna, una collezione di abiti di Fortuny degli anni Venti; un arazzo medievale; un calamaio di tartaruga della dinastia Han, un Cézanne del Mont Sainte-Victoire quasi tutto bianco…” (N. Shakespeare, Bruce Chatwin, Baldini & Castoldi,1999)
È una raccolta apparentemente confusa ed eterogenea in cui si fa fatica a intravedere il filo conduttore, l’idea di bellezza che l’attraversa.
Perché accumulare oggetti tentando di dare un ordine alla bellezza è in fondo ricerca, ossessione e malattia estrema di ogni collezionista, quando il dare ordine alla natura e al raccolto, al bisogno di cibo, dare ordine alle stagioni è stato forse l’origine del tutto.
Perché la rivoluzione neolitica non fu solo un modo più sicuro per rispondere alla necessità di sicurezza alimentare e l’agricoltura, rendendoci sedentari, non ci ha consentito solo un relativo controllo sul cibo e sulla natura. Sfumava contemporaneamente l’importanza del presente, se la soddisfazione dei bisogni dipendeva da come avremmo gestito il futuro che apparteneva alle stagioni; programmare il tempo è stata la vera rivoluzione del Neolitico, l’ossessione del tempo è stata sua conseguenza, virus subito evidente che si è nascosto nel Dna di ciò che chiamiamo civiltà.
Utz, attraverso la sua raccolta di porcellane di Meissen, come qualunque collezionista, dal più grande al più vicino a noi, a noi stessi, non insegue una semplice brama di possesso.
Incapace di godere dell’esperienza della bellezza come condizione effimera, come sentimento “distillato” dell’esperienza del solo presente, il collezionista è il vertice di una condizione da cui siamo tutti abbracciati. Collezionando inseguiamo nel tempo il tentativo di dare alla bellezza un ordine duraturo quanto personale: è questa una straziante contraddizione, invisibile per i più, che ci riporta alle origini del modello che ancora abbracciamo e di cui coltiviamo insospettabili eredità, laggiù dove tutto ebbe origine, quando il vaso di Pandora appariva ancora chiuso, quando insieme alla natura dovemmo e volemmo controllare il tempo, quando il senso dell’effimero, lentamente, poté farsi ingombro, persino ostile .
Quando il tempo rimasto ormai era poco, lontano dagli antichi sentieri e dalle “vie dei canti”, è anche su questi percorsi che Chatwin si è forse inoltrato, perdendosi o ritrovandosi.