C’è poi la variabile spaziale, per cui, come noto, gli amori a distanza possono essere più febbrili (ma anche più caduchi) e conoscono problemi specifici. Quando vola lei, da Parigi, dove vive, alla Chicago di lui: «Prenderò il diretto Parigi Chicago il 6 sera e arriverò il 7 alle 18 (ora di Chicago). Non venire all’aeroporto, ci saranno un sacco di formalità noiosissime, non vorrei sentirti lì accanto senza poterti vedere, e poi un aeroporto non è un bel posto per il ricongiungimento di un marito e di sua moglie. Se ti va aspettami a casa con un whisky buono, prosciutto e marmellata, perché avrò sete, fame e sarò stanca. Prendi anche parecchio amore, tutte le casse e le bottiglie del migliore amore del posto che puoi comprare dal droghiere ». Quando vola lui, di ritorno negli Stati Uniti dopo alcuni mesi passati insieme in Europa: «Ho ricevuto il tuo telegramma; grazie amore mio, mi fai togliere un peso dal cuore. Certo che era piacevole fantasticare su di te che volavi oltre le nuvole bianche, ma non molto rassicurante, mi veniva la nausea e solo dopo il telegramma ho ricominciato a respirare normalmente».
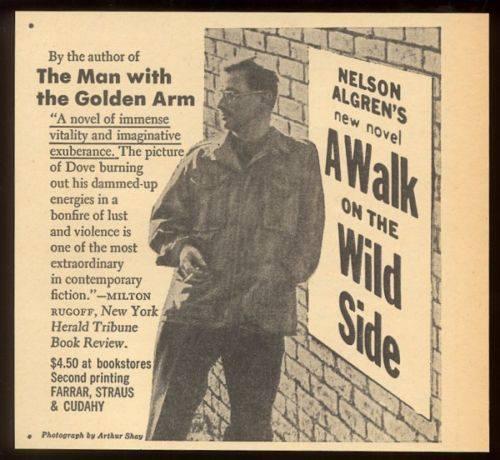
Se fin qui siamo più o meno nell’ordine del precetto virgiliano «amor omnibus idem», stacca però in modo netto l’elemento letterario. Senza di esso, di questa storia non si può dir niente, o, ancora peggio, si rischia di psicologizzare in modo ingenuo quella specie di guerriglia letteraria con cui due degli scrittori più importanti del Novecento hanno creato una mitologia subdola e malinconica della loro vita di amanti, una mitologia che compone finzione e autobiografia, privato e pubblico.
D’altra parte, nei primi anni della loro prossimità – i più ardenti e ottimisti, stando a questa mitologia – ognuno ha covato e partorito il proprio lavoro più importante. Nel 1949 Nelson Algren pubblica il romanzo The Man with the Golden Arm, che nel ‘50 gli varrà il sommo National Book Award for Fiction, premio creato proprio quell’anno. Sempre nel 1949 Simone de Beauvoir dà alle stampe i due tomi di Le deuxième sexe, che tra ondate d’indignazione in Francia e in tutto l’Occidente la consacrano «faro indiscusso» della filosofia femminista. (Quando cinque anni dopo de Beauvoir vince l’altrettanto sommo Prix Goncourt, con il romanzo Les mandarins, questo trionfo subirà il contrappasso di una reazione non buona di Algren; ma ci torneremo tra poco).
Lui, Algren, che in America è stato di recente riletto in una corposa biografia, Never Lovely So Real (Colin Asher, Norton and Company, 2019, 543 pp.), ha uno stile ascetico e visionario: quando si conoscono, la scrittrice lo attira subito, ma nel frattempo ne diffida perché ha in mano una copia della Partisan Review, una rivista letteraria che per lui emana «il tanfo di una macelleria di cui sia morto il padrone». Lei, “il faro” de Beauvoir, è altrettanto asciutta, ma più didascalica: «Nelson possedeva quel dono rarissimo che definirei bontà, se questa parola non fosse stata così bistrattata: diciamo una vera preoccupazione per gli uomini».
L’incontro avviene il 21 febbraio del 1947, a Chicago; Algren ha 38 anni, de Beauvoir 39. Lei è negli Stati Uniti per un ciclo di conferenze sul rapporto tra intellettuali e dopoguerra; gli telefona su suggerimento di una conoscente comune (Mary Guggenheim) ed escono in giro per la Chicago notturna, che di Algren è l’ambiente e la fonte d’ispirazione per i suoi romanzi. In particolare è legato ai bassifondi del quartiere polacco, ai locali del bebop nero, gioca duro a poker e a dadi e perde altrettanto duro, adora il pugilato, molti suoi amici sono eroinomani, psichiatrici, vivono prostituendosi e strabevono. De Beauvoir si dice rapita, e tra loro nasce un amore che è sia una relazione erotica che un dialogo intellettuale, tutto basato sulla permanenza nel piccolo appartamento di lui, su Wasanbia Avenue, molto presto per entrambi «casa nostra». Le circostanze del loro risiedere così lontani lungo la maggior parte dell’anno sono, in quell’epoca, ancora più onerose di quanto lo sarebbero oggi: si vedono otto volte in tutto, per periodi di qualche settimana, all’inizio, e più avanti di mesi. Lei va da lui (più spesso), lui va da lei (due volte), e fanno insieme tre viaggi epici in cui visitano l’America centrale, una parte dell’Europa mediterranea e del Nordafrica.
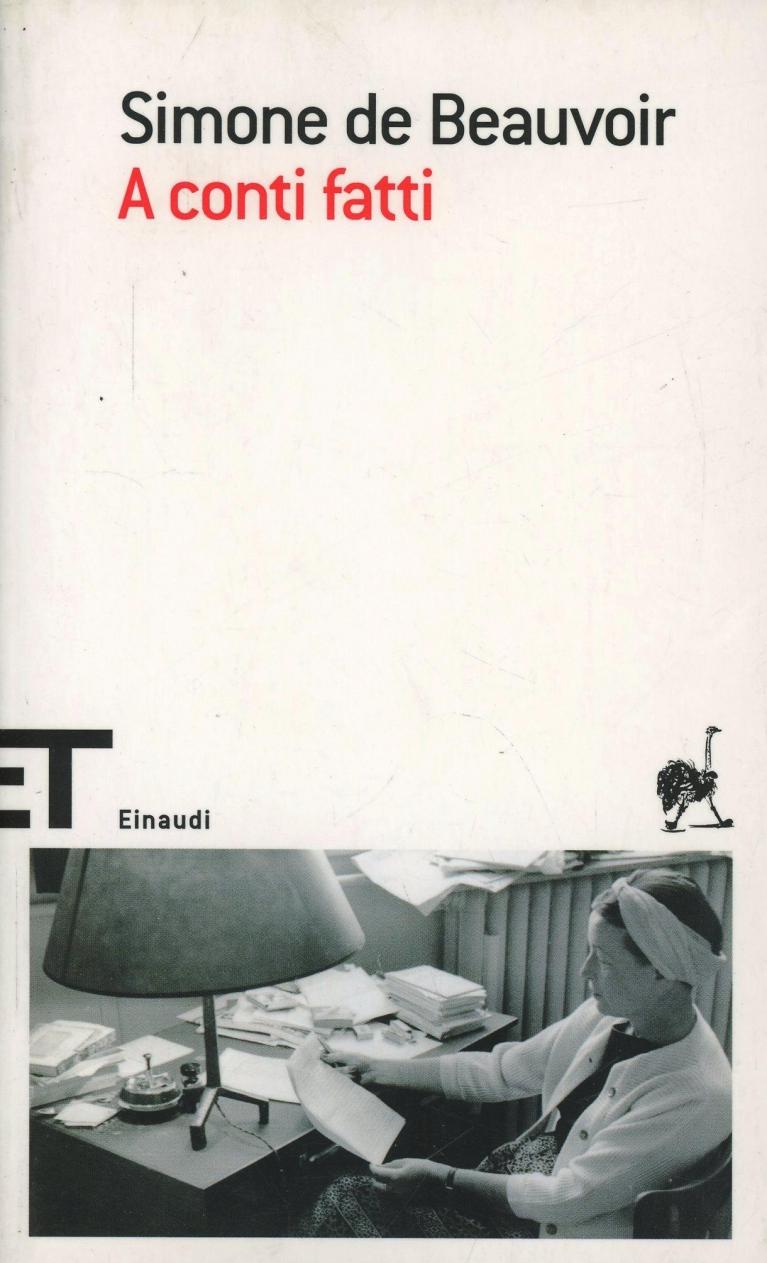
È stato scritto molto sulla differenza tra le inclinazioni e le biografie. Lui, che ha alle spalle una gioventù di mille lavori precari e vagabondaggi, più una pessima capacità di autopromuoversi, sarà riconosciuto come l’esponente più bravo della cosiddetta American Proletarian Literature (nelle memorie di lei, anni dopo, piuttosto un «proletario delle lettere»). Lei, borghese fino alla punta dei capelli per natali e formazione, viene (indegnamente) illustrata da un giornale statunitense come «la più bella esistenzialista che si possa immaginare» (per lui, più tardi, diventa l’autrice letta malvolentieri di saggi che sono «come mangiare cartone»). Su Algren, i giudizi sono di un uomo «nevrotico», «più pronto a picchiare che a parlare», «molto bello sul piano spirituale, ma con il complesso di Cristo». Il “faro” non è meno chiacchierata, ma per altre debolezze: per Mary McCarthy è «odiosa, una mente del tutto borghese rovesciata», mentre in un saggio breve sui due amanti Fernanda Pivano la dipinge egoista, entrante, impegnata a trovare al suo uomo americano «stomachevoli nomignoli» (lo chiamava Coccodrillo, Mio amato marito, Mio dolcissimo mostro, Mio giovane provinciale, ma non molto spesso).
Eppure la loro mitologia fa trasparire una tendenza costante a compenetrarsi, politicamente, letterariamente. Algren ha lavorato come cronista giudiziario: sempre nel ‘47, porta de Beauvoir a vedere da dentro il penitenziario della contea. Qui, nel reparto dei condannati a morte, la scrittrice apprende che a ogni esecuzione «quattro guardie premono quattro bottoni: solo uno dà la morte e nessuno sa quale sia. Così nessuno sa chi ha veramente ammazzato il condannato». Tinte forti che lei riproduce, a modo suo, nelle lettere da Parigi: gli racconta che ha dato una festa in cui tutti sono finiti sbronzi marci, Giacometti e Boris Vian per primi, e che quando il giorno dopo è tornata a riprendere la borsa un portiere le ha chiesto se non «volesse l’occhio, dato che fu trovato un occhio». Era l’occhio di vetro di un amico di Vian, che la sera prima se l’era tolto per farlo vedere a qualcuno e poi lo aveva dimenticato sul pianoforte.
Inoltre, De Beauvoir e Algren si consigliano sulle bozze dei propri scritti; lei si adopera molto per far tradurre in francese i primi lavori di lui e poi The Man with the Golden Arm (lo tradurrà Vian); infine, si confrontano in modo indefesso sui classici, sulle uscite letterarie, cinematografiche, sulla politica statunitense e sulla filosofia politica – Algren è un ebreo laico che ha rinnegato le sue origini, e avrà problemi con l’FBI perché negli Anni Trenta è stato molto vicino al Partito Comunista –.

Purtroppo, di modi e ragioni per chiudere una storia pare ce ne siano tanti o persino di più di quelli immaginabili per aprirne. L’idillio tra lo scrittore e “il faro” si stempera, dice la mitologia, quando nella relazione subentra un terzo regime, più pericoloso di quello programmatorio e di quello fusionale. Ovvero quando cominciano gradualmente a manipolarsi. Lui la implora di vivere insieme per sempre, sposati, negli Stati Uniti, e le fa capire che non potrà continuare a sentire senza la soddisfazione di questo bisogno; lei lo supplica invece di andare avanti, nonostante non possa lasciare Parigi, non possa «dargli tutto». Il fondale della scena vede apparire l’ingombrante figura di Sartre (che ad Algren, quando l’ha conosciuto, ha ricordato «un negoziante di scarpe da quattro soldi, sull’orlo del fallimento»), il quale Sartre comunque nel frattempo è alle prese con una corrispettiva proposta di matrimonio avanzata dalla propria amante Dolores Vanetti. Compaiono anche una breve relazione di Algren e un paio di altre sue amiche di letto; poi è la volta della meno passeggera ex moglie, con cui lo scrittore proverà a sposarsi di nuovo. Ultimo arrivato, Claude Lanzmann, all’epoca ventisettenne, con cui de Beauvoir inizia una relazione (non mancando d’informare Algren della propria inaspettata fortuna).
Il mito si forma qui, all’intersezione di una serie di atti manipolatori che cominciano a tracimare copiosamente dal privato al pubblico. De Beauvoir romanza la loro storia in Les mandarins (lo chiama “Lewis Brogan”, ma poi con una metalessi alla Genette dedica il romanzo proprio «à Nelson Algren»); dieci anni dopo, in La force des choses, adotta un realismo autobiografico integrale, racconta di loro due lasciando intatti i nomi e inserisce nel corpo del testo stralci delle lettere ricevute da lui. Algren ha reazioni molto dure: la schernisce in interviste e recensioni feroci, dipinge lei e Sartre come fantocci di un collasso ridicolo tra vita, letteratura e attivismo politico. Per ultimo, come gesto di risentimento supremo, vende all’asta le trecentoquattro lettere che lei gli ha scritto. Dal sodalizio ha preso vita una schermaglia pubblica in cui ognuno deve dimostrare che ha dato meno. È a questo punto, sotto questa luce assunta dal rapporto ormai storicizzato, che Julia Kristeva può scrivere che per le sue scelte filosofiche de Beauvoir dovette «sfuggire alla tentazione della vita coniugale e della maternità paventata da Algren»; ed è a questo punto che alcuni cronisti hanno potuto denunciare come la memoria di un grande scrittore fosse stata adombrata dal suo essere, per l’amante celeberrima, solo «una storia di letto». Concordare con queste semplificazioni tuttavia appare pericoloso: forse, in un rapporto (soprattutto) tra scrittori, manipolarsi è consustanziale, forse Algren e de Beauvoir ne sono un esempio eloquente. Non va dimenticato che dai loro spostamenti in Nord America e in Europa ognuno trasse un saggio (lei L’Amérique au jour le jour, lui Who Lost An American?), diversi articoli, e infiniti spunti e opportunità – incluse le tarde recensioni al vetriolo firmate da lui, che per un periodo di esse viveva –. La manipolazione ha dei colpi di coda postumi. Nel 1997 la figlia adottiva di de Beauvoir, Sylvie Le Bon de Beauvoir, cura l’edizione francese delle trecentoquattro lettere, fino a quel momento custodite nell’archivio dell’Ohio State University Libraries (Lettres à Nelson Algren: un amour transatlantique 1947-1964, Gallimard): è stata de Beauvoir stessa ad autorizzare il lavoro, fornendo in questo modo una risposta più che dignitosa alla vecchia provocazione di lui che le aveva vendute. Ma manca ancora l’ultimo contrattacco: quando la curatrice chiede agli agenti americani di Algren di poter pubblicare anche qualcuna delle lettere firmate dallo scrittore (che sono già in mano sua), questi negano in modo categorico. Male, chiosa Le Bon nell’introduzione del volume, perché le lettere di Algren avrebbero «gettato una luce inedita, intima, sulla verità della sua vita di scrittore e di uomo». Male o meno, senza dubbio questa censura taglia la storia in un certo modo, ne disegna una versione e ne esclude molte altre. Chissà che le cose non cambieranno prima o poi.

Programmi, fusioni e manipolazioni: Algren e de Beauvoir hanno avuto infine molto poco di un altro, ultimo elemento piuttosto comune nelle storie d’amore. Il caso. Nella loro, l’aleatorio, l’imprevedibile, quella figura che per gli amanti assume spesso, con Barthes, il carattere di uno «spettacolo delle implicazioni» o meglio rientra nelle «evidenze sbalorditive» sembra aver avuto scarso peso. Salvo forse per un aspetto, verso la fine. L’8 maggio del 1981 Algren è in procinto di festeggiare la sua elezione a membro dell’American Academy and Institute of Arts and Letters. Un giornalista va ad intervistarlo a casa sua e, nella camera spoglia, Algren gli mostra la scatola di latta che contiene le lettere di de Beauvoir. Pare che l’interlocutore faccia fatica a mantenere l’attenzione di Algren sul romanzo che ha appena finito, perché sedici anni dopo le sue ultime frecciate, lui ora si prodiga, più volentieri, in una nuova lunga e accorata accusa della sua amante. Spiega qui che ha accettato di vendere le lettere – e a Fernanda Pivano, in un commento di quell’episodio, non sfugge che deve essere un gesto legato a «un’assoluta povertà» –. Poi Algren si lamenta: la scrittura è «una cosa seria, non consiste solo nel tirar fuori vecchie lettere d’amore che avrebbero dovuto restare dove si trovavano».
Ma è lo stesso Algren che «riesce a lavorare solo sul campo», perciò è andato a vivere sopra l’appartamento dove si è compiuto l’omicidio al centro del suo romanzo, lo stesso Algren che scrive di questa vicenda «con le viscere», lo stesso che si appresta a vendere trecentoquattro lettere di una corrispondenza estremamente intima, mentre de Beauvoir ne ha fatto un uso sotto molti aspetti ben più professionale. In alcune delle pagine più belle di Les mandarins lei aveva cristallizzato questo paradosso in due battute di lui. Lewis dice: «Che si menta o no, la verità non la si dice mai… questa è la peggior bugia: fingere che ci diciamo la verità». Sempre secondo Pivano, Algren era uno scrittore che scriveva solo di tradimento. L’intervista dell’8 maggio dell’‘81 è forse la più complessa e paradossale dichiarazione di Algren sul vero, il verosimile, il rapporto tra pubblico e privato, il lavoro dello scrittore, e il rapporto con l’amante. Ma è anche l’ultima, perché nella notte che segue verrà stroncato da un infarto, tradito da una cardiopatia curata male.

