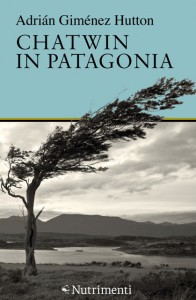“Bruce Chatwin, quando l’ho conosciuto, aveva l’aria di un rappresentante d’altri tempi di Sua Maestà britannica. Aveva un che di imperiale, o forse di imperioso. Tra il sobrio ma sorridente ambasciatore di Sua Maestà e il conquistatore di bottino. Haltung, direbbero i tedeschi. Portamento. Posa. Decisione. Il prototipo dell’europeo che mette piede sulla terra coloniale. Non come un Francisco Pizzarro, allevatore di maiali e bestie cristiane. No, un vero e proprio gentleman. Guanti bianchi, sorriso, simpatico, sangue freddo. L’inchino davanti a una dama. La stretta di mano guardando negli occhi di fronte a un uomo. Un gentleman che ha fiutato un buon bottino”.
Così comincia la descrizione di Bruce Chatwin fatta da Osvaldo Bayer in un articolo pubblicato su Página 30 nell’agosto del 1997 come parte del “Dossier Chatwin” scritto per la rivista. Bayer non cela la sua antipatia per l’autore, e neanche una punta di irritazione nei confronti di sé stesso per l’attenzione che gli aveva prestato sul momento.
Chatwin gli fece visita appena arrivato in Argentina, per chiedergli informazioni sulla Patagonia. Bayer descrive così il loro primo incontro: “L’uomo del primo mondo mi fa notare di non avere molto tempo. Per questo è così preciso con le sue domande e a descrivermi i suoi interessi, interrompendo il suo interlocutore quando divaga dal tema che interessa a lui. Niente pregiudizi per la storia del time is money, ma in genere questi intellettuali del terzo mondo sono chiacchieroni, vogliono dirla tutta ai loro ospiti, scoprirsi, denudarsi davanti al Sir, che non smette mai di essere il Sir… Mi sta di fronte. E pronuncia la parola magica: Patagonia, e mi guarda con un largo sorriso. Oh, yes! Gli hanno dato il mio nome e vuole conversare. L’unica cosa è il tempo. Time, poco. Molti impegni. Si fa una risata. Ma è disposto a fare un viaggio in Patagonia. Non solo a leggere sulla Patagonia. Due, tre, qualche settimana se è necessario e ne vale la pena. Vuole libri, bibliografia. Sì, libri, niente documenti. No, niente antropologia o etnologia. Preistoria? No, tolto il ritrovamento di qualche animale antidiluviano. Leggende? Yes. Sì, leggende sì. Ecologia? No, no. Viaggiatori, leggende, aneddoti, donne, indios, sì, ma più avventura. Sì, bandoleros e storie di estancieros. Scioperi. Ah, scioperi! Ma… con anarchici? Oh, allora yes, fantastico. Cowboys, oh yes, yes. Mi parla di una cattedra in un’università dell’Arizona esclusivamente sui cowboys. Si porta via i libri di Abeijón, alcuni numeri dell’Argentina Austral, Armando Braun Menéndez, articoli collezionati da me del ‘cronista a cavallo’, don Gorraiz Beloqui, Elías Chucair, e tutto ciò che era emerso dai ricordi patagonici. Inoltre gli do l’indirizzo del negro Juárez, l’uomo che ne sa di più sulle avventure dei cowboys nordamericani della Patagonia, poiché ha trascorso cinquant’anni della sua vita – almeno – a indagare perfino sul numero di scarpe che calzavano. E naturalmente i primi tre volumi di La Patagonia rebelde, che allora era uscito con il titolo Los vengadores de la Patagonia trágica. Il quarto volume lo leggerà in Europa.
Se ne va con una valigetta, un pacco e una borsa di nylon con i miei libri. Quasi uno scaffale della mia biblioteca patagonica. Tornarono tutti, meno che quelli che si perdono sempre. Quando ripasso i libri e vedo cosa manca, lo immagino ancora con l’uniforme di Sua Maestà britannica”.
Il secondo incontro avvenne a Parigi, nel salone di un hotel, accompagnato da Héctor Olivera, il regista del film La Patagonia rebelde. “Erano passati dei mesi. Io ero in esilio. Nel frattempo venni a sapere che Bruce Chatwin era direttore del supplemento culturale del Times. […] Voleva fare un film sui cowboys nordamericani in Patagonia. Divagammo sul tema fino a quando non trovai l’occasione per parlargli del suo libro In Patagonia. Gli dissi che aveva fatto un ‘affascinante’ riassunto dei libri che gli avevo passato e che, in gergo giornalistico, era uno straordinario ‘cuoco’. Ossia qualcuno che prende le narrazioni di altri, una cosa qui, una cosa là, prende il prosciutto dal panino e, urrà!, il best seller è servito. Più che un cuoco era un perfetto chef di cucina giornalistica… Visto che aveva scritto assemblando il faticoso lavoro di indagini di autori locali argentini, poveri e sconosciuti, che nella loro vita non avevano mai visto uno spicciolo per le loro fatiche, gli proposi di donare almeno il dieci per cento delle sue succulente royalties alle biblioteche delle piccole città della Patagonia, regione che, a quanto pare, patisce persino il più sofisticato sfruttamento delle proprie risorse. Mi rivolse uno sguardo sovrano, che tradiva compassione: il miglior sorriso, assieme a un non so che di fastidio che ho visto disegnato sulle labbra degli esseri superiori. E nello sguardo, ironia. Non si degnò di rispondermi e non lo rividi mai più”.
questo brano è tratto dal volume di Adrián Giménez Hutton “Chatwin in Patagonia”, pubblicato da Nutrimenti (2015), nella traduzione di Luigi Marfé e Marino Magliani
dalla presentazione del volume della casa editrice Nutrimenti:
Con In Patagonia, il libro nel quale Bruce Chatwin racconta l’itinerario che dal dicembre del 1974 fino al marzo dell’anno successivo lo condusse all’estremo Sud del continente americano, il grande viaggiatore britannico è diventato un autore di culto, che ha cambiato per sempre l’idea di letteratura di viaggio. Vent’anni dopo, Adrián Giménez Hutton ha messo alla prova la verità di quel diario, ripercorrendone le tappe e cercando di rintracciarne luoghi e personaggi.
Dopo due anni e quasi diecimila chilometri sulle tracce di un vagabondo scaltro a confondere i propri passi, senza tralasciare nessun incontro e nessun dettaglio (la ricerca della pelle del milodonte, la baracca di Butch Cassidy, la leggenda della Città dei Cesari, le spedizioni di Magellano e Darwin, la storia dell’indio Jemmy Button, la colonia missionaria del reverendo Bridges, il fiordo Última Esperanza), l’inseguimento ha preso la forma di un volume, che è nello stesso tempo un indimenticabile affresco di quell’estremo lembo di mondo e un ritratto del suo narratore più famoso.
Se per Giménez Hutton la stesura di questo singolare libro è stata soprattutto l’occasione per calcare le orme di un mito, per il lettore odierno si tratta di ritornare all’opera di Chatwin, e rivisitarla ormai a quasi quarant’anni dalla sua uscita. Questo non è un libro critico nei confronti di In Patagonia (anche se spesso ne sottolinea le incongruenze) né un libro che lo esalta. È il resoconto di un viaggio che ripercorre un altro famoso viaggio: pagine che rievocano, nel fluire degli episodi e delle voci, la lunga storia delle esplorazioni in Patagonia, sovrapponendo ai luoghi reali lo spazio immaginario dei libri che in quella regione hanno intravisto il simbolo di un altrove assoluto e irraggiungibile.
Del resto, pare suggerire l’autore, il significato di un racconto di viaggio non si risolve mai semplicemente nei suoi aspetti documentari. E in questo libro, come in quello di Chatwin, oltre al diario si scopre un’appassionata elegia della lontananza, una preziosa collezione di destini tanto inverosimili quanto reali, segretamente legati da una medesima condizione esistenziale: quella di chi si sente a casa solo lontano da casa.