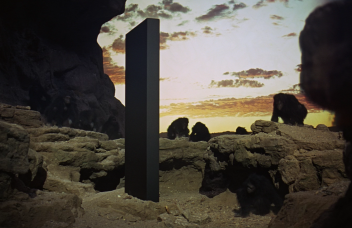In queste circostanze abbiamo la tentazione e la tendenza a metterci “fuori di un determinato gioco”, come direbbe Wittgenstein. Vorremmo quasi essere fuori, almeno temporaneamente, da quel gioco linguistico e di azione di cui siamo ineluttabilmente parte e di cui, tra l’altro, vogliamo essere parte, perché la compagnia degli altri ci rassicura. L’ordinario ha una sua “forza” intrinseca e magneticamente ci attrae e riporta a sé. Eppure, allo stesso tempo, l’insoddisfazione spinge in noi verso qualcos’altro, oltre ciò che già esiste e ci contiene e costringe. In questo gioco senza fine, nella maggior parte dei casi a vincere è il ripiego sull’esistente, la normatività dell’ordinario. La nostra propensione ad estendere al di fuori dai limiti segnati dall’ordinario le nostre scelte; la nostra tensione ad occupare una prospettiva esterna sopraelevandoci dalla contingenza, nella maggior parte dei casi è risucchiata dal conformismo. Bisogna, naturalmente, chiedersi perché le cose vanno così. Abbiamo alle spalle un lungo retaggio di paure ancestrali e di ricerca di rassicurazioni. Tra tutte le possibili fonti di rassicurazioni, la consuetudine è ai primi posti. Quando dobbiamo cambiare qualcosa nelle nostre vite, si affaccia subito la forza dell’abitudine e ci presenta il suo conto. Se non si pensa l’impensabile certamente non lo si scoprirà. Eppure pensarlo è impegnativo, inquietante e per certi aspetti doloroso. Da un punto di vista cognitivo, come mostrano molteplici esperimenti, ognuno di noi di fronte a una scelta tra conservazione e innovazione, in ben due terzi dei casi, propende per la conservazione, anche quando è evidente che quella scelta produrrà esiti indesiderabili. In Ululare con i lupi Gaburri e Ambrosiano propongono il concetto di “identificazione a massa” (E. Gaburri, L. Ambrosiano, Ululare con i lupi. Conformismo e réverie, Mimesis, Milano 2014). Nell’identificazione a massa l’individuo accetta una serie di credenze, aspettative, desideri, speranze, supponendo che corrispondano a una realtà oggettiva, ma che in realtà sono influenze, condizionamenti e imposizioni sul suo meodo di essere e vivere. In quelle situazioni l’individuo rinuncia al proprio modo di vivere ed essere personale e si consegna al condizionamento e alle suggestioni degli altri. L’identificazione a massa, d’altra parte, risponde al bisogno di evitare il terrore che ogni individuo prova a sentirsi separato dagli altri, dal gruppo di appartenenza e dalla massa stessa. Secondo Freud “è palesemente rischioso opporsi, e ci si tranquillizza adeguandosi all’esempio che si mostra tutt’intorno, e magari addirittura ululando con i lupi” (S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’io, Opere, volume 9, Boringhieri, Torino 1977; p. 275). Stare nella massa ed essere ad essa conformi permette di mantenere in vita la speranza di poter essere tutti amati ugualmente; una speranza delirante di poter essere trattati secondo un giudizio uguale per tutti. Nel calore tiepido della massa si produce anche la comodità apparente della negazione di ogni conflitto: quella negazione è una delle principali fonti del conformismo. Ne I fratelli Karamazov, Dostoevskij tratteggia, per bocca del Grande Inquisitore, la disposizione dell’uomo al bisogno di sicurezza e non della libertà; la propensione a stare in un gruppo, nella religione, nel partito, segnalando così che l’uomo si sente più sicuro nel gregge, “more pecorum”, come aveva sostenuto Seneca. Per la via dell’appartenenza totalizzante come strategia per affrontare l’ansia della solitudine si può giungere persino a creare condizioni illusorie ma molto efficaci di negazione della caducità e della morte, fino alle pratiche di suicidi collettivi, come accade in certe sette. Anche senza ricorrere ad esempi di situazioni estreme, molto più diffusa è la propensione ad essere conformi agli altri nella vita quotidiana ordinaria. È soprattutto nella nostra esperienza di ogni giorno che facciamo i conti con il conformismo e con la sua forza, cioè con la sua influenza nel vincolare la nostra capacità generativa e creativa dell’inedito. Una domanda ci può aiutare: se siamo effettivamente capaci di estendere l’uso e il significato delle parole, e di fatto li estendiamo, come mai allo stesso tempo compiamo continui tentativi di metterci in armonia con le pratiche linguistiche e i significati degli altri membri del nostro gruppo e della nostra comunità? Ci giochiamo la nostra esperienza di noi stessi e del mondo, di fatto, in una continua tensione tra “noi” e “io”. Possiamo sostenere che l’individuazione di ognuno si realizza in quella tensione. Pur appartenendo a una comunità di parlanti a cui cerchiamo in ogni modo di essere conformi, siamo di continuo capaci di forzare la mano e di operare estensioni e trasgressioni. Come fa notare Stanley Cavell in La riscoperta dell’ordinario, siamo capaci di passare dall’affermazione “alimentare il bambino”, all’affermazione “alimentare il computer”, senza problemi, estendendo in continuazione l’uso delle parole e creando nuove e inedite possibilità di significato. Mentre ci prendiamo la libertà e il diritto di parlare a nome del gruppo di cui sentiamo la necessità di essere parte; mentre operiamo continui tentativi di modulare intenzionalmente le nostre pratiche linguistiche con gli altri componenti della comunità, tendiamo allo stesso tempo a trasgredire quell’ordine che tanto ci attrae per affermare una posizione o una proposizione originale che sia del tutto nostra. Quella forzatura che cerca di estendere il linguaggio oltre i confini della consuetudine e dei limiti segnati dalla costituzione della comunità stessa, è in una certa misura un’ennesima prova della forza del conformismo.
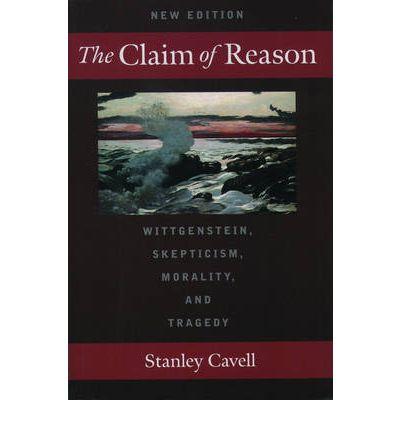
Abbiamo evidenze consolidate derivanti dalla ricerca, che mostrano la nostra propensione all’appartenenza a forme diverse di molteplicità condivisa. È come se la necessaria risonanza con l’altro, alla base della nostra individuazione, si amplificasse agli altri, ai gruppi di riferimento e alle comunità di appartenenza e, con diversi gradi di intensità, ci coinvolgesse in diversi livelli di “noità” che, mentre ci rassicurano, allo stesso tempo ci includono e cirendono ad essi conformi. Nel tempo attuale le tecnologie della comunicazione e la pervasiva omologazione degli immaginari sembrano ricreare conformismi e omologazioni neo-tribali, tacite e spesso inconsapevoli. Tutto questo tende a ridurre la nostra plasticità e libertà. Nei primi anni della nostra vita viviamo un lungo periodo critico di grande plasticità del nostro cervello. In quel periodo il nostro organo centrale è altamente sensibile all’esperienza e si estende alla conquista dell’abbondanza del mondo. E’ come se il cervello andasse a scuola dagli altri e dall’ambiente e cambiasse in funzione delle relazioni con il mondo in cui vive. Si verifica successivamente una stabilizzazione dei circuiti nervosi. I circuiti divenuti più stabili tendono a ripetere le stesse funzioni e, di conseguenza, di fronte a stimoli esteri e interni la “macchina cerebrale” tende a rispondere con comportamenti simili. Si generano in tal modo molte routine mentali che mostrano un significativo livello di ripetizione e prevedibilità. Oltre a risuonare con gli altri e a simulare i loro comportamenti e le loro scelte, noi diveniamo progressivamente parte di molteplicità condivise. Animali sociali quali siamo costruiamo appartenenze e l’integrazione in esse ci rassicura. Quanto riusciremo a essere almeno in parte indipendenti mentre viviamo e cerchiamo l’appartenenza, è una questione aperta dalla cui elaborazione dipenderà il nostro grado di conformismo e di originalità innovativa. Quello che Lamberto Maffei in Elogio della ribellione, Il Mulino, Bologna 2016, chiama “il grande ragno delle comunicazioni”, oggi estende la tela della globalizzazione e del pensiero omologato con una velocità sorprendente e accoglie nella sua rete soffice e attraente gli umani che accorrono entusiasti a quella appartenenza, così che sia i prodotti che i desideri divengono simili.
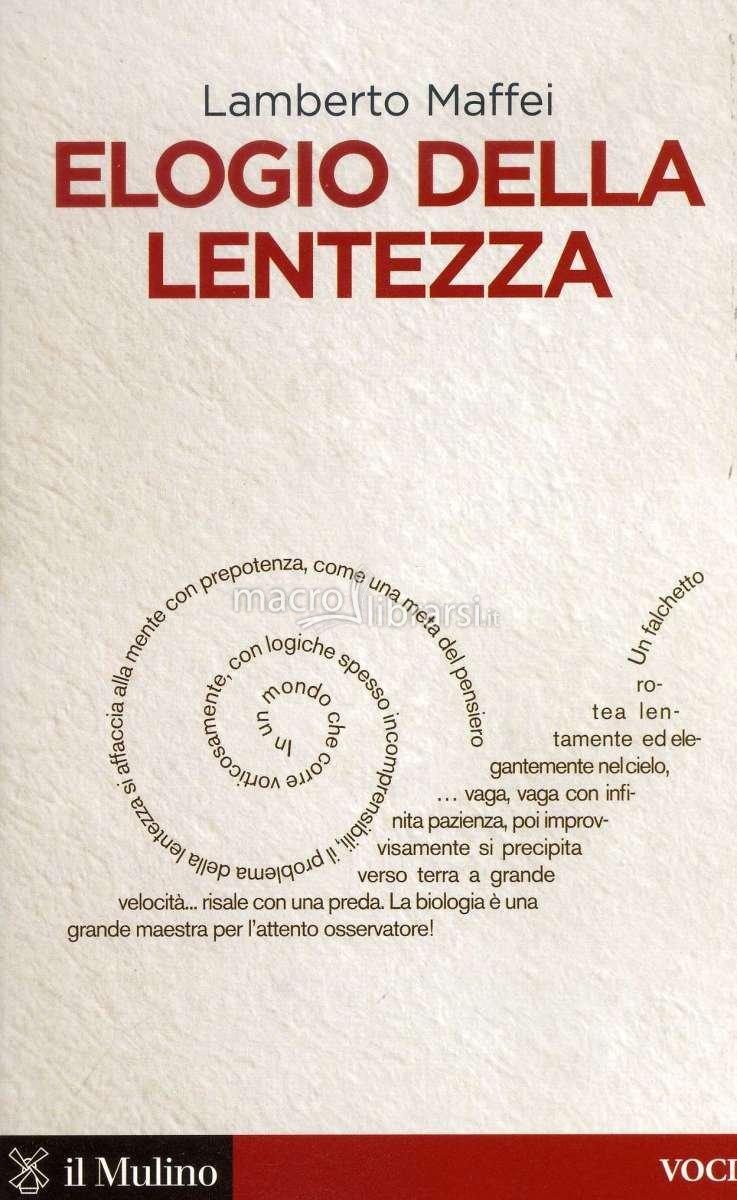
Se la grande ragnatela della rete diventa l’ambiente comune che costituisce l’insieme degli stimoli che riceviamo, con stimoli simili è più probabile che si abbiano comportamenti simili. Il fatto è che il conformismo vincola, ostacola, a volte neutralizza la creatività. Non solo ma vincola la capacità di sentire, e possiamo giungere a non sentire più la differenza tra “alimentare un bambino” e “alimentare un computer”. Se creare per noi umani è comporre e ricomporre in modi almeno in parte originali le cose esistenti al mondo, è nella generatività che si esprime una delle nostre possibilità più importanti. La rassicurazione conformista attacca proprio quella capacità specie specifica e tende a ridurci a massa. Se c’è sempre un oltre possibile nel consueto scorrere degli eventi e se l’appartenenza al tepore della massa ci rassicura, il nostro senso del possibile dipenderà da come sapremo elaborare questa ambiguità e questo conflitto.