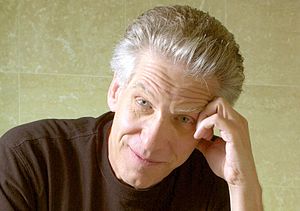È curioso come quest’anno al Festival del Cinema di Cannes fossero praticamente scomparsi i film che riguardavano la paternità e la crisi del ruolo del padre, che erano stati tra i grandi temi del cinema degli ultimi anni. La nostra impressione però è che non fossero propriamente scomparsi, ma fossero semplicemente stati rovesciati. Al loro posto sono comparsi molti film che parlano di rapporti incestuosi o di rapporti di competizione narcisistica tra le generazioni: non solo Mommy di Xavier Dolan o il discusso film israeliano Loin de mon père, che mostrano esplicitamente rapporti d’amore tra madre e figlio o tra padre e figlia, ma anche Sils Maria di Olivier Assayas dove diverse generazioni non sono in una posizione di insegnamento e trasmissione verticale, ma sono in competizione e rispecchiamento orizzontale l’una nell’altra. Ma perché questi due temi sarebbero l’uno il rovescio dell’altro?
Il ruolo del Padre – se facciamo lo sforzo di disincarnarlo dalle sue manifestazioni concrete e rimaniamo alla lettera della sua formulazione teorica psicoanalitica – è infatti soprattutto quello di rendere operativa una Legge: impedire gli investimenti erotici che un bambino inevitabilmente ha nei confronti del genitore che lo accudisce, e far sì che questi vengano proiettati nella dimensione pubblica. La crisi della figura che è stata storicamente l’estensore di questa Legge (non discutiamo se purtroppo o per fortuna), cioè il Padre, comporterebbe dunque una diversa conformazione del legame sociale. Verrebbe dunque da chiedersi se sia davvero questo l’esito della tanto discussa “evaporazione del Padre”: la diffusione di un legame sociale incestuoso dove le generazioni stanno tutte l’una accanto all’altra indifferenti a ogni discontinuità simbolica?
Ci parla di questo problema Maps to the Stars, il nuovo capolavoro di David Cronenberg: ovvero di un mondo dove non esiste una Legge simbolica operativa e dove regna incontrastata l’indifferenziazione narcisistica. E non è un caso che l’ambientazione siano Hollywood e Beverly Hills, luoghi dove l’unica autorità riconosciuta è quella dell’Io, della sua performance e della sua immagine. Cronenberg ce lo fa capire subito facendoci vedere l’attrice decadente e sulla cinquantina Havana Segrand (Julianne Moore) che lotta per avere la parte di un remake di un film classico di Hollywood che fu interpretato da sua madre molti anni prima. I rapporti sono rovesciati: l’immagine della madre è giovane, bella, sexy; quella della figlia è anziana, insicura, il fisico non più quello di una volt
La madre non è una figura di cura e accudimento ma rappresenta l’immagine che Havana vorrebbe diventare ma non è più in grado di essere. C’è poi la giovanissima star Benji Weiss (Evan Bird) che a nove anni ha già guadagnato milioni di dollari con la commedia Bad Babysitter e a tredici è già stato in una comunità per tossicodipendenza: suo padre e sua madre non hanno la funzione di genitori, ma di manager, e da lui vengono trattati proprio come se fossero i suoi dipendenti. In Maps to the Stars i rapporti generazionali sono rovesciati. La famiglia non conta. Tutti sono in competizione con tutti: quello che conta è il potere che uno ha (ovvero i soldi che ha) e il corpo.
Ma a Cronenberg non interessa la critica sociale (non gli è mai interessata). L’ha ricordato anche in conferenza stampa a Cannes rispondendo alla domanda di una giornalista che gli chiedeva come mai avesse un’immagine di Hollywood così negativa: “non è vero – ha risposto candidamente lui – io adoro Hollywood! Non vede come ci stiamo divertendo?”. Maps to the Stars vuole infatti muoversi su un terreno più astratto, persino filosofico. Semmai si potrebbe parlare di una cosmologia, visto che la protagonista, Agatha Weiss (Mia Wasikowska), arriva nella città degli angeli da Jupiter, Florida e che la prima cosa che chiede al suo autista di limousine (Robert Pattinson, che sembra uscire da Cosmopolis) è proprio una “mappa delle stelle”. Quando si vive in un mondo orizzontale, dove genitori e figli si possono facilmente scambiare di posto, il problema è proprio quella di orientarsi, e di essere in grado di fare una mappatura.

È proprio questo che tentano di fare tutti i personaggi del film. Vagando in un mare di Xanax, Vicodin, Energy drink, terapie yoga, massaggi e strane pratiche di auto-aiuto, sembra che tutti tentino il più possibile di trovare una strana modalità singolare di equilibrio, sempre nell’alveo della prestazione fisica e della propria immagine narcisistica. Tuttavia il mondo di Hollywood – o meglio, di una Hollywood che è diventata un vero e proprio universo senza confini e limiti – è solo apparentemente immanente, in realtà qualcosa emerge da questo piano liscio. Non dallo spazio e neanche dal tempo ma da uno strano impasto di entrambi. Sia Havana Segrand, che Benji Weiss, che poi il padre stesso di Benji e Agatha inizieranno tutti ad avere delle visioni. Si tratta di spettri del proprio passato: il rapporto mai risolto con la madre (che viene da morta a umiliare la figlia), un’amica morta da bambina di malattia e che si era andato a trovare in ospedale senza troppa attenzione e poi naturalmente il più grande spettro di tutti, quello dell’incesto dei propri genitori, che in realtà si scopre fossero fratello e sorella. Il passato (tempo) dunque si fa spettro (nello spazio) e rompe questa eterna sceneggiata narcisistica.
È questo un punto cruciale per comprendere non solo questo film ma tutta l’ultima produzione di Cronenberg. Il regista canadese dice infatti di non credere negli spettri o nel soprannaturale – è forse il regista materialista per eccellenza – ma di credere nel fatto che il passato e i sensi di colpa possano ossessionare una persona per sempre. È proprio in questo punto che un regista che ha fatto del corpo il tema al quale ha dedicato la sua intera opera scopre la psicoanalisi: perché c’è qualcosa della materialità del corpo che ha una causalità bizzarra e difficile da comprendere. Perché per riuscire a comprendere materalisticamente il corpo a un certo punto dobbiamo includere anche quello strano intruso che è l’inconscio. O se vogliamo, rovesciando il problema, perché l’inconscio non è lo spirituale, come purtroppo ancora credono molti psicoanalisti, ma è semmai una dimensione materiale, una sorta di strano principio causale (una quasi-causa la chiamerà Deleuze) che rompe i rapporti necessitati di causa e effetto tra le cose. Una diversa connessione tra le cose. O se vogliamo, la loro vera mappa.

E allora come si fa ad avere a che fare con queste strane materialità spettrali che continuano a ossessionare le vite narcisistiche di questa cosmologia hollywoodiana? Come è possibile avere a che fare con questi sensi di colpa e questi traumi del passato che nemmeno un guru new age, il Dalai Lama (“è un grande uomo, ride molto”) o una confezione di Xanax possono guarire? Questi spettri che fanno sì che nemmeno i morti siano mai veramente morti? È qui che Cronenberg ci regala il vero e proprio colpo di scena concettuale del film (il cui intreccio non sveleremo): è proprio quello che ci viene ad ossessionare dal passato che finirà per guarirci; è proprio lo stesso incesto i cui fantasmi continuano a dannare la famiglia Weiss che finirà per condurla verso una paradossale guarigione. O meglio, in questo mondo non esistono né malattie né guarigioni, non esiste né vita né morte, non esiste dannazione né salvezza. Il peccato delle generazioni dei padri si trasmetterà in quelle dei figli perché in realtà di peccato non si tratta, ma solo di un eterno scivolare delle cose. Maps to the Stars diventa allora il cantico di un’immanenza assoluta dove tutte le cose stanno incestuosamente l’una accanto all’altra, senza che nessun Padre e nessuna Legge le potrà mai separare (come si dice nelle celebrazioni matrimoniali).
Ed ecco che allora acquisiscono senso quei versi che tutti i personaggi declamano enigmaticamente lungo tutto il film, dove si dice che sopra ogni cosa “scrivo il tuo nome” (“Su ogni carne consentita/ Su la fronte dei miei amici/ Su ogni mano che si tende”…). I versi di Libertà di Paul Éluard, di cui viene genialmente rovesciato il senso, diventano allora non il cantico della liberazione dal nazi-fascismo, ovvero di una liberazione da qualcosa; ma di una libertà dell’indifferenza e del permanere di ogni cosa. Di una libertà che è assenza di tempo, di verticalità, di legge e che è spinozianamente indistinta dalla necessità e quindi anche dall’ossessione di un passato che non può che ritornare in eterno. È come se Cronenberg ci volesse dire – in un film che è ad un tempo la sua opera più psicoanalitica e quella più anti-psicoanalitica possibile – che l’inconscio non ci schiavizza mai, perché il suo ripetersi non è un ossessione spettrale, ma è semplicemente il ritmo dell’universo e quindi della sua libertà. La sola libertà è allora quella di andare a riconoscerla nel permanere di ogni cosa, l’una accanto all’altra, come se stessimo guardando un firmamento di stelle. Che però non sono da un’altra parte su nel cielo. Ma qui, a Hollywood.