Aveva qualcosa del guru, Ferdinando Taviani, del combattente comunero latino-americano e andino con i suoi poncho, gli eterni sandali, i berretti colorati. Non so perché, lo associo a Garabombo, il personaggio di vecchi romanzi di Manuel Scorza, invisibile come Taviani, Nando per le innumerevoli tribù teatrali che ha frequentato. Garabombo era invisibile alle autorità cui presentava le proteste della sua comunità andina; Taviani era un accademico capace di scomparire nel teatro e di riapparire di lato, nel “fra” come ebbe a scrivere di Giuliano Scabia, spostando ogni volta i dati delle questioni, aprendo squarci inaspettati, anche ferite, che avrebbero generato idee e comportamenti. Non so cosa significhi: ma non esiste una voce di Wikipedia su di lui. Così lo hanno ricordato Eugenio Barba e i suoi compagni dell’Odin Teatret.
Arrivederci, fratello di lavoro
Il 4 novembre è morto Nando Taviani, pensatore e studioso originale di teatro, fratello di lavoro dal 1969 di noi tutti all’Odin Teatret. Era il nostro consigliere letterario, co-autore di testi e ispiratore di progetti che hanno reso il nostro gruppo teatrale un incoraggiamento e una vocazione per molti altri.
Insieme abbiamo progettato i cinque mesi del soggiorno dell’Odin a Carpignano Salentino nel 1974, lì dove nacque l’idea e la pratica del “baratto”. Era accanto a noi quando visitammo nel 1976 per la prima volta l’America Latina e scoprimmo che esistevano le isole galleggianti del Terzo Teatro, i gruppi teatrali che credevano che si potesse cambiare sé stessi e addirittura la società. In fitto dialogo inventammo l’antropologia teatrale e mettemmo su una scuola che si chiamava ISTA, internazionale e laboratoriale nella sua ricerca pura sulla tecnica dell’attore.
Durante i lunghi mesi di prove a Holstebro per uno spettacolo, Nando cercava di liberarsi dai suoi impegni universitari in Italia e accompagnare il nostro “viaggio” il più a lungo possibile. Rinchiusi con gli attori in sala per 10-12 ore, e poi a casa mia per alcune ore, discutendo, vaneggiando, scoprendo, equivocandoci, prima di crollare di stanchezza.
“Adesso telefono e lo racconto a Nando”. Quante volte l’ho fatto – dieci mila, venti mila volte. Fino a un paio di mesi fa ci sentivamo regolarmente e i suoi consigli finali riguardavano una Fondazione che volevo creare. L’ho visto per l’ultima volta tre settimane fa. Stentava a parlare e a stare in piedi. Quando ci separammo volle alzarsi da solo, senza aiuto. In uno sforzo sovrumano mi abbracciò con tutta la forza della sua spossatezza e mi sussurrò: non ti lascio.
Caro Nando, ci sei accanto e continuerai a volare con noi fino a quando l’Odin continuerà a sognare. Con dolore
Eugenio e tutto l’Odin

Primo ricordo
Ero appena arrivato all’Università da studente, desideroso di capire il teatro e di metterlo in pratica per capirlo meglio. Uno dei primi libri che comprai, approfittando di uno sconto epocale, perché si trattava di copie rovinate da un’alluvione o da qualcosa del genere, era il suo La fascinazione del teatro (1970), una raccolta di scritti sulla Commedia dell’arte, di padri predicatori, sopra tutto, che nel secolo barocco vedevano nel teatro una manifestazione del diabolico. Parlava, se ricordo bene, di tempo altro del teatro, di tempo sospeso dalla vita produttiva e da quella di comunità governate dallo Stato e dalla religione, e noi, in quei primi anni ’70 di pensieri e pratiche di trasformazione della società, capimmo che si trattava di un tempo altro rispetto alla società della produzione, al tempo servo del lavoro salariato, un momento di scatenamento di energie e pensieri in diretto rapporto col desiderio, prefigurazione di mondi diversi attraverso l’immaginazione. Già allora parlava dei teatranti come di microsocietà distaccate dalla società normale, di enclave alternative. O almeno così lo leggemmo in molti (l’idea di microsocietà poi sarebbe germinata negli studi di Claudio Meldolesi: Taviani, con Laura Mariani e Mirella Schino, li avrebbe riuniti in un prezioso volume apparso nel 2013, Pensare l’attore). In quegli anni, nel 1975, uscì Il libro dell’Odin, guida partecipata con la sua cura al teatro della compagnia diretta da Eugenio Barba, una raccolta di materiali, testimonianze, interpretazioni.

Secondo ricordo
Vedo Taviani al festival di Santarcangelo 1978, intitolato dal direttore Roberto Bacci La città dentro il teatro. Non era semplicemente una teatralizzazione dello spazio urbano, ma un’invasione, una trasformazione con fuoco, acrobati, attrazioni, meraviglie del quotidiano cittadino. Una proiezione, che riprendeva i fuochi degli scontri degli anni precedenti, del ’77 in particolare, rendendoli non più conflitto fisico ma mentale, esistenziale. Ancora enclave. E all’interno di quel festival si poneva la questione del rapporto con la città di Santarcangelo, invasa da bonghisti che non smettevano di suonare i loro tamburi e tamburini di giorno e di notte. Come mediare tra l’anima libertaria di un festival dell’immaginazione e delle possibilità e il bisogno di ore di pausa (e di normalità) della cittadinanza? Lui, che di Bacci come di Barba era consigliere, ci provò, con ragionamenti che parevano inoppugnabili. Non ricordo se ci riuscì.
Certo era capace di aprire come scatolette le questioni più spinose, di rovesciarle e mostrale differenti, sorprendendo. Ha scritto: “Credo che il buon senso mostri esattamente il contrario: sono lo scarto, la non coincidenza o addirittura la mutua inconsapevolezza fra visione dell’attore e visione dello spettatore che fanno dell’arte teatrale un’arte, e non un’imitazione o una replica del conosciuto”.
E questo stesso atteggiamento utilizzava per i problemi pratici come quelli storiografici o teorici. D’altra parte la novità del suo metodo – messo a punto con vari compagni di viaggio radunatisi inizialmente intorno alla cattedra di Giovanni Macchia all’Università di Roma, con Ferruccio Marotti, col compianto Fabrizio Cruciani, morto troppo giovane, con Franco Ruffini, Claudio Meldolesi, Nicola Savarese, e poi Mirella Schino, Clelia Falletti, Laura Mariani e altri – consisteva proprio in quello: nutrire la teoria con la pratica e provare a comprendere nodi storiografici del passato come la differenza delle tribù della Commedia dell’arte attraverso la partecipazione alla vita di gruppi teatrali di oggi. In quelli, nell’Odin e nelle compagnie che si riconoscevano in quel fenomeno definito da Barba “Terzo Teatro”, riconosceva altre microsocietà che si staccavano da quella dominante con un bisogno espressivo, creativo ma anche di testimonianza nei territori. Tale consuetudine a un dialogo continuo con il teatro vivente gli consentì una parte della messa a punto proprio del metodo storiografico: entrare nel passato di cellule sociali vive attraverso la conoscenza di pratiche del presente.

Terzo ricordo
Guardare il teatro è opera di pulizia di uno sguardo offuscato dalle tradizioni e dalle superfetazioni. Ha scritto (ringrazio per le citazioni Lorenzo Donati): “Quando alcuni critici e storici del teatro saltano fuori dalla separatezza che tradizionalmente li allontana dalla vita degli attori e dal lavoro che precede e circonda gli spettacoli, quando cioè scelgono una forma di osservazione partecipante lavorando sul terreno del teatro materiale, sembrano sacrificare lo studio all’impegno, l’analisi alla memoria, il giudizio critico al viaggio personale. In realtà, non fanno altro che prendere posizione per spaesarsi ed avere un proprio personale punto di vista”.
In tal modo il teatro si ritrova come pratica totale della scena e spesso come pratica di vita, sottratto alle semplificazioni della letteratura e della critica teatrale, all’aneddotica e ai travisamenti della società dello spettacolo. Esemplare a questo proposito è Contro il mal’occhio del 1997, raccolta di scritti di critica, dove per critica non si intendevano le sempre più esangui cronache dei giornali, ma veri e propri saggi d’occasione che provavano a rimettere lo sguardo, offuscato, in funzione; a sottrarlo ai fuorvianti “incantesimi”.
A questo proposito esemplari sono il saggio su uno dei grandi artisti di teatro emarginati e “sprecati” del secondo Novecento, Antonio Neiwiller, e quello intitolato Una storia semplice: la mossa del cavallo, dove Taviani smontava la montatura fatta dalla stampa sulla famosa “uccisone” del cavallo durante uno spettacolo dei Magazzini Criminali (che dopo quel “caso” dovettero cambiare nome). Lo spettacolo di Federico Tiezzi Genet a Tangeri era stato ambientato nel macello di Riccione e durante il brano in cui si diceva il testo di Genet sulla strage nei campi palestinesi veniva ucciso un cavallo dagli addetti del macello, nella loro normale quotidiana attività. I giornali titolarono che gli attori avevano ucciso il cavallo in scena, con articoli e commenti di collaboratori che non avevano assistito allo spettacolo. Taviani smascherava la faciloneria e l’effettismo che sempre di più la stampa avrebbe seguito, interessandosi al teatro solo quando poteva montarci sopra racconti di cronaca più o meno raccapriccianti.
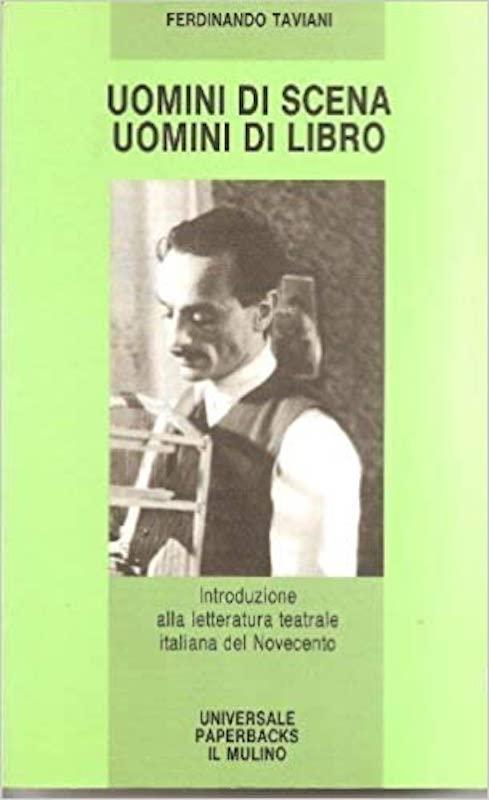
Ultimi ricordi.
In uno dei suoi libri più belli, scritto con Mirella Schino, Il segreto della Commedia dell’arte del 1982, rivelava quella forma di teatro inventata da artisti italiani una pratica degli attori, un metodo produttivo e un’invenzione storiografica della Francia, dove i comici avevano riscosso un particolare successo. Ancora una volta ispirato dall’esempio divergente delle compagnie del Terzo Teatro, trovava nell’improvvisazione e nella presunta assenza di testi drammatici della Commedia dell’arte (stereotipi interpretativi duri a morire) invece la coscienza di un metodo di creazione di letterati che si erano trasformati in attori e avevano messo a punto un sistema per arrivare a pubblici ampi. Essi, promuovendo un’impresa produttiva con un’originale divisione del lavoro, potevano allestire in fretta gli spettacoli puntando sulle abilità di ciascuno dei componenti della troupe. Si presentavano come borghesi, dividendo la vita dalle maschere che indossavano; assegnavano alle compagnie nomi come Gelosi, Desiosi, Accesi, ricollegandosi alle Accademie letterarie per marcare la distanza dalla massa dei guitti di piazza, per dare dignità e efficacia ai loro lavori.
A queste correnti, tra la letteratura e il teatro, in una direzione e nell’altra, ha dedicato gli ultimi studi, con il fondamentale Uomini di scena, uomini di libro del 1995, dove il “libro” non è solo il testo drammatico, ma tutto quello che gli attori stessi e chi li circonda scrivono sul teatro, testimoniandone la vita effimera e rendendola più tangibile. Poi si era occupato di Pirandello, come letterato e come capocomico, e delle fratture che con la sua opera aveva procurato nel teatro del Novecento
Tantissimi altri sono stati i contributi di questo docente universitario, prima a Lecce, poi professore ordinario all’Università dell’Aquila dal 1986, ed emerito dal 2014: saggi, articoli, molti dei quali su “Teatro e Storia”, la rivista fondata con altri studiosi. Sempre in quel movimento a onde che si diceva: dalla pratica alla storiografia alla teoria e viceversa. Con una capacità da “dottor sottile” di rovesciare le questioni, di smontare certezze acquisite e rivelarle diversamente, smascherarle, permettendo alla ricerca, pratica e teorica, di guardare in territori inesplorati e spesso prima impensati. Nel tentativo costante di restituire lo spessore delle storie di vita di sofferenza, di entusiasmo, di invenzione alle tracce labili del teatro.

