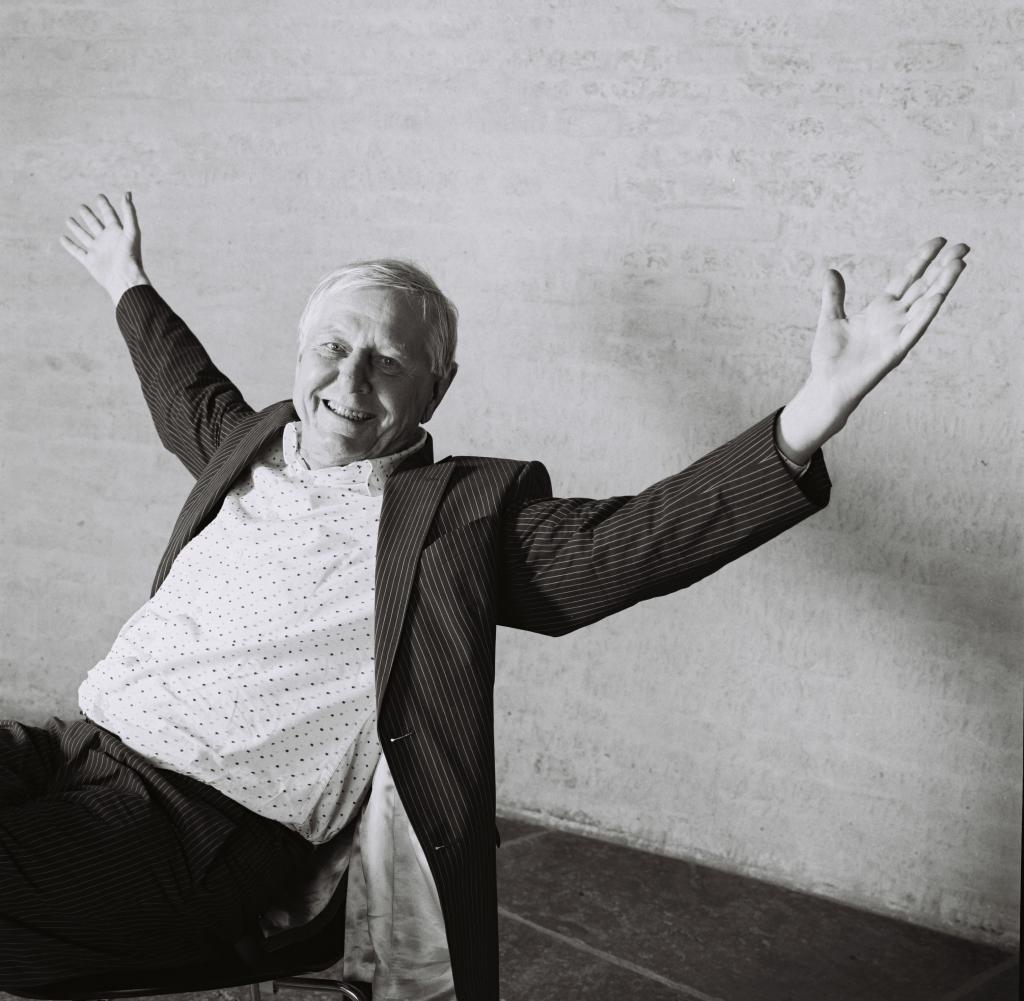A Hans Magnus Enzensberger (1929-2022) non è mancato il coraggio, anzitutto nel correggersi. Fu attratto dalla rivoluzione cubana, ma dopo un anno passato all’ombra della barba giovanile di Fidel Castro capì che “la cosa non poteva funzionare”. Dall’ideologia di quegli anni, quelli del “Kursbuch”, la rivista di agitazione politico-letteraria da lui diretta tra il 1965 e il 1975, quelli della grande illusione per una rivoluzione imminente e liberatrice, il poeta, traduttore e critico tedesco ne è uscito presto. Per riaffermare la sua natura più vera, quella di poeta anzitutto, nel 1978, con La fine del Titanic (Einaudi, 1997), un poemetto in 33 canti che celebrava la fine delle utopie, quelle del progresso e delle grandi ideologie liberatrici su tutte, ma successivamente, all’inizio degli anni ’90, per allontanarsi dalla sinistra tout court, non solo da quella intollerante e violenta, oscillante tra stalinismo e anarchismo, a lui ben nota.
È al tempo della prima guerra del Golfo che, insieme a pochi altri intellettuali tedeschi, prende una propria autonoma posizione di legittimazione del conflitto, azzardando un paragone Saddam-Hitler, distanziandosi radicalmente dalle posizioni di Habermas e Grass e criticando duramente il Movimento pacifista tedesco, accusato di ingratitudine nei confronti degli Stati Uniti, dei liberatori dalla dittatura nazista e di poco coraggio nelle battaglie per la libertà. Quella presa di posizione rispetto all’establishment culturale dominante fece guadagnare a Enzensberger l’onore di essere elencato tra i rappresentati della “nuova destra” tedesca. In un autorevole studio pubblicato nel 1995, dedicato agli intellettuali accomunati da tratti di pensiero nazionalista, l’autorevole storico Richard Stöss accostò il suo nome a quello, tra gli altri, di Ernst Nolte, Botho Strauss, Armin Mohler e Klaus Motschmann. La grande ubriacatura ideologica era davvero finita e da allora da parte di Enzensberger non c’è stata più ritrattazione. Anzi, con maggior convinzione ha legittimato la seconda guerra all’Iraq, dichiarando la propria “gioia trionfale” al momento dell’abbattimento del regime di Saddam Hussein.

Per quanto detto, sorpresero non poco certi commenti nostrani a proposito del suo pamphlet Il perdente radicale (Einaudi, 2007). Da taluni Enzensberger era ancora considerato “un punto di riferimento per molta sinistra europea” (Giuliano Ferrara). Già il titolo originale, vizio frequente tra i nostri editori, era stato manomesso: in tedesco suonava decisamente meno soft: Uomini del terrore. Saggio sui perdenti radicali. Per tracciare i tratti del “perdente radicale” Enzensberger si interrogava circa le sue condizioni personali di vita, senza indulgere troppo in psicologismi o sociologismi. Tanto meno utilizzava vecchi criteri marxisti: “Con le categorie dell’analisi di classe non è possibile venire a capo delle contraddizioni che qui si prospettano”, si preoccupava di precisare. Interessante il richiamo a Hitler e al nazionalsocialismo quali esempi storici di “uomini del terrore”, non solo per il parallelo tra il combattente nazista e il terrorista islamico fondato sullo sterminio di altri, ma anche per il comune obiettivo, più o meno cosciente: il suicidio, personale e collettivo. “Non è peregrina”, sosteneva Enzensberger, “l’ipotesi che Hitler e i suoi accoliti non mirassero a vincere, ma a radicalizzare e perpetuare il loro status di perdenti”. Non a caso dunque il Führer avrebbe affermato che il popolo tedesco non meritava di sopravvivere. L’attentato suicida, scriveva ancora il poeta.
“esercita un’attrazione irresistibile sul perdente radicale, perché gli consente di sfogare le sue fantasie megalomaniache e insieme l’odio verso se stesso”.
Nella pur rapida disamina contenuta in poche decine di pagine, il libro si rivelava di grande interesse anche perché riproponeva con coraggio il tema del conflitto di civiltà, specificando che non si tratta di discutere presunte inferiorità razziali. Piuttosto, il poeta si rifaceva all’Arab Human Development Report, frutto di una ricerca commissionata dall’ONU e realizzata tra il 2002 e il 2004 da studiosi arabi, in primis l’egiziano Nader Fergany. Apprezzando il coraggio dell’autocritica, Enzensberger sottolineava i pesanti deficit circa la libertà politica e religiosa, lo sviluppo economico, l’istruzione e il sapere e la situazione delle donne. Da questo quadro, si poneva una domanda definita “tormentosa”: perché la decadenza della civiltà dell’islam, giunta al suo culmine con il califfato, “di gran lunga superiore all’Europa militarmente, economicamente e culturalmente”? E qui Enzensberger decideva coraggiosamente di affrontare le cause endogene, denunciando la facile attribuzione di colpe al “grande Satana” (gli americani, gli ebrei) e rifacendosi al saggio di Dan Diner, Il tempo sospeso. Stasi e crisi nel mondo musulmano (Garzanti 2007), dove, per esempio, i ritardi nello sviluppo del sapere scientifico e tecnico vengono fatti risalire alla decisione dei giuristi islamici del XV secolo, sulla base del dogma che nessun altro libro fosse lecito oltre al Corano, di non introdurre il torchio tipografico: la conseguenza fu che la prima tipografia capace di produrre libri con caratteri arabi venne fondata con tre secoli di ritardo rispetto all’Europa.
Da ultimo, tanto per ribadire la radicale ricusazione rispetto alla cultura sinistrorsa nelle cui braccia per decenni si era abbandonato, Enzensberger individuava i precursori del modello organizzativo dei terroristi islamici “specialmente” nel “terrorismo radicale di sinistra degli anni Sessanta e Settanta”. Ancor più esplicitamente, Enzensberger ricordava che “il Corano prende il posto di Marx. Lenin e Mao, e a Gramsci subentra Sayed Qutb” e, infine, al partito rappresentante il proletariato mondiale si era ormai sostituito “il vastamente ramificato reticolo cospirativo dei combattenti islamisti.”
La “storia molto tedesca” del generale Hammerstein
Hammerstein o dell’ostinazione (Einaudi, 2008) è stato il terzo romanzo documentaristico di Enzensberger. Al centro della vicenda, il pigro padre di sette figli Kurt Freiherr von Hammerstein-Equord, la cui carriera raggiunse l’apice nel 1930, con la nomina a capo dell’esercito tedesco. Ad appena un anno dall’ascesa al potere di Hitler, era il 1° febbraio 1934, dopo aver ascoltato il fresco cancelliere esporre durante un incontro segreto i propri piani militari d’aggressione, rassegnò le dimissioni e si decise per il ritiro a vita privata. Accanto al generale, di formazione prussiana e tra gli ispiratori dell’attentato a Hitler del 20 luglio 1944, nel romanzo gioca un ruolo centrale l’intera sua famiglia. Due delle quattro figlie divennero infatti comuniste, finendo col passare materiale segreto all’Unione Sovietica, mentre due dei tre maschi figurarono tra le fila degli ufficiali della Wehrmacht organizzatori del citato attentato. Eppure il nocciolo di quel libro era un altro, cioè il doppio gioco dei comunisti russi, pianificato fin dal 1919: sostenere insurrezioni in tutta la Germania per far scoppiare anche lì la rivoluzione e insieme, tramite l’Armata Rossa, trattare con la Reichswehr. “Se la Germania si metterà dalla parte della Russia, sarà invincibile”, così Karl Radek, membro del Comitato esecutivo del Komintern ed emissario dei bolscevichi a Berlino nel 1919. Dopo il Trattato di cooperazione russo-tedesca di Rapallo del 1922 quelle attività che sarebbero dovute restare clandestine (reciproci soggiorni di formazione militare tra Armata Rossa e Reichswehr) subirono negli anni Venti un considerevole incremento. Perfino il nome di Hammerstein, che non nascondeva le proprie simpatie per la realtà sovietica, figura tra gli ospiti più illustri ricevuti in quegli anni con la massima riverenza dall’Armata Rossa. Questo, accanto ai già altrove sperimentati dialoghi immaginari con i morti, agli aneddoti e alle interviste ai sopravvissuti, è ciò che ha raccontato e dettagliato Enzensberger con il rigore dello storico navigato.
*
Hitler, “politico molto dotato”, e Castro, il “dittatore”
Fu poco dopo la pubblicazione in Germania di Hammerstein che dall’“irregolare” tedesco arrivarono, attraverso il settimanale svizzero “Die Weltwoche” (numero 4/2008), considerazioni sul Führer, sul nazismo e sull’approccio dei suoi connazionali alla storia di quel regime.
Enzensberger faceva notare come nella scuola tedesca contemporanea “quei dodici anni (1933-1945) occupino uno spazio assolutamente sovradimensionato”, e come si fosse soliti “separare rigidamente il bene e il male”. “Al contrario, si presta poco ascolto”, lamentava lo scrittore, “a coloro, probabilmente la maggioranza, che non si comportarono al cento per cento in un certo modo.”
Alla domanda se Hitler invece sia stato al cento per cento cattivo (il “male assoluto”, direbbe qualcuno), Enzensberger non esitava ad attribuire all’austriaco la qualifica di “politico molto dotato” (hochbegabt): “Bisogna pur dirlo, ha captato con più precisione rispetto agli altri le forze latenti in Germania nel 1931”. Altrettanto interessante il giudizio secondo il quale Hitler non fosse da considerare un “patriota”, in quanto “il popolo tedesco era la massa da usare per il suo fine”.

L’intervista, infine, conteneva anche un duro attacco al totalitarismo cubano (Castro, “il dittatore”) e alle esperienze di comunismo fatte nel Novecento. Dopo aver ricordato com’egli avesse sempre verificato di persona gli “esperimenti” socialisti distribuiti nel mondo, Ensensberger tagliava corto:
“Il socialismo purtroppo non funziona. Punto. Non posso farci nulla, non l’ho inventato io”.
*
Il coraggio di raccontare i propri fallimenti
Varcata la soglia benemerita degli ottant’anni anni, un qualsiasi scrittore, almeno tra i teutonici, se non l’ha già fatto, comincia a pensare al riordino delle proprie opere (Günter Grass iniziò a farlo a sessant’anni…), puntando magari a nuove, raffinate riedizioni di quelle più riuscite. Non è stato così per Enzensberger, che nel 2010 in I miei flop preferiti (Einaudi, 2012) tracciò la propria autobiografia elencando e raccontando i progetti mai realizzati o, peggio ancora, miseramente falliti, perché, come scrive nella prefazione citando Hesse, “in ogni pena abita un’illuminazione”. Un elenco di débâcles personali redatto con orgoglio e senza autocompiacimento che rappresentò anche un invito ai suoi colleghi a smetterla con gli eterni lamenti circa l’ingiustizia del sistema, la stupidità del pubblico che non capisce… “Invece d’intrattenersi con simili rimostranze”, scriveva, “ha molto più senso tirare fuori la successiva carta dalla manica e, come dice una canzone popolare del 1793, tirare avanti ‘perché il piccolo lume è ancora acceso’”.
Certo quello cui poté attingere lo svevo era un cospicuo repertorio di fallimenti personali che spaziava dalla letteratura al cinema, dal teatro all’opera e all’editoria. Particolarmente numerosi i soggetti per film mai realizzati. E quello più caro a Enzensberger, di cui ha fatto il tema centrale della sua vita, era legato alla figura di Alexander von Humboldt, il biologo ed esploratore vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento: ad un certo punto, ricordava lo scrittore, tutto lasciava intendere che il suo soggetto sarebbe diventato un film. Poi però, l’imprevisto arrivò nel 2005: Daniel Kehlmann con il suo romanzo La misura del mondo (Feltrinelli, 2006). “In quel libro”, ammetteva Enzensberger, “venne alla luce un Humboldt che mi era sconosciuto e che rivelava molti bei tratti”. Entrato in concorrenza, lo svevo dovette soccombere.
I flop più interessanti sono stati però quelli editoriali. Nel 1961, insieme a Uwe Johnson, lo scrittore tedesco orientale fuggito dalla DDR, a Ingeborg Bachmann e altri decise che la Germania occidentale aveva bisogno di una rivista internazionale, non ideologica, sorprendente ed esteticamente attraente.
Ci furono incontri preparatori un po’ dovunque in Europa e dall’estero sarebbero arrivati i contributi di Italo Calvino, di Pier Paolo Pasolini, di Jean Genet, di Marguerite Duras e di Roland Barthes. Il magazine si sarebbe dovuto chiamare prima “Halleluja”, poi “Gulliver” ed avrebbe dovuto “evitare tutto ciò che viene coltivato con noia, che è puritano, che viene rimarcato come serio”. Si volevano presentare fiction e non fiction in un’unità indissolubile, “una nuova poesia accanto all’analisi di un nuovo modello d’auto”: in breve, con la rivista si voleva “recensire l’intera realtà.” Purtroppo però, ricordava Enzensberger nel 2010, la realtà non volle lasciarsi recensire…e con una lettera inviata il 15 maggio 1963 ai potenziali collaboratori dovette comunicare che il progetto di rivista non sarebbe neppure partito, causa “l’assurda moltiplicazione dei costi tecnici” necessari per realizzarla. Tuttavia, anche in questo fallimento Enzensberger riuscì a vedere il positivo: appena due anni dopo sarebbe infatti uscito il primo numero di quello che sarebbe diventato il leggendario trimestrale “Kursbuch”.
Insomma, tanto di cappello a quest’“uomo universale”, come lo definivano in Germania, che ci ha appena lasciato.