studiosi di poesia e romanzo, linguistica e folklore, teatro e cinema, ma anche poeti e romanzieri, sceneggiatori e registi, che erano portatori di un forte rinnovamento teorico e metodologico nel campo degli studi umanistici, etichettati alcuni come formalisti russi, altri come strutturalisti sovietici, altri ancora come semiotici slavi. L’innesto di questa tradizione di studi in una cultura come quella italiana, ancora fortemente intrisa di idealismo crociano e storicismo più o meno dialettico, era certamente salutare. Se pure vigilato con maniacale attenzione e non poche censure dai sovietici locali, sempre pronti a esercitare il loro filtro ideologico su tutto ciò che sapeva di rigore teorico nell’ambiente tanto polveroso quanto aggressivo delle umane lettere. Già il parlare di scienze dell’uomo era guardato con accigliato sospetto: si preferivano le impalpabili nuances dello Spirito, le indicibili manifestazioni del sentimento interiore, qualsiasi cosa esse volessero e potessero significare. Oppure si invocava la goffissima interpretazione materialistica della storia. Un modo feroce per custodire posizioni di potere academico ed editoriale.
Importare dai meandri culturali più nascosti dell’URSS e degli altri paesi del blocco sovietico le opere di quegli studiosi (contro le quali, va ricordato, s’erano levati sia Trockij sia Stalin in persona, con scritti che allora fecero scalpore) significava, da un parte, contrastare l’euforia travolgente dello strutturalismo francese e anglo-americano e, dall’altra, proporre una sorta di teoria ibrida fra il marxismo e il metodo formale, lo storicismo e la semiotica. Una specie di trasformismo culturale, di cui l’Italia è maestra indiscussa, e non solo nell’arena politica. Sdoganiamo la Struttura, signora mia, ma sempre con l’avallo della Storia, per carità.
Meglio di niente? Macché. A dispetto dei loro cani da guardia, le opere di quegli studiosi erano linfa vitale per i nostri linguisti e antropologi, critici letterari e storici dell’arte, filmologi e mediologi. Del resto, Saussure e Barthes, Wellek e Forster, Hjelmslev e Lévi-Strauss, Greimas e Lacan, Benveniste e Foucault venivano tradotti con generosità. C’era di che leggere, di che imparare da entrambi i lati. Ecco dunque libri importanti come i Saggi di linguistica generale di Jakobson e la Morfologia della fiaba di Propp, l’antologia I formalisti russi curata da Todorov e la Tipologia della cultura di Lotman e Uspenskij, il Dostoevskij di Bachtin e La struttura del testo poetico dello stesso Lotman. Tutti volumi che, deo gratias, il nostro mercato editoriale continua a ristampare. Ma anche, e soprattutto, opere che sono finite nell’oblio, in quella che doppiozero ama chiamare Atlantide. Per esempio (e vado a memoria): la Teoria della prosa e i Materiali e leggi di trasformazione stilistica di Sklovskij, la Teoria della letteratura di Tomaševskij, Avanguardia e tradizione e Il problema del linguaggio poetico di Tynjanov, Il formalismo russo di Erlich, La funzione, la norma e il valore estetico come fatti sociali di Mukařovský, Poetica e poesia di Jakobson, Semiotica e storia di Uspenskij, La fiaba russa di Propp.
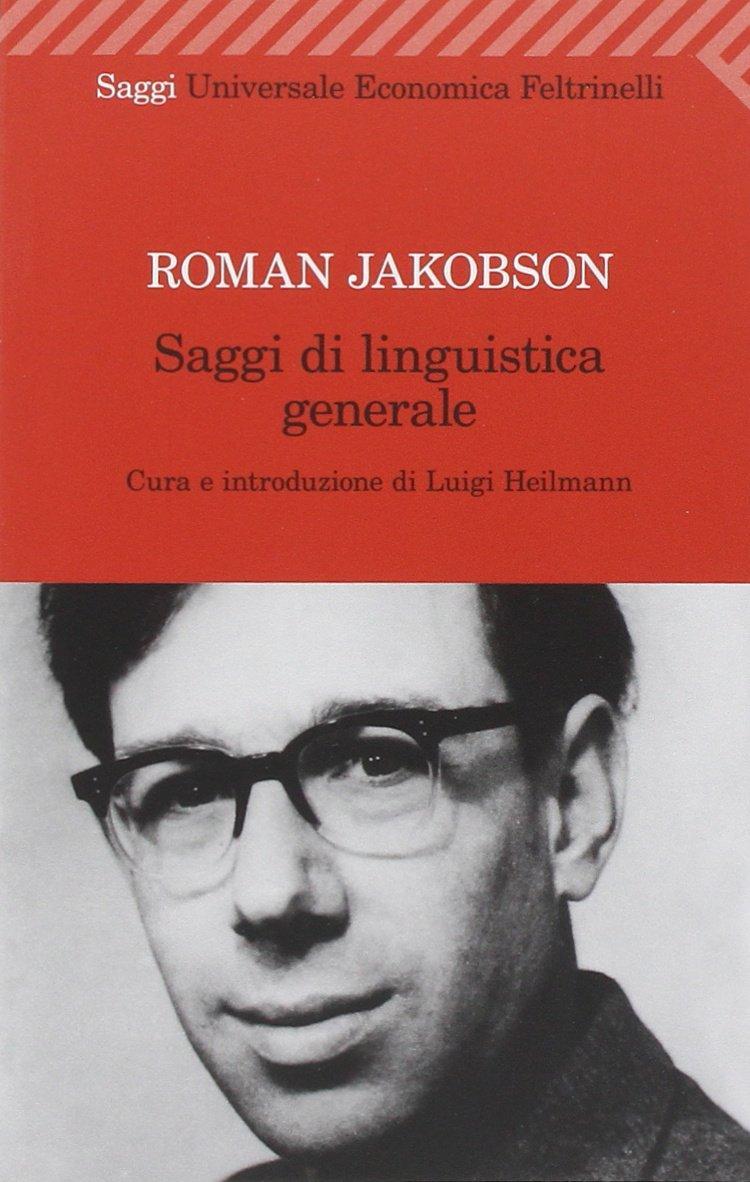
Per non parlare dei tanti libri di Lotman non più editi come Testo e contesto, La semiosfera, La cultura e l’esplosione, Cercare la strada, Il girotondo delle muse e così via. O delle quattro ricchissime raccolte di scritti: I sistemi di segni e lo strutturalismo sovietico, curata da Eco e Faccani per Bompiani; La semiotica nei paesi slavi, a cura di Prevignano per Feltrinelli; le Ricerche semiotiche curate da Lotman e Uspenskij per Einaudi; La cultura nella tradizione russa del XIX e XX secolo a cura di Avalle sempre per Einaudi. Infine, la miriade di saggi e articoli che pubblicavano riviste meritorie come “Strumenti critici”, “Uomo & cultura”, “Rassegna sovietica”, “Versus” e tante altre.
Bello allora vedere tornare in libreria il vecchio libro sui Formalisti russi nel cinema, uscito in Italia da Garzanti nel 1971 per la cura di Giorgio Kraiski, in una versione arricchita curata da Pietro Montani per Mimesis (pp. 251, € 22). Vi si trovano i saggi di Eichenbaum, Tynjanov, Sklovskij e Brik che c’erano nella prima edizione, per lo più volti a ricostruire le specificità del linguaggio ibrido del film, nel crinale fra il muto e il sonoro, il bianco/nero e il colore, con l’aggiunta di tre saggi di Jakobson (sulla presunta decadenza del cinema), Mukařovský (sull’estetica filmica) e Lotman (sul particolare ruolo del cinema nel meccanismo della cultura contemporanea).
I formalisti erano maestri nello studio del testo letterario: cercavano quella che chiamavano “letterarietà” nei meccanismi di composizione delle opere, non a prescindere dai loro contenuti (come sostenevano i loro detrattori) ma per meglio riconoscerli e comprenderli. Parlavano di “straniamento” della percezione quotidiana del mondo, da ottenere attraverso il complesso lavorio di arricchimento (formale e dunque semantico) operato dallo scrittore – termine e concetto, quello dello straniamento, che tanta fortuna avrà nella drammaturgia brechtiana e nella semiologia di Barthes. Sostenevano che nella storia della letteratura non c’è mai progresso, piuttosto una serie di parricidi: l’evoluzione letteraria, a loro avviso, non va di genitore in figlio ma da zio a nipote. Trasversalmente, di sghimbescio. Ogni scrittore crea così i suoi predecessori, come poi sosterrà Borges.
Ma per quale ragione, si chiede Montani nell’introduzione, si interessarono così tanto, e così da vicino, al cinema, trascurando arti più blasonate come la pittura o la musica? Sicuramente per le forti analogie strutturali che il cinema presenta con la letteratura, e con il testo poetico in particolare. Il loro interesse, difatti, non stava tanto nel carattere palesemente narrativo del film, a dispetto, per esempio, della apparente staticità della fotografia. Né tantomeno la loro attenzione era attirata dalla – anche qui apparente – naturalità dell’immagine meccanica (fotografica come filmica), atta, secondo i più, a rappresentare il mondo per quel che è. Molto diversamente, essi pensavano che l’arte cinematografica si fondi in primo luogo sulla sua convenzionalità, sulla serie di regole sintattiche – a iniziare dal montaggio – che ne regolano il flusso, e specificamente sulla sua capacità di produrre effetti poetici dispiegando lungo la pellicola fotogrammi che sono in relazione fra loro, per parallelismi, inversioni, trasformazioni, rime. In altre parole, l’immagine cinematografica è interessante non perché è in movimento, che è una banalità, ma perché lungo questo movimento del film è come se essa lo bloccasse, rinviando per via retorica alle altre immagini presenti in quello stesso film. Esattamente come la poesia, lungo il proprio tempo il film crea effetti di spazio: quel che conta non è la narrazione lineare ma la sua continua frammentazione, la rete di collegamenti interni (visivi, ma anche cromatici e sonori), le cesure, i toni, i ritmi, gli accenti, le pause, i dispositivi prosodici. Insomma il montaggio (grande tema di Ejzenštejn, su cui Montani ha parecchio lavorato).
Così, per esempio, un’inquadratura soggettiva sarà tale se e solo se segue a un’altra
di tipo oggettivo, o pseudo tale, e ne precede un’altra anch’essa oggettiva. Se tutto quanto, nel film, fosse visto da un solo personaggio, questo coinciderebbe con l’occhio della camera e diventerebbe – oltre che noioso (si pensi a The lady in the lake di Montgomery) – del tutto normale, abituale, cioè a suo modo oggettivo. Analogamente per il tempo: oltre al ritmo dell’azione raccontata, c’è quello dello stesso film, la velocità con cui viene riprodotto, che può cambiare nel corso della proiezione in modo da creare, per esempio, effetti di comicità (quando c’è un’accelerazione) o di tristezza (quando c’è un rallentamento). Ma accelerazione e rallentamento sono tali soltanto rispetto al tempo ‘normale’ del film, ossia quello a cui siamo abituati. Ancora, se in Schindler’s list il cappottino rosso della bambina, durante la retata in un ghetto, fa tanta impressione è perché il resto del film è in bianco/nero.
Ovvio, si dirà. Ovvio perché, continuano i formalisti, lo spettatore ha introiettato nel corso del tempo questi e altri meccanismi dell’arte cinematografica, acquisendo i codici di un linguaggio che essi chiamano “transmentale” – il quale, per nulla curiosamente (ne parla uno psicologo come Vygotskij), sta a metà strada tra la cognizione e la percezione, l’attività intellettuale e quella sensoriale. Al cinema è il corpo che pensa, e il pensiero che sente. Per questo motivo la diffusione progressiva dell’arte cinematografica è parallela a una certa “alfabetizzazione delle masse”.
Motivo in più per leggere questi scritti, commenta Montani, in un momento culturale come quello attuale, dove si pone fortemente il problema di un’analoga “alfabetizzazione mediale” “volta a implementare un grande circuito di condivisione e di pratiche interattive”. Così come negli anni dei formalisti, fra il ’20 e il ’30, il cinema veniva studiato nel suo stato nascente, allo stesso modo oggi il mondo del web deve essere inteso e compreso. Troppo facile, ancorché fuorviante, guardare a esso con gli occhi cisposi dell’umanesimo classico, finendo per assumere posizioni banalmente apocalittiche. Più utile semmai ragionare nei termini di una nuova “scrittura per immagini” tipica delle pratiche, per esempio, del riuso delle immagini archiviate in rete “le quali contemplano diverse modalità di accoppiamento con la scrittura in senso stretto, nell’ambito di una più vasta attività di montaggio audiovisivo e intermediale”. Leggere Sklovskij per credere.

