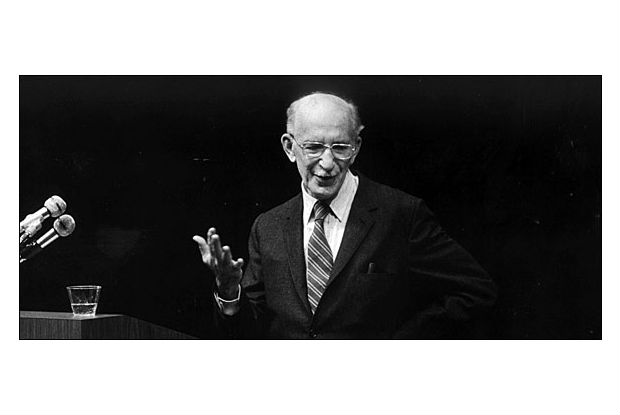Appena Bernard Malamud seppe di aver vinto il National Book Award si mise in strada e passeggiò a lungo. Camminò per le vie che conosceva e proseguì per alcuni isolati sperduti, quando sentì di essere stanco si addentrò in un parco pubblico. Si sedette su una panchina, era quasi sera, e ci pensò su. Non rifletté sulle conseguenze del premio letterario più importante d’America, gli venne in mente la madre. Era morta giovane lasciandolo solo con il padre, un droghiere gentile di Brooklyn senza lamenti e con la devozione per la famiglia. La madre e il padre, festeggiò così lo scrittore ebreo più importante e discreto degli Stati Uniti. Era il 1959 e lui aveva quarantacinque anni, un’esistenza alle spalle di mezza orfananza che gli aveva portato dozzine di mestieri, dalla fabbrica ai negozi alimentari, fino al concepimento di un romanzo capolavoro: Il commesso.
Lo aveva pubblicato due anni prima, l’effetto che generò fu lo stesso che si avvera nelle scorribande tra ragazzini, quando il più fragile della compagnia compie un’impresa inaspettata. E produce sgomento. Così il narratore che veniva dalla tetra Brooklyn, ebreo di irrisorio fascino, divenne il maestro indiscusso di un giovane Philip Roth e il collega a cui guardare con ammirazione, il riferimento è a Saul Bellow. L’intero mondo letterario seppe che la grande potenza di Malamud covava nella semplicità, e nell’onestà. Per lo sguardo e per la scrittura. Per l’azzardo di restare nella modestia degli uomini.
Il commesso è questo, racconta la storia di Morris Bober, un piccolo negoziante ebreo che si trova in difficoltà perché nella stessa via hanno aperto un’altra drogheria e un negozio di liquori. Gli affari calano, la miseria arriva. Crescono le opportunità di farla franca in altre maniere. Morris non cede, si arrocca nella sua rettitudine e si consuma nello sforzo. Finché un ragazzo di origine italiana, Frank Alpine, si offre di aiutarlo senza compenso per imparare il lavoro sul campo. Morris tentenna, poi accetta perché la salute inizia a mancargli e perché vuole assicurare un accenno di futuro alla figlia e alla moglie. È la scelta che avvia la missione di ogni personaggio, umiliando le illusioni religiose, esaltando le certezze etiche.
Destino, sacralità, morale. La cattedrale di Bernard Malamud scardina i miraggi quotidiani con una storia che è il punto massimo nella lotta tra un omino giusto e un immenso Dio impietoso.
Sgobbava per ore e ore, era l’onestà fatta persona – non poteva proprio sfuggirle, era la sua palla al piede; sarebbe scoppiato se avesse imbrogliato qualcuno; eppure si fidava degli imbroglioni – non invidiava nulla a nessuno e diventava sempre più povero. Più sgobbava – la sua fatica era un’immagine del tempo che divora se stesso – meno sembrava possedere. Era Morris Bober e non poteva avere una sorte migliore. Con un nome così, il senso della proprietà ti era negato, come se il non possedere ce l’avessi nel sangue, nel destino.
Nella storia yiddish un bober indica una persona o una cosa che vale poco. Un’anima rattrappita che aspetta la fine dei suoi giorni. Un’ombra nell’ombra. Invece qualcosa resiste, è il piglio che viene dalla storia dei singoli, e da nessun dogma: la dignità. Morris Bober non la perde mai. E quando sta per farlo la ritrova nelle origini. Nella madre e nel padre, appunto. Ancora meglio, nell’infanzia. «Morris era pieno di malinconia e passava ore a sognare della sua infanzia. Ricordava i campi verdeggianti. L’uomo non dimentica mai i luoghi in cui ha corso da bambino».
Così il misero negoziante di Brooklyn afferra il coraggio ancora una volta. Corre come da bambino. Accetta l’aiuto del commesso, duella con la concorrenza, con la crisi nera, con i malanni e con un Dio scorbutico che non ha mai fatto girare la ruota dalla parte giusta. Ripaga l’anatema con la fatica. Ha queste braccia minute, la schiena curva, il volto di spigoli. Va avanti e a un certo punto sembra riuscire nell’impresa, poi la beffa si consuma: il commesso ruba. Inganna Morris. Arraffa un paio di dollari dall’incasso impietoso e poco importa se li rimette in cassa dopo qualche giorno per il rimorso. Il senso di colpa è nella matrice ebraica, si scaglia sul negoziante quando è imprigionato nella povertà, ricatta Frank Alpine per i furti e perché spia la figlia di Bober nella doccia.
«Come puoi o Signore accanirti ancora in questo modo?», è il tormento di Morris nell’attimo in cui scopre ogni cosa. Come puoi, o Signore? Il negoziante crede, tutta la sua famiglia fa il possibile per rispettare le leggi di Dio, anche se mangia prosciutto per niente kosher. E si limita a guardare la sinagoga da lontano. Forse viene da qui la maledizione che aleggia sopra questo minuscolo alimentari con gli scaffali mezzi vuoti, le pareti ingrigite, le luci che stentano. O forse è soltanto la vita di certi uomini come lui che «da adulti, in America, raramente avevano visto il cielo».
C’è un punto della storia in cui Morris si consulta con la moglie, il negozio peggio di così non può andare. Potrebbero metterlo all’asta e trovare un altro lavoro. Morris va a Manhattan per elemosinare aiuto a vecchi amici che hanno avuto fortuna al suo posto. Passa da negozio a negozio, qualcuno gli fa mettere un grembiule e lo sistema alla cassa del suo lussuoso emporio. Morris ha superato la sessantina, è piegato dal tempo e il mondo l’ha stancato. Fugge un attimo prima di essere compatito. Rinuncia, e diventa libero. Il ritorno nella sua Brooklyn è una passeggiata lunga, come lo è stata per Malamud dopo che è venuto a sapere del National Book Award. Incontra gente sconosciuta e qualche volto familiare. Cammina ancora, e per un attimo sente l’antidoto alla sua paura atavica, non sa bene di cosa si tratti. Fede? Fiducia in Frank Alpine? Rassegnazione? Incoscienza? La risposta è nel suo passo lieve che scaccia per un attimo la malasorte. Il commesso è questo, il manifesto di una vita inclinata e di una dignità salvata. Beato chi lo leggerà per la prima volta.
Verso la fine si tiene un discorso pubblico sull’integrità religiosa di Morris Bober, viene sollevata la questione della sua fede a singhiozzo: «“Posso chiamare ebreo quel tale che è vissuto e ha lavorato tra i gentili, vendendo la loro carne di porco, trayfe, robaccia che noi non mangiamo, uno che neanche una volta in vent’anni ha messo piede nella sinagoga; un uomo così è un ebreo?”» La risposta contiene il senso di questo romanzo sussurrato che custodisce la semplicità di una persona e delle persone. «“Sì, per me Morris Bober era un autentico ebreo, perché […] chiedeva poco per sé, non chiedeva niente, ma voleva per la sua diletta figliola un’esistenza migliore di quella che lui aveva avuta”».
L’esistenza di Malamud fu migliore di quella dei suoi genitori. L’episodio che lo fece passare di grado nell’evoluzione familiare accadde quando il padre gli regalò un’intera enciclopedia, The Book of Knowledge, come premio per essere sopravvissuto a una feroce polmonite. Era la prima volta che un libro entrava in casa Malamud. Quando il ragazzino si vide davanti la sfilza di volumi capì che il mondo non era solo fatto di merce da vendere, di una naturale cortesia verso i clienti o di gare tra coetanei nel quartiere. C’era dell’altro, e andava esplorato. Lo aiutarono dei buoni insegnanti al liceo e un’innata propensione a raccontare qualsiasi vicenda nei minimi particolari. Da quando aveva dieci anni il piccolo Bernard assillava chiunque per una descrizione minuziosa dell’ultimo film visto. Era la vera passione malamudiana dell’infanzia: i film, e soprattutto Charlie Chaplin.
Molto tempo dopo quel battesimo culturale, lo scrittore di Brooklyn ammise che il tocco amaro dei suoi libri e la gentilezza della sua prosa veniva proprio da Charlot. Anche il modo di pensare per immagini era in debito con quell’alfabeto. Così Morris Bober diventa un Chaplin quotidiano, mesto e acuto, rancoroso, timido. L’amaro del negoziante sopravvive nei gesti accorti, si avvera nella propensione al bene. Lungi da ogni sentimentalismo, Il commesso dà fiato alla discrezione del cuore. È lo stesso pudore narrativo che Malamud insegnò nei corsi di scrittura per quarant’anni. «Si impara da ciò che si insegna, e si impara da quelli a cui si è insegnato», disse a Daniel Stern in una delle poche interviste rilasciate. Non lo dimenticò mai, con questa missione continuò a trasmettere il mestiere del narratore finché riuscì. Era un modo per incontrare sensibilità formidabili («Imbattersi in un gruppo di lettori veramente seri è qualcosa di miracoloso») e per viaggiare.
Malamud perlustrò in lungo e in largo il continente americano e l’Europa, amava moltissimo l’Italia. Per un po’ visse a Roma e non è un caso che Frank Alpine sia di origine italiana. Ogni suo personaggio in un modo o in un altro rimane esule, è l’omaggio ai genitori immigrati dalla Russia. Anche Morris Bober ha la stessa ferita, non territoriale ma di alienazione. La minaccia viene dallo straniero: due norvegesi aprono un alimentari nella stessa via, sanno usare la pubblicità e vendono prodotti di qualità superiore. La strada che l’ha protetto ora è confine di guerra. Così Malamud trasforma il calore del luogo di nascita in ghiacciaio. Anche il clima segue il suo disegno, la neve è l’unica traccia del Dio scorbutico. Nevica quando proprio non deve, e quando c’è di mezzo il riscatto finale di un uomo. «La neve di primavera commuoveva Morris nel profondo. La guardava cadere, scorgendovi scene della sua infanzia, ricordando cose che pensava di aver dimenticato. […] Provò un desiderio irresistibile di trovarsi fuori, all’aperto». Stattene a letto, cocciuto di un ebreo, griderebbe il lettore. Il codice di Morris Bober rispetta l’obbedienza al dovere, è il suo vangelo. L’ebreo va, esce. Sfida il cielo avverso. E compie il suo destino.
Malamud combatté per tutta la vita con l’incertezza di saper scrivere un libro. Più diventava celebre, maggiore era la sua ansia di non riuscire più a creare una storia. Lo diceva anche ai suoi studenti: «Convivete con l’insicurezza e osate». Lui osò sempre, e ogni volta tornava a trovarlo la maledetta paura. Forse fu proprio quella, la paura, a condurlo in strada quel pomeriggio di vittoria del National Book Award. A convincerlo a passeggiare oltre le strade conosciute, a metterlo seduto sulla panchina di un parco pubblico. A fargli scansare un pensiero di gloria, a favore della madre e del padre. E a riportarlo a scrivere, per altri venticinque anni, narrazioni formidabili.
Ribadì la sua esitazione sempre. Tranne a Daniel Stern, quando gli chiese se esistesse nel mondo la possibilità di non raccontare più storie. Prima di rispondere Malamud aspettò un istante, poi disse: «Questo succederà quando la gente non farà più sesso».
Torna in libreria Il commesso, il romanzo capolavoro di Bernard Malamud. Pubblichiamo la prefazione inedita di Marco Missiroli