Dopo l’8 settembre ci mette qualche mese prima di decidere di salire in montagna. Giorgio Bocca ricordò poi quel periodo in cui lo “stato d’animo era di libertà totale”, ma le ferite della Russia e il redde rationem dopo il collasso del fascismo per una generazione per cui la parola “patria” aveva un valore, rendono la scelta di Nuto non immediata. È un colloquio con Dante Livio Bianco, maggiore di lui di una decina d’anni e che aveva conosciuto gli ambienti dell’antifascismo piemontese riuniti attorno alla figura ideale di Piero Gobetti, che lo spinsero a salire in montagna nel febbraio 1944, a Paraloup, dove le baite assomigliano alle izbe della steppa russa.
“In montagna mi sentivo libero, tutto il resto era occupato dai tedeschi e dai fascisti; in basso era il terrore. Con un Thompson sulle spalle mi sentivo il padrone del mondo, ho respirato degli attimi di libertà che non ho mai più respirato in vita mia”. Sulle Alpi piemontesi gli scontri tra partigiani e nazifascisti sono una guerra vera: agguati, attacchi, ripiegamenti. Revelli è un grande comandante partigiano, sa tenere uniti i suoi uomini, ma nel settembre 1944, dopo un incidente di moto, va in coma.
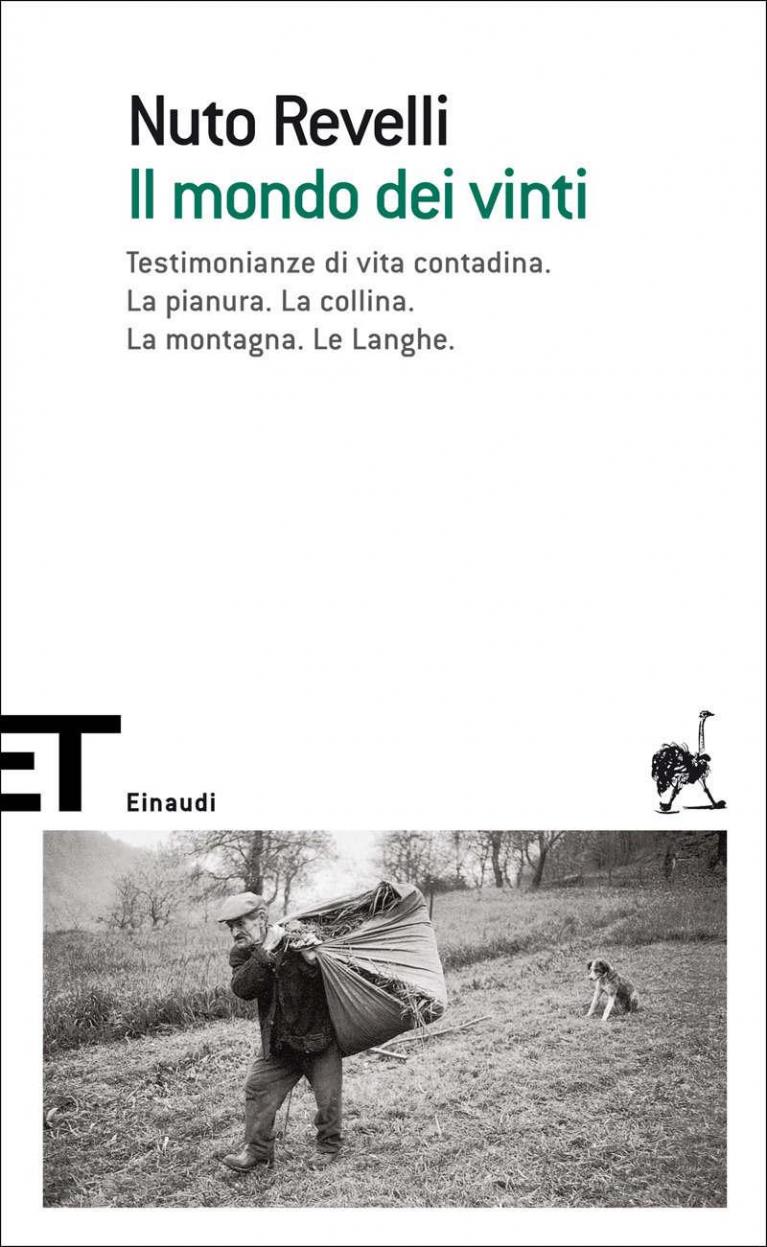
Ha il volto sfigurato e trova rifugio nella Francia liberata dagli Alleati dove, dopo una serie di operazioni chirurgiche, trascorre a Parigi forse il periodo più duro di una vita che lo aveva già molto segnato. Nell’aprile 1945 riesce a raggiungere la sua banda partigiana e a liberare Cuneo.
I giorni di gloria finiscono presto nella routine del dopoguerra, nella voglia di dimenticare i lutti e i compromessi morali del Ventennio. Revelli non è un uomo fatto di questa pasta, fa attività politica per il Partito d’Azione ed è eletto consigliere comunale a Cuneo. Riprende il diario di Russia e pubblica Mai tardi (1946). Il libro ha qualche recensione autorevole (Monelli, Muscetta, Garosci), è osteggiato dallo Stato Maggiore dell’Esercito perché ritenuto disfattista, ma nel complesso passa sotto silenzio. Lo stesso destino di Se questo è un uomo (1947). Ci informa Mendicino che il libro di Revelli fu portato da un compaesano a Rigoni Stern e fu per lui uno stimolo per scrivere Il sergente nella neve.
Levi, Revelli, Rigoni Stern: i tre sono stati sempre più spesso accomunati – divennero anche amici tra loro – come testimoni dei momenti più tragici della Seconda guerra mondiale. Solo negli ultimi anni si è cominciato a riflettere sullo stile con cui sono stati scritte le loro opere d’esordio. Levi frequentò il Liceo classico, gli altri due le scuole professionali. Comune a tutti la ricerca di una lingua che non esisteva nella tradizione letteraria italiana, che non veniva insegnata nelle scuole che frequentarono dove, a parte Dante e I promessi sposi, veniva portato a esempio il “bello scrivere” di tradizione toscana. Pur nelle differenze, quello che unisce i tre scrittori non è solo l’immediatezza espressiva, come sottolinea Mendicino, ma la precisione della parola, il ritmo del racconto, raggiunto attraverso un uso efficace della punteggiatura. Gli esempi sono piuttosto Cesare, Tucidide, Senofonte, letti senz’altro da Levi, mentre è più difficile da affermare per gli altri due. Quello che li ha accomunati e resi amici è uno sguardo morale sulla realtà e aver vissuto, prova difficilissima, all’altezza della propria autobiografia.
In quel dopoguerra l’esempio forse massimo di un modo diverso di scrivere per i nostri giovani scrittori venne dalla letteratura americana (e in particolare da Hemingway). Da lì vennero gli esempi che Vittorini offrì al Calvino di Il sentiero dei nidi di ragno (1946) per raccontare le sue avventure nella Resistenza, ma Levi, Revelli e più tardi Rigoni Stern, avevano la necessità di farsi ascoltare idealmente da tutti, di testimoniare quale fosse la natura dell’uomo e come reagisse in circostanze così estreme.
Nel frattempo negli anni del dopoguerra e nei successivi Revelli si sposò, avviò un’attività commerciale, tenne viva la memoria della Resistenza in tempi avversi, facendo rinascere insieme ad alcuni compagni il giornale “La sentinella delle Alpi” (in lui, e più in generale nel gruppo piemontese di Giustizia e Libertà, è sempre stato forte il richiamo ideale alla tradizione più liberale del nostro Risorgimento).
Il clima politico cambiò in Italia attorno al 1960, dopo le proteste contro il governo Tambroni, un monocolore DC con l’appoggio esterno del MSI. In quell’anno si organizzò un ciclo di lezioni nelle principali città italiane sulla storia d’Italia tra il 1915 e il 1945. Lezioni che ebbero un enorme successo e che vennero raccolta in volume da Einaudi. Revelli fu tra i testimoni e da lì nacque il suo rapporto, durato poi per tutta la vita, con la casa editrice torinese con cui combinò di pubblicare La guerra dei poveri (1962), in cui riprendeva Mai tardi e a cui aggiunse il diario della guerra partigiana. Per l’occasione Revelli compì una revisione formale del testo rendendolo più fluido e narrativo. I tempi erano finalmente maturi per ottenere un successo di pubblico e il consenso della critica. Come scrisse Alessandro Galante Garrone la novità del libro risiedeva, rispetto ad altra memorialistica, nel fatto che la guerra “era vista dal basso”, interpretando i sentimenti di chi l’aveva combattuta.
La campagna di Russia, la tragica ritirata, è uno dei buchi neri della nostra storia novecentesca. La Russia aveva inghiottito tutte le armate? Quanti erano stati i morti? Nel dopoguerra si combatté un’aspra battaglia politica tra chi sosteneva che molti reduci erano ancora prigionieri al di là della cortina di ferro e chi, come fece Revelli nei suoi libri successivi, dimostrò le dimensioni di una catastrofe senza possibili paragoni nella nostra storia militare e le responsabilità dei nostri comandi. La strada del Davai (1966) è un’antologia di testimonianze di guerra e di prigionia del fronte russo. Dopo anni di silenzio i reduci parlarono a lungo con uno che aveva vissuto la guerra come loro, che parlava la stessa lingua e che si esprimeva nello stesso dialetto. Revelli utilizzava i fine settimana per raggiungere i testimoni, raccogliere attraverso appunti stenografici le loro testimonianze e passava poi le serate a mettere in ordine le interviste. L’ultimo fronte (1971), terzo volume dedicato alla guerra di Russia, nasce dal ritrovamento di un archivio di lettere che i soldati mandavano ai famigliari dal fronte e che dopo la guerra erano tornati in possesso dell’Esercito, che ora voleva disfarsene.
La seconda parte della carriera di scrittore di Revelli fu dedicata alla raccolta di testimonianze degli abitanti della montagna cuneese in via di spopolamento verso la pianura dove sorgevano i grandi stabilimenti della Michelin e della Ferrero. Ne nacquero Il mondo dei vinti (1977) a cui seguì il punto di vista femminile in L’anello forte (1985). Attraverso le testimonianze si compone una storia d’Italia vista dal basso: le due guerre mondiali, il fascismo, la guerra partigiana (una guerra subita dagli abitanti delle valli), l’emigrazione, ma anche la migrazione delle donne del Sud salite per i matrimoni combinati con i contadini piemontesi. Commentò Revelli: “la guerra dei poveri non finisce mai”.
È interessante notare come in questo caso l’autore utilizzò un magnetofono e, sbobinando, scelse di utilizzare un italiano con inflessioni dialettali, piuttosto che riportare le risposte in dialetto. La stessa modalità espressiva di Ermanno Olmi in L’albero degli zoccoli (Olmi tra l’altro, insieme a Corrado Stajano, girò il documentario Nascita di una formazione partigiana che racconta la storia della brigata di Revelli).
L’ultimo libro, Il disperso di Marburg (1994) è il più personale. È un’indagine, in forma diaristica, sull’identità di un ufficiale tedesco che gli abitanti del Cuneese ricordavano andare a cavallo per le campagne durante la guerra, poi catturato e ucciso dai partigiani. Oggi le opere di Revelli, come quelle di Levi e Rigoni Stern, sono considerate dei classici. Ci è voluto del tempo, ma è accaduto.

