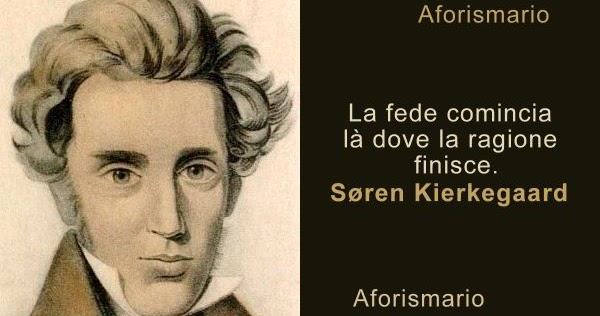Le riflessioni del danese Søren Aabye Kierkegaard, filosofo, teologo e scrittore del XIX secolo, per la critica filosofica, rappresentano un importante momento di rottura con l’hegelismo. Il suo nome è legato, quasi per un beffardo gioco del destino, al sentimento dell’angoscia, elemento portante di un complesso sistema filosofico e teologico che pone le basi per la nascita dell’esistenzialismo, i cui sviluppi segnano profondamente la cultura europea del secondo dopoguerra. Kierkegaard è antagonista di Hegel. Se l’hegelismo procede, attraverso la dialettica dell’ “et-et” (e-e) – dialettica dominata da una rigorosa necessità logica –, alla risoluzione nel negativo nel positivo, annullando l’individuo nell’universale, il pensiero del filosofo danese costituisce una decisa presa di posizione nei confronti di tutto ciò: non vi è affatto spazio per l’ottimismo di fondo proprio dell’hegelismo. La dialettica proposta da Kierkegaard, infatti, risulta incompatibile con quella hegeliana, poiché, non conoscendo costrizioni logiche di alcun genere, invero, salva la libertà dell’uomo, implica la possibilità della scelta e, inevitabilmente, il dolore che ne consegue. Si tratta della celebre “dialettica del salto” che, come tale, si configura come un doloroso “aut-aut” (o…o) e permette all’individuo di riappropriarsi della sua centralità, facendo i conti, al tempo stesso, con le derivanti responsabilità in essa contenute. Il sistema in tal modo delineato non annulla più l’individuo nell’universale, ma lo inchioda alla scelta, rendendolo responsabile di fronte al bene e al male. Questa è la novità, senz’altro, più rilevante rispetto all’hegelismo.
Il tema del libero arbitrio non solo è centrale nelle riflessioni dell’autore, ma si rivela anche decisivo nel determinare un percorso parallelo tra filosofia e teologia. Il punto di partenza, di fatto, è l’esistenza, il cui significato è derivato, dal filosofo, dal latino “ex-sistere”, ossia uscire fuori dall’astratto, dall’indeterminato, attraverso la libera scelta. Appare subito evidente la problematicità che una tale visione della realtà comporta: la scelta tra diverse possibilità, non essendo più vincolata a “rassicuranti” necessità logiche, espone l’individuo anche alla possibilità del fallimento; di qui il sentimento dell’angoscia, definita “vertigine della libertà”. Se esistere è scegliere, l’angoscia trova collocazione nell’impossibilità di conoscere, in anticipo, l’esito delle scelte. Nella dialettica del salto, allora, è più che mai evidente il rapporto “risolutivo” con la fede, intimamente vissuta come “paradosso”. Angoscia e disperazione trovano la loro origine nella separazione dell’uomo da Dio; solamente la scelta coraggiosa e “paradossale” può, pertanto, avere ragione definitiva di esse. Per il filosofo danese, che fa esperienza sulla propria pelle dei diversi stadi dell’esistenza umana, delineati, tra l’altro, nello scritto “Aut-Aut” (1843), la scelta in questione non può che essere rappresentata dalla fede, perfettamente incarnata nella figura di Abramo, che è pronto a compiere il più inconcepibile dei gesti per abbandonarsi totalmente a Dio. Si tratta di una fede radicale, certamente non coincidente con il concetto di fede proprio della religione cattolica o di quella protestante; né è assimilabile al concetto di fede della cultura romantica e naturalista. Questa fede è descritta, soprattutto, nell’opera “Timore e Tremore” (1843), nelle pagine dedicate, per l’appunto, ad Abramo, il quale vive in completa solitudine il dramma più grande, quel “per Dio o contro Dio” che richiama alla scelta più dolorosa e, al contempo, più coraggiosa: il salto nell’ignoto che è anche un andare contro il mondo. Nella chiave di lettura kierkegaardiana, il dramma vissuto da Abramo è il dramma del singolo uomo, la cui esistenza non può prescindere dal libero arbitrio.

«C’è stato chi era grande con la sua forza, e chi era grande con la sua sapienza, e chi era grande con la sua speranza, e chi era grande con il suo amore, ma Abramo era il più grande di tutti, grande con la sua forza, la cui potenza è impotenza, grande per la sua saggezza il cui segreto è stoltezza, grande per la sua speranza la cui forma è pazzia, grande per il suo amore ch’è odio di se stesso».
La grandezza di Abramo consiste nella fede, quasi esasperata, in quel che apparentemente è giudicato assurdo (“credo quia absurdum est” riecheggia, fortemente, in tutte le riflessioni di Kierkegaard). Cosicché egli vive, in assoluto silenzio, il doloroso paradosso delle fede (il comandamento che gli impone il sacrificio del figlio Isacco, da un lato, e il rispetto di quei precetti morali che hanno guidato la sua vita fino a quel momento, dall’altro), la quale è vera e tale proprio perché prescinde dalla comprensione razionale. L’angoscia è l’elemento portante di una fede così drammaticamente vissuta, di fronte alla quale i concetti logici appaiono sterili. Essa, tuttavia, a differenza della paura, che si riferisce sempre a un oggetto preciso e facilmente identificabile, è connessa a una dimensione futura ed è, perciò, “possibilità della libertà”. Nell’opera “Il Concetto dell’angoscia” (1844), a tal proposito, Kierkegaard scrive: «Se l’uomo fosse un animale o un angelo, non potrebbe angosciarsi. Poiché è una sintesi, egli può angosciarsi; e più profonda è l’angoscia, più grande è l’uomo; non l’angoscia come gli uomini l’intendono di solito, cioè l’angoscia che riguarda l’esteriore, ciò che sta fuori dall’uomo, ma l’angoscia che egli stesso produce. Soltanto in questo senso bisogna intendere il racconto del Vangelo, quando si dice che Cristo fu angosciato fino alla morte, come pure quando egli dice a Giuda “Fa’ presto quello che devi fare”. Nemmeno quelle terribili parole di Cristo, che tanto angosciavano lo stesso Lutero: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”, nemmeno quelle parole esprimono così fortemente il tormento; infatti, queste ultime indicano lo stato in cui Cristo si trova, le prime invece indicano il rapporto con uno stato che non è».
La “stato che non è”, cioè il futuro, si determina attraverso la libera scelta di possibilità presenti e reciprocamente incompatibili. L’angoscia, dunque, è insopprimibile e prepara il terreno per l’avvento del “cavaliere della fede”.
«Nel momento stesso che considero il cavaliere della fede, ecco che mi tiro indietro, giungo le mani, e dico a mezza voce: Gran Dio! È quest’uomo qui, è proprio lui? Ha tutta l’aria di un agente delle imposte! Eppure è proprio lui. Mi avvicino un poco, sorveglio ogni suo minimo gesto per cercare di sorprendere qualcosa di un’altra natura, un minuscolo segno telegrafico trasmesso dall’infinito, uno sguardo, un’espressione della fisionomia, un gesto, un’aria melanconica, un sorriso che riveli l’infinito nella sua irriducibilità al finito. Macché! Nulla. Lo esamino dalla testa ai piedi, cercando la fessura attraverso la quale si riveli l’infinito. Nulla! È solido in ogni suo punto. Il suo passo? Tranquillo, interamente confidato al finito. Nessun borghese vestito a festa che faccia la sua settimanale passeggiata al parco ha una andatura più sicura della sua. È completamente di questo mondo, come nessun bottegaio potrebbe esserlo di più. Si rallegra di ogni cosa, si interessa a tutto e ogni volta che lo si vede intervenire in qualche luogo, lo fa con perseveranza caratteristica dell’uomo terrestre, il suo spirito è legato a piccole cure». (“Timore e Tremore”, 1843)

Dalle parole dell’autore non traspare nulla di eroico, anzi l’”eroico”, almeno nell’accezione comune del termine, non appartiene affatto a questa figura, la quale ha per compagna solo una “terribile solitudine” e, quasi fatalmente, parla una lingua sconosciuta ai più. Vivendo la fede come paradosso, infatti, egli (il cavaliere della fede) è destinato a non farsi intendere da nessuno. La fede esaltata da Kierkegaard può albergare esclusivamente nella solitudine e nel silenzio, non contempla la compagnia né aspira alla comprensione da parte dell’altro né può essere oggetto di ridicole e pretestuose dissertazioni logico-razionali. La dimensione che le è propria è espressa da un irriducibile “Io-Tu (Dio)”. Vani risultano tutti gli sforzi, in questo senso, di decodificare una siffatta fede facendo ricorso alla scienza. Tra l’uomo e Dio vi è un infinito abisso e le questioni etiche, morali e religiose sono destinate a sfuggire a qualsiasi tentativo di assoggettamento da parte dello scientismo, subdolamente mascherato da scienza. Ciò, in realtà, è solo una deviazione insita in un determinato modo di rapportarsi alla scienza e, in quanto tale, essenzialmente intrisa di un certo “fanatismo religioso”, che affonda le sue radici nella società industriale moderna e mira a fare “tabula rasa” di tutto ciò che non è materiale. Perentoria è la condanna, da parta di Kierkegaard, di questa forma di presunzione che caratterizza lo scientista, il quale si adopera, con “fervore religioso”, per – scrive l’autore nel “Diario” – «liquidare Dio, completamente come una superfluità, sostituendolo con le leggi naturali» in modo da potersi sostituire a esso (fine ultimo di tale atteggiamento). Con lo stile che gli è proprio egli contrappone la “sapienza dello spirito”, unica certezza, allo scientismo, nient’altro che scelta inautentica e preludio del fallimento.
«Considerare la scoperta al microscopio come un piccolo spasso, una piccola perdita di tempo, va bene; ma considerarla come una cosa seria è da sciocchi […]. Se Iddio si mettesse a gironzolare con un bastone in mano, vedreste come le buscherebbero, specie codesti osservatori così impettiti coi loro microscopi! Col suo bastone Dio bandirebbe ogni ipocrisia da essi e dai naturalisti! E l’ipocrisia consiste nel dire che le scienze portano a Dio».
Certamente si tratta di parole che possono suonare terribilmente inattuali, poiché vanno in un’unica direzione: la precedenza di Dio su tutto, e questo è, innanzitutto, il messaggio che traspare dalle riflessioni del solitario e tormentato pensatore danese, un messaggio opportunamente obliato in una società dove quotidianamente si creano e si venerano idoli di ogni genere, pur di non fare i conti con le conseguenze e le responsabilità delle scelte operate.