Il rovescio del ricamo è l’esorcismo della parola, un esorcismo che non attesta, come in Sartre, l’inconsistenza della nominazione degli enti, ma che al contrario vuole rendere conto, nell’intimo del suo processo, di una densità effettiva propria del discorso. Ed è proprio per perseguire tale obiettivo che ne Il bel rischio. Conversazione con Claude Bonnefoy (Cronopio, Napoli 2013, Traduzione di Antonella Moscati), il critico d’arte Claude Bonnefoy propone a Michel Foucault, all’interno di un incontro vivace e cordiale, di mettere tra parentesi – senza tuttavia scordarsene – la costitutiva vacuità della parola umana, ed offrire così, al filosofo francese, l’occasione per rovesciare quella prospettiva ingenua nella quale spontaneamente si colloca chi scrive, incarnandosi in uno degli innumerevoli possibili medium del logos: ecco, invece, in questo modo apparire fulminea la scaturigine della parola, per mezzo di una lucida autobiografia svolta innanzi alla vigile e imparziale autorità della penna di Foucault.
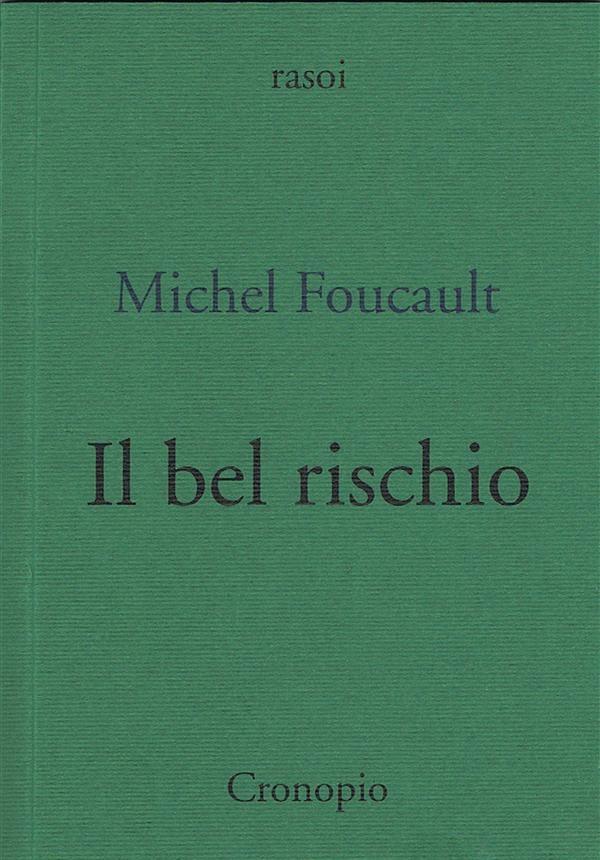
È chiaro che, per un filosofo, strappare ad un ingenuo senso comune il suo dominio sul mondo della parola sembra un compito scontato ed anche piuttosto immediato, ma è proprio ciò che i due interlocutori insistono a nominare “rovescio del ricamo” che consente a Foucault di scoprire, una volta addentratosi nell’analisi, che l’unico modo per liberare la scrittura dalla schiavitù dei luoghi comuni è la reinvenzione di se stessi nel discorso autobiografico, entro una parola nuova, in una dimensione in cui la relazione tra i termini sia come capovolta: non è più Bonnefoy che intervista Foucault, ma è il Foucault timoroso di essere denudato di fronte al rischio che porta con sé ogni domanda, che finisce per interrogarsi da sé sul suo rapporto con l’atto di scrivere.
Sacralità della scrittura, elevazione di sé nell’atto di gettare inchiostro su carta, forse per salvarsi da un male che ancora non è ben chiaro, o forse per irrompere violentemente sulla scena del mondo fino a che il sangue ci terrà in vita, e poi donare le opere all’umanità, così da eternare il nome di chi scrive nella memoria dei lettori a venire. Può anche darsi che la salvezza stia tutta nel mero gesto, e che ci sia più metafisica nell’inchiostro di una parola scritta che in secoli di teoresi.
In realtà, invece, la diffidenza che Foucault ha sempre nutrito nei confronti della scrittura, ha una connotazione intimamente morale: ciò non implica, è ovvio, che la scrittura pura possieda in sé la chiave dei dispositivi etici. Piuttosto, la condizione morale di questa diffidenza conduce il filosofo a non vedere alcun lato davvero sacro e immacolato nella scrittura, nessun aspetto che possa essere degno di elevarne l’attività a paradigma per una fascinazione autentica. Ne viene che la scrittura si è sempre presentata a Foucault sotto l’aspetto di un dolore quasi corporeo, e ciononostante materializzatosi in un’atmosfera di accettazione necessaria della sofferenza stessa, quasi come innanzi ad un richiamo presso al quale non ci si può mostrare sordi. In questo senso, allora, la diffidenza foucaultiana contro la scrittura può dirsi davvero morale, come egli sembra intenderla.
Una delle confessioni più intime e più temute che Michel Foucault rivolge al suo interlocutore Claude Bonnefoy riguarda la paura che un’intervista in cui il suo linguaggio viene prepotentemente messo a nudo possa essere presto resa nota al pubblico. Ma non risponde la scrittura, come già si è detto, proprio al bisogno di perpetuarsi oltre la fine? Non è, questo, di interesse universale per la volontà di potenza – o di salvezza – di ogni individuo? A dire il vero l’autore sembra nutrire un interesse del tutto diverso, per quanto il tentativo di salvaguardare se stesso sia ugualmente manifesto: la vita di Foucault è una vita che in queste battute ci viene da lui descritta come connotata da una noia pervasiva, cosparsa di insistenti preoccupazioni, e in quanto tale fin troppo esposta al dominio del giudizio. Proprio per questo, allora, la scrittura si costituirebbe come quell’apparato velante dietro il quale nascondere la propria esposizione rischiosa all’Aperto, come una nicchia di parole entro cui lasciare che il vaniloquio della parola umana affiori alla coscienza per essere finalmente considerato come tale. La scrittura è il tentativo sempre costitutivamente fallimentare di nascondersi all’essere, di chinare la testa e cercare protezione all’interno di un rettangolo di carta stampata.
L’influenza del senso comune, anche quello più innocente, deve avere poggiato la propria mano anche sul giovane Foucault. Fu proprio per questo, forse, che la scrittura non lo interessò fino ai trent’anni, ma se questo “silenzio” giovanile è servito a maturare in lui la coscienza di una parola fondata sul vuoto organico dell’individuo, probabilmente l’attesa è stata ripagata con un’autentica lucidità. Così, grazie ad una benevola illuminazione, le ingenue credenze popolari sull’atto di scrivere si sono disgregate e la riflessione sulla parola ha dato vita ad un nuovo linguaggio e alla necessità di strapparlo dagli artigli di basse autocelebrazioni mondane.
Esiste un intimo piacere nella scrittura di Foucault, un piacere quasi misantropico, un piacere carnale per il sangue che fluisce dalle ferite, un piacere che trafigge corpi con la stessa forza che la punta del pennino imprime sulla carta, trascinando con sé la vitalità creatrice dell’inchiostro. È innegabile: il piacere della coscienza di quel logos che è pensiero e parola è la gioia di avere a che fare con il corpo degli altri, di poterne disporre come di un cadavere e di potere finalmente attestare come ogni parola sia sempre nell’errore. E non meno errata solo perché la si riconosce quale essa è, sia chiaro, ma forse più sincera, perché non c’è parola di scrittore che sia davvero tale se non è almeno sincera. Contraddittoria, vana, ingenua forse, ma sincera.
Ed è proprio in nome di un piacere avvertito fin negli strati più profondi della carne che Foucault lega la scrittura alla morte, alla morte degli altri, al corpo degli altri come corpo già morto, ancor prima della possibilità stessa di ogni eloquio.
In Blanchot si muore per non morire, si muore per sfuggire alla morte e allo stesso tempo consegnarvisi nell’assurdità del proprio farsi vuoti innanzi ad essa: Kirillov lo sa bene.
Ma Foucault non vuole fare del male, non vuole uccidere un corpo già morto. Tutto sommato, vuole solo concedersi l’amara libertà di infierire sui cadaveri che gli altri sono innanzi alla sua scrittura:
«Con la mia scrittura percorro il corpo degli altri, lo incido, tolgo i tegumenti e la pelle, cerco di scoprire gli organi, cerco di far apparire finalmente quel focolaio della lesione, del male, quel qualcosa che ha caratterizzato la loro vita, il loro pensiero e che, nella sua negatività, ha organizzato, in fin dei conti tutto quello che sono stati.» (ivi, 26)
Senza ombra di dubbio c’è qualcosa, in Foucault, come di un retaggio di quella abitudine alla pratica del taglio che gli deriva dal padre chirurgo, e che il filosofo stesso sembra descrivere miscelando fermezza e malinconia, forse anche provenienti da una vocazione abdicata da sempre, mai realizzata davvero e compensata con le armi nobili della carta e della penna. Ma è auspicabile pensare che ci sia molto di più rispetto ad un semplice rimosso, un che di residuale che ha intimamente a che vedere con quel piacere di scrivere sul quale Foucault torna insistentemente, come a voler esorcizzare una mancanza costitutiva della pratica della scrittura, una mancanza costitutiva del linguaggio, una mancanza costitutiva dell’essere.
Allora è davvero piacere, quello della scrittura? Si ha, a volte, l’impressione che Foucault, forse anche influenzato dal timore che una confessione così aperta sul proprio linguaggio possa essere in futuro resa nota, parli della scrittura in termini idealistici, rischiando un venefico ritorno a quel senso comune che ha adornato la scrittura di inutili orpelli, e che purtroppo continua a farlo. In realtà, però, sembra ben chiaro che il piacere della scrittura si trasfigura ben presto nel dis – piacere di ottemperare alle necessità implicate in un’attività intrisa di interruzioni, di sofferenze, di angosce, di vuoti creativi e fastidi corporali: in fin dei conti, niente di più lontano dal piacere chirurgico – per quanto aspro – dell’essere investiti dal potere di affondare il bisturi nelle profondità della carne umana.
Letteratura e clinica, in definitiva, sono i due ambiti che Foucault pensa in continuità, interrogandosi sull’opera di autori che hanno portato con sé il fardello della schizofrenia, in maniera meno immediata Raymond Roussel e più direttamente Antonin Artaud. Non c’è davvero nulla più della schizofrenia che sia in grado di leggere la filosofia nell’ottica psichiatrica, ed è per questo che Foucault, autodefinitosi medico diagnostico di quella verità colta nelle ferite perpetrate sui corpi morti degli altri, riesce a strappare la parola al suo ambiente comune e a farne, come negli intenti profondi di Heidegger, il luogo presso cui prendere dimora dell’essere, al di là di ogni dispositivo etico. Non è forse, proprio questo, il vero rovescio del ricamo?

