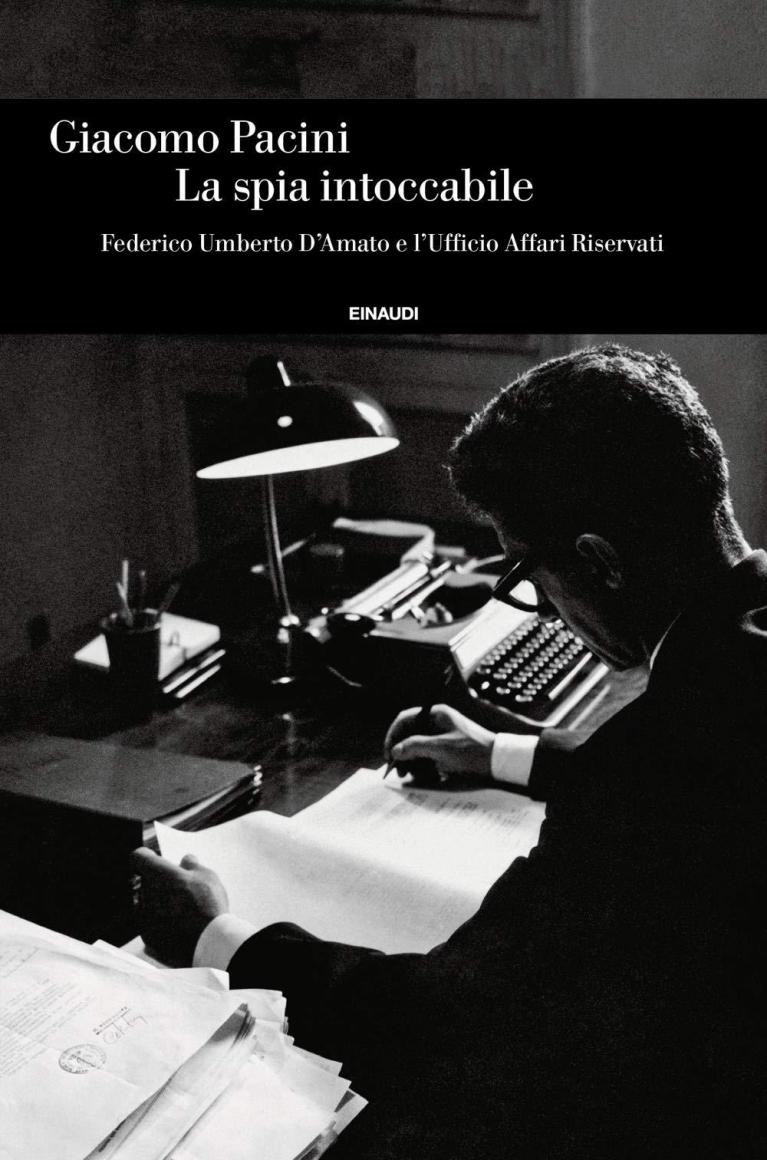1 – Prima sapere tutto. E, quindi, dimenticare tutto. Solo così lavora efficacemente il cantiere che trasforma una vita in una biografia.
Leggendo il notevole e puntiglioso saggio che Giacomo Pacini ha dedicato a La spia intoccabile. Federico Umberto D’Amato e l’Ufficio Affari Riservati, pubblicato da Einaudi, viene in mente questo consiglio dato da Lytton Strachey.
Per Lytton Strachey, impareggiabile cesellatore di biografie perfette, solo se si affronta la bruciante contraddizione che sta in ogni vita si può fare centro. Per trovare il bandolo della matassa di un’intera esistenza – dalla più semplice alla più complessa, quella di una “spia intoccabile” per esempio – non basta l’investigazione archivistica. Né l’acribia documentaria sostenuta da consolidate bussole storiografiche.
Per arrivare alla meta occorre anche accettare cose che fanno a pugni con le rappresentazioni che ci piacerebbe lasciare attorno al nostro lavoro di scavo. Al nostro procedere sulla pagina.
Forse – viene da suggerire a tutti coloro che si occupano di ricostruire storie sommerse del nostro recente passato – dovremmo lasciarci incendiare un poco di più dal dubbio. Dovremmo abbandonare il gratificante e algido piacere di dimostrare acutezza ad ogni riga.
Dovremmo consentirci, talvolta, di essere teporosamente confusi. Fraternamente ottusi. Esclusi, perfino. Perlomeno dall’accecante godimento del capire.
Dovremmo accettare, anche rispetto alla Verità, di essere, e di essere stati, “servi inutili”. Quindi indotti a non poter tagliare a metà il mondo con la riga che suddivide definitivamente il bene e il male.
Dovremmo riconoscere di essere cercatori di verità, a volte così smarriti, da rischiare di finire sul lato opposto della riva. Incrodati a ricostruzioni che pur apprezzate, rimangono in definitiva sterili. Perché scoratamente “evenemenziali”, incatenate alla carta degli archivi. Carta che, da sola, magari canta ma non fa risuonare la musica della verità. Tantomeno di una comprensione esaustiva. Né libera dal rischio di finire sottoposti alla perniciosa contaminazione tra l’investigazione storiografica e l’inchiesta giudiziaria, senza riuscire poi ad andare oltre. A darsi un colpo d’ala. Quello capace di far assurgere a una visione più alta, finalmente e definitivamente rivelatrice – dico a me stesso, per farmi coraggio – dei capitoli insanguinati e menzogneri della nostra storia. Quelli che ancora ci addolorano e ci avvelenano.
Dovremmo riuscire ad essere capaci di salire, lavorando assieme, verso qualcosa che si avvicini a un’ermeneutica delle stragi. A una morfologia del male che abbiamo avuto di fronte. Vicino. Accanto. A volte dentro.
Quel male insorto anche dentro quelle istituzioni che avrebbero dovuto garantire sicurezza e protezione alle nostre comunità. Alle vite e alle giornate dei cittadini che ne facevano parte.
Invece spesso siamo finiti dentro la fitta schiera di coloro che non hanno compreso. In compagnia di chi non ha capito tutto quanto era fondamentale capire. E possibilmente al più presto possibile. Non qualche decennio dopo.
2 – Non capire. A volte accade. È accaduto. Perché ci si è lasciati ingannare. Da ciò che era troppo complesso per quelli che erano allora i nostri attrezzi interpretativi.
O da quanto era così semplice, scontato e ostentato, da non lasciarsi scorgere.
Soprattutto se intravisto a distanza ravvicinata.
Cosa possibile per chi è stato contemporaneo e magari limitrofo – non importa se come avversario, dirimpettaio, competitore, interlocutore o perfino estemporaneo compagno di tavola o duraturo commensale – di chi, nell’affresco storico o biografico, regge il ruolo principale. Dunque, nel caso del libro di Pacini, quel prefetto Federico Umberto Amato che in anni cruciali è stato a capo dell’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno.
Struttura – che proprio negli anni Sessanta e Settanta in cui dovrebbe servire la sicurezza democratica della Repubblica, messa a rischio dallo stragismo e dal terrorismo – cambia abito e sigle con infinita disinvoltura. Quasi volesse emulare Arturo Brachetti, l’UAR nel maggio del 1969 diventa il SIGOP, suddiviso in SIIF e DOPS.
Però queste due creaturine, ancora in fasce, a soli due anni, siamo nel novembre del 1971, diventano rispettivamente la SIGSI e la SOPS.
A tenerle per le redini, come aveva fatto prima del loro nascere con le antecedenti creature spionistiche, è ancora lo stesso D’Amato. Apparentemente viene poi disarcionato, dal ministro Taviani, nel giugno 1974, dopo la strage di Brescia. Quando il SIGSI diventa l’IGAT che due anni dopo diventa l’SDS, soppresso poi a fine 1977. Con l’entrata in vigore della legge 801 che riforma i servizi di sicurezza e porta alla nascita del SISDE, del SISMI e del CESIS.
Tuttavia, nello stesso periodo, D’Amato, spostato a dirigere la polizia di frontiera, si comporta, fino alla pensione nel 1984, esattamente come prima. Da patron dei servizi di sicurezza e informazione della Repubblica. Un ruolo che viene negato da Virginio Rognoni, ministro dell’Interno dell’epoca che, deponendo in Commissione Stragi, minimizza con parole che Pacini scrupolosamente riporta: “Quando D’Amato veniva a trovarmi, avendo davanti un personaggio con quella storia, lo interrogavo. Gli chiedevo cosa pensasse, quali fossero le sue considerazioni. Si trattava di conversazioni dalle quali, peraltro non mi è mai arrivata una dritta. Se D’Amato ha fatto qualcosa probabilmente è avvenuto quando era titolare degli Uffici Affari Riservati in cui aveva l’iniziativa e gli spazi di lavoro che quell’incarico gli consentiva”.
Di lui, Francesco Pazienza, altro complesso protagonista delle trame più nefaste di quella stagione della nostra storia, darà in Il disobbediente, la sua autobiografia che pur fitta di spunti preziosi è da tempo sparita dal mercato editoriale, una sintesi fulminea: “Sapeva quasi tutto di tutti e quello che non sapeva, tutti pensavano lo sapesse”. Per questo lo temevano. Intuendo come la teologia del segreto abbracciata da quegli apparati fosse pressoché inseparabile dalla quotidiana liturgia dei ricatti che veniva praticata da chi li guidava.
In ogni caso, anche dopo la caduta di sella, estromesso formalmente dagli Affari Riservati, D’Amato ostenta il suo ruolo.
È ancora il signore delle Ombre e l’abitatore dell’Olimpo delle cose segrete. Afferma di esserlo anche dopo la pensione quando, come consulente e quasi precettore dei capi della polizia che si susseguono, percepisce, praticamente sino alla scomparsa, avvenuta nel luglio del 1996, un extra di svariati milioni (di lire) mensili. Oltre ad attingere a generosi rimborsi spese, esattamente come prima. Come ha fatto sempre, nel corso di una carriera che accompagna un lungo tratto di storia nazionale. Una parabola, percorsa puntigliosamente da La spia intoccabile che segue D’Amato dai primi passi, sullo sfondo del tracollo del regime mussoliniano, nell’estate del 1943, sino agli immediatamente successivi a Tangentopoli.
La ricostruzione storiografica di Pacini, tuttavia, si distende su un periodo più vasto, sia in questa recente biografia dedicata a D’Amato sia nel denso saggio, uscito da Nutrimenti editori nel 2010, su Il cuore occulto del potere. Storia dell’ufficio affari riservati del Viminale. 1919 – 1984.
Del resto, caso vuole che proprio in quel 1919, quando per decisione del presidente del consiglio Nitti, prende vita il Corpo degli agenti di investigazione che costituisce il nucleo fondativo di quello che sarà poi l’Ufficio Affari Riservati, venga alla luce anche Federico Umberto D’Amato.
Nasce e cresce. Evita il servizio militare. Entra nella polizia. È destinato poi, attraverso i passaggi che Pacini ricostruisce dettagliatamente nel suo libro, ad essere non solo responsabile dell’Ufficio Affari Riservati del ministero dell’Interno in anni cruciali ma, sino alla morte, l’impareggiabile patron dei segreti e delle loro trame. Quei ricatti che hanno avvolto, sino a quasi a strozzarla, la Repubblica Italiana nel suo primo mezzo secolo di vita.
3 – L’Ufficio Affari Riservati costituisce l’habitat utilizzato da D’Amato per costruire il ruolo che gli verrà attribuito. Un ruolo che lui stesso provvede a far aleggiare sul Paese attraverso i tanti tasselli espliciti ed impliciti, allusivi, apologetici e intimidatori, con cui contribuisce a raffigurare la propria parte di protagonista nascosto ma onnipresente delle vicende più scottanti del Bel Paese.
I due libri dello studioso grossetano condividono molto materiale documentario nel loro dispiegarsi. Ovviamente, non potrebbe essere altrimenti. Visto il procedere parallelo e l’apparente fusione, lungo i decenni, tra l’Ufficio e la persona che ufficialmente, o ufficiosamente, lo pilota.
In particolare il saggio più recente di Pacini si articola in cinque capitoli, ai quali è assegnato il compito di declinare le varie stagioni della parabola professionale di D’Amato dentro la struttura, operante all’interno del Viminale, che costituisce la sua creatura. Ma anche il suo modus operandi. La sua opera perdurante nei decenni.
Il plot da imprimere sulle vicende in corso. Suggerendo versioni e interpretazioni. Aggiungendo o espiantando tasselli. Sottraendo prove di crimini eclatanti – cosa che D’Amato ha fatto più volte; prove accedendo alle quali la verità, anche a livello giudiziario, sarebbe venuta a galla.
Una narrazione in infinito svolgimento e mobilissima evoluzione su quella scacchiera costituita dalla vita pubblica del Paese dove, come mobili pedine, stanno collocati anche loro. Agenti d’influenza; controllori; collaboratori; infiltrati; specialisti della disinformazione e della guerra non ortodossa; professionisti del caos. Insomma tutte quelle competenze ed esperienze professionali con cui gli apparati dell’Ordine e del Disordine, in ogni epoca, suonano il loro spartito sotto la direzione del D’Amato di turno.
Un D’Amato che qui è messo in scena da Pacini attraverso cinque capitoli assai ben documentati. Atti di una rappresentazione – “L’ombra dell’Ovra”; “L’ascesa di D’Amato”; “Il grande chef del Viminale”; “Strategia dell’infiltrazione” e “Nel cuore occulto del potere” – che costituisce l’impianto centrale del libro.
A questa parte si sommano, oltre a un sostanzioso corpo di note (55 pagine), un brevissimo epilogo e un rilevante incipit. Quest’ultimo è stato scritto a conclusione dell’intero lavoro. A costruzione ultimata appone un riorientamento non irrilevante all’intera architettura del libro. Infatti inserisce “at last minute” l’aggiornamento sulla recentissima iniziativa giudiziaria della Procura Generale di Bologna. È la conclusione dell’inchiesta che, chiamando in giudizio un nuovo imputato della strage del 2 agosto 1980, accusa il prefetto D’Amato, ovviamente non più perseguibile visto che è scomparso dal 1996, di essere uno dei mandanti, e finanziatori, di quello che costituisce il più pesante attacco stragista registrato in tutta la storia del Paese.
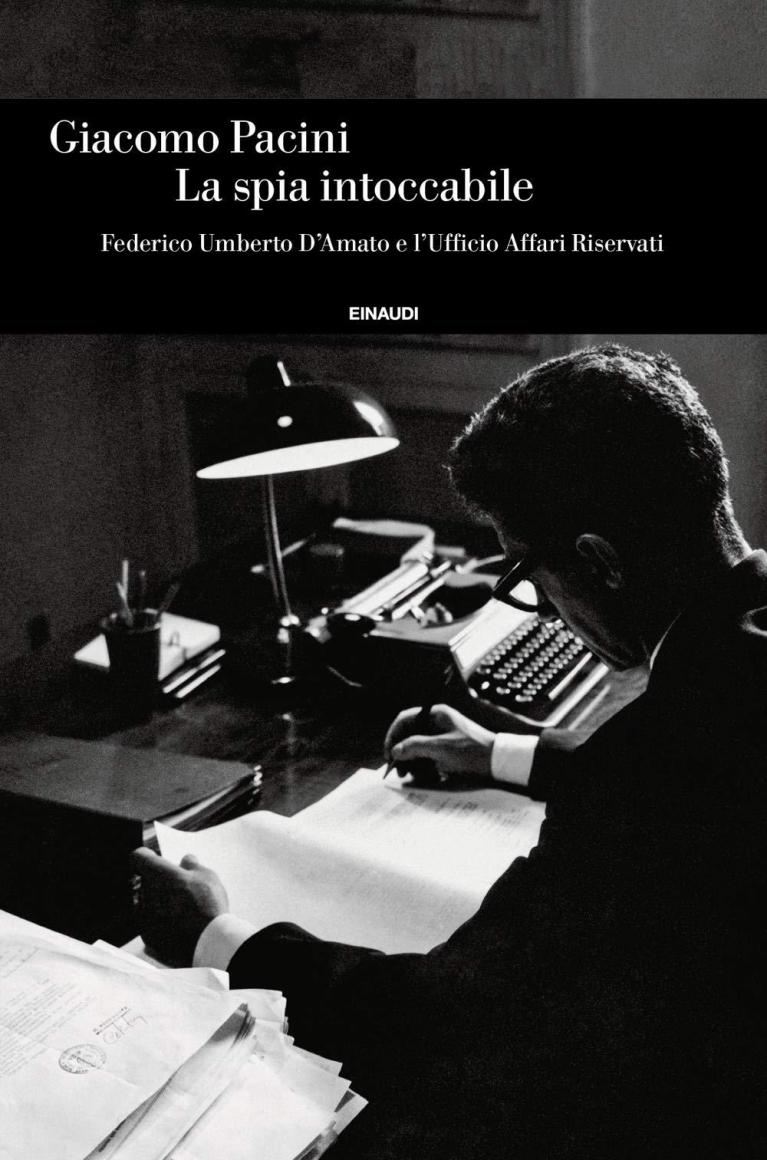
Una tesi che, se in fase dibattimentale fosse provata e accettata, farebbe di D’Amato una figura criminale tra le più feroci operanti nelle vicende della nostra Repubblica. Ponendola in una prospettiva assai divergente, e contradditoria, rispetto a quanto Pacini ha delineato nei cinque capitoli centrali che compongono la sua opera.
Capitoli costruiti su una rigorosa documentazione e giustamente severi verso l’intera parabola della “spia intoccabile” ma difficilmente compatibili col ruolo, ben più feroce, di mandante e finanziatore stragista che gli attribuisce, nella sua recentissima azione, la Procura di Bologna.
È proprio l’accusa contro D’Amato, emersa nella recente iniziativa della magistratura di Bologna, che obbliga Pacini, nel suo incipit, a non celare come, dentro l’affresco biografico che sta per esporre, emergano crepe.
Contraddizioni non irrilevanti. Si pongono in sintesi tra lo stagliarsi sulfureo e criminale di un D’Amato mandante e finanziatore della strage di Bologna, secondo i PM di Bologna, e il ritratto dello “sbirro” spregiudicato e onnipresente, sottratto al rispetto della legge in nome di chissà quali arcana imperii, che emerge in tante pagine.
Una contraddizione che si fa evidente focalizzando l’inizio del declino di quello che è stato il sempiterno patron degli Affari Riservati. Un declino che va di pari passo all’irrobustirsi, proprio da parte di D’Amato stesso, di quella auto-narrazione che lo ha sempre accompagnato. E che, negli ultimi anni, si fa bulimica e illusiva. Fatta di mezze verità e molte bugie.
Di memorie ben ritoccate e ricordi evocativamente indirizzati a proteggere e conservare – grazie anche all’inarrestabile e indubitabile vocazione a tenere in vita il personaggio della “spia intoccabile” che lui stesso ha creato – equilibri a lui favorevoli. Almeno dentro quel mondo nel quale si è sempre mosso e nel quale chiuderà gli occhi.
Un mondo fatto di segreti e di menzogne che gli hanno consentito di far proliferare la sua vasta rete di infiltrazioni in ogni scacchiere politico, di potere o sovversivo che sia. Infiltrazioni che gli consentono di declinare le sue narrazioni e le sue relazioni – variandone il plot, il contesto, i protagonisti e il senso del loro agire – in funzione delle molteplici prospettive alle quali risponde. Narrazioni che spende a seconda del variare dei cieli che stanno sopra l’Olimpo del potere ma, avendo come bussola costante, non solo la propria carriera ma anche quella voracità che lo porta a razziare in tutte le occasioni il massimo del vantaggio economico. Ramazzando soldi, proprietà, agi sino ai suoi ultimi giorni.
4 – Ricapitolando: prima, sapere tutto. E, quindi, dimenticare tutto, raccomandava Lytton Strachey.
Per poi procedere oltre e fare centro. Per riuscirci occorre far buon uso delle dense pagine del libro di Pacini che, non a caso, contengono anche espliciti interrogativi sulle ipotesi avanzate dalla Procura di Bologna. Per afferrare la bruciante contraddizione di una vita e di una carriera quale quella di D’Amato occorre però aprire una più ariosa e scompigliata finestra. Sporgersi sul gioco narrativo che D’Amato conduce lungo tutta la sua vita.
Partire da lì forse consente di rendere più leggibile l’intreccio – per dirla con lo sguardo assunto da Caillois in I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine – che dà forma al racconto che la spia intoccabile dà di se stessa. A quell’incrocio dove alea e agon, mimicry e ilinx si sfidano e si fondono.
Anzi, ci sfidano e ci provocano, quasi irridendoci.
Ad esempio con il gioco delle identità che D’Amato fa comparire nella sua ricostruzione della sua vita. C’è lo sbirro Federico Umberto D’Amato e tutta la sua carriera. A cominciare dagli inizi in una Roma “città aperta”, dove incontra il suo maestro e sempiterno padre spirituale, James Jesus Angleton.
Angleton, avendo seguito nel 1937 suo padre dislocato alla AmCHAM, la Camera di Commercio Americana in Italia, ha imparato l’italiano e studiato Dante per poi tornare negli USA. Dove, prima di essere reclutato tra i giovani quadri dell’OSS, il servizio segreto creato dal generale Bill Wild Donovan su ordine di Roosevelt per battere Hitler anche nella guerra delle spie, fa tempo a impiantarsi a Yale e fondarvi una rivista di poesia, “il Furioso”. Vi coinvolge T.S. Eliot, William Carlos Williams, e. e. Cummings, Robert Frost. Con Wallace Stevens diventa amico. Fanno lunghe passeggiate nei boschi attorno ad Hartford.
Poi, lasciata la letteratura per lo spionaggio, diventerà per un ventennio il dominus incontrastato della CounterIntelligence americana incaricata della caccia alle spie sovietiche. E, paradossalmente, Angleton sceglie come suo modello e maestro Kim Philby, l’uomo che gli inglesi del Circus hanno mandato a Washington come ambasciatore dell’intelligence inglese presso i cugini americani. Quando Philby scappa in Russia, essendo stato scoperto che è una spia del KGB, Angleton impazzisce e vede spie ovunque.
Il mondo delle spie e dei segreti italiano è palcoscenico ben più piccolo e irrilevante di quello che vede l’epopea di Angleton.
Tuttavia l’Italia, durante la Guerra Fredda, è sui bordi della Cortina di Ferro. Lo “sbirro” D’Amato apprende presto che stare a cavallo delle frontiere, e dei mondi che vi si affacciano, conferisce potere e influenza. Soprattutto in quel piccolo mondo provinciale che sono ancora i Palazzi della politica e del potere romano dove è marcata, ma anche assai porosa, la linea che divide potere e sovversione. Filo-atlantici e comunisti.
Lo stare a ridosso delle frontiere e tenere sotto controllo clandestine irruzioni che le oltrepassano (come quella dei congiurati dell’OAS francese, a cominciare dall’ex-premier di Parigi Bidault diventato il principale oppositore di De Gaulle e della decolonizzazione algerina) fornisce a D’Amato asset decisivi per la sua carriera.
La gestione del fermo e della discreta estromissione dall’Italia dei capi dell’OAS lo fa diventare un interlocutore dei piani alti del Viminale. Dove peraltro è già ben considerato per l’acquisizione e il trasloco dei dossier più riservati dell’OVRA, la polizia fascista, dal vecchio regime agli apparati polizieschi della Repubblica. Dossier che sono passati attraverso le sue mani. Mandato proprio da Angleton al Nord, ad acquisire – prima del crollo della Repubblica Sociale – dossier e alti funzionari, da inserire in quella che poi sarà la filiera della continuità tra vecchio e nuovo dentro non solo il Viminale ma in tutto i Palazzi che contano a Roma.
Tornato nella capitale, nell’interregno dei governi che includono la sinistra, è comune opinione che robusti rivoli informativi siano giunti, chissà attraverso chi, sino a coloro che poi saranno relegati all’opposizione. E che dunque si troveranno in mano qualche carta utile per non interrompere il dialogo, dentro gli apparati, tra salvati e sommersi. In nome della continuità dello Stato.
5 – Sono anche gli anni in cui D’Amato stende la rete di infiltrati degli Affari Riservati dentro i partiti. Di governo e di opposizione. Essere uno spione significa stare sul mercato delle informazioni e farne intermediazione. Comprarle e venderle. Oppure semplicemente fare da tramite per farle arrivare, vere o finte che siano, al destinatario giusto. Attraverso dirigenti politici. Intellettuali. Giornalisti. Uomini d’affari. Gente di chiesa. Tutto questo è quello che, anno dopo anno, impegna le giornate dello “sbirro” Federico Umberto D’Amato.
Ma, dentro le stesse giornate, opera un altro Federico Umberto. Di cognome fa Godio. Il cognome di sua madre, una cameriera piemontese che lo ha messo alla luce a Marsiglia. E che gli dà il suo nome prima che il padre naturale, sergente in congedo e poi quadro della Pubblica Sicurezza, la sposi. E riconosca il figlio.
Padre naturali. Padri spirituali. Sono tante le leggende e le faccende che Federico Umberto fa ruotare attorno ai padri.
Mentre Federico Umberto D’Amato scala l’Olimpo dei segreti, al Viminale, Federico Umberto Godio vive la sua vita parallela, ma intrecciata e funzionale al ruolo del suo “alias”. La gioca ad esempio nel mondo del cinema. Del giornalismo. Della Televisione.
È suo, di Federico Umberto Godio il soggetto del film Il ricatto di un padre, regia di Giuseppe Vari (una cinquantina di film, un diluvio di pseudonimi creatore comunque dei “western all’italiana”).
Ecco un esempio concreto di cosa sia sapere tutto e dimenticare tutto. E poi afferrare le contraddizioni dello sbirro D’Amato, patron di tanti ricatti nei palazzi del potere. Per fondere l’insieme occorre anche andare al cinema. E vedere Il ricatto di un padre.
Ma anche le trasmissioni televisive di cui è autore – nel cuore degli anni Settanta, quando dovrebbe pilotare le trame segrete del Viminale tra stragi, bombe, terroristi e brigatisti – non sono male. Come pure i documentari sulla Sardegna e altro ancora.
A Federico Umberto D’Amato e a Federico Umberto Godio una doppia vita, però, non basta.
Gliene servono di più. Ed ecco allora far capolino, e perdurare a lungo sulle pagine del settimanale “Il Borghese” gli spifferi su segreti, trame e complotti firmati da Abate Faria. È sempre lui, naturalmente. Lo sanno tutti, nella Roma dove tutti sanno tutto di tutti. E nessuno si sorprende perché al bazar dei segreti svenduti e dei ricatti in allestimento non si respinge nessuno.
Quando un segreto o uno spiffero devono emergere non manca certo il giornalista giusto che non si fa scappare l’occasione di fare uno scoop.
Un esempio?
I verbali del primo pentito brigatista, Patrizio Peci dai quali – nel 1980, nel bel mezzo dell’offensiva terroristica – emerge che tra i leader e i killer della formazione “Prima Linea” c’è anche il figlio di Donat-Cattin, ministro della Repubblica in carica e potentissimo capo-corrente democristiano. Quelle pagine riservatissime vengono passate a Fabio Isman, giornalista del “Messaggero”.
Lo stesso documento però qualcuno provvede a farlo arrivare anche alla redazione di Lotta Continua, formazione nella quale il giovane Donat-Cattin ha brevemente militato.
Nel documento, almeno nella versione arrivata al quotidiano extraparlamentare, manca però un foglio. Non ci crederete: è proprio dove si fa il nome del terrorista, del figlio del ministro. Lotta Continua pubblica il documento. Però, scrupolosamente, avvisa i lettori: “nel verbale manca un foglio”.
Purtroppo un improvvido refuso tipografico pare abbia mutato la frase. Il “nel verbale manca un foglio”, nel giornale che arriva in edicola all’indomani, diventa “nel verbale manca un figlio”. Chi vuole capire, capisca.
Mi sono appassionato a raccogliere, nelle storie che riguardano D’Amato, alcuni altri esempi di questo vertiginoso confondersi, tra testo e parole, di una realtà cangiante che sembra cambiare a seconda della visuale che la osserva.
Non è qui possibile sintetizzarle. Basti un ultimo esempio. Riguarda il conto cifrato svizzero di D’Amato. Quello su cui si impernia l’accusa di finanziatore e mandante della strage formulata dai magistrati bolognesi.
Un conto a cui D’Amato attribuisce un nome, OGGICANE, di difficile interpretazione. A meno di pensare possa essere la risposta irridente del patron delle trame e dei ricatti a chi giunge fin sulla soglia di uno dei suoi segreti.
OCAGGINE, a quanto mi risulta, è l’anagramma, il più dotato di significato, di OGGICANE.
Il gioco narrativo dispiegato da D’Amato va oltre i capitoli di La spia intoccabile e scavalca quell’incipit denso di giusti interrogativi posto da Pacini nell’avvio della sua opera. Chiamerebbe, avendo spazio e tempo, a proseguire.
E rimarrebbe ancora comunque l’esplorazione, sicuramente feconda di spiazzanti risultati, della sua militanza di critico gastronomico. Con tanto di rubrica su L’Espresso e ruolo di coordinatore delle guide Gault e Millau. Dopo le accuse dei giudici bolognesi inquieta vedere come, avendo come autore sempre Federico Godio, sia uscita, l’anno successivo la strage alla stazione, una guida dettagliata ai ristoranti di Bologna. Ma altrettanto inquietante è leggere, in un’introduzione a un’altra sua guida gastronomica, come nell’anno che ha visto il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro l’autore, vale a dire il gastronomo ma anche il funzionario che seppur ufficiosamente è tra i vertici dei servizi di sicurezza del Bel Paese, abbia dedicato il suo tempo a percorrere la penisola, in lungo e in largo, “con la forchetta tra i denti”.
Forse è anche attorno a queste narrazioni che bisogna tornare.
Poiché “Non è dal viso che si riconosce un uomo, ma dalla maschera che porta”, ammoniva Karen Blixen.
Forse sta anche in questo gioco narrativo la sostanza del ruolo che “la spia intoccabile” ha scelto di svolgere con la sua lunghissima parabola dentro gli apparati polizieschi del nostro Paese.
L’agire da patron degli Affari Riservati e il gioco narrativo sotto altre maschere si compongono in un tutto unito e si fondono.
Rappresentano forse una connotazione che accomuna le più recenti stagioni della storia della Repubblica.
Connotazione che, se le parole dovessero tristemente corrispondere alla realtà, finirebbe con l’espiantare dalla nostra Costituzione il primo articolo. Sostituendolo con la sconsolata ammissione che “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul ricatto. La sovranità appartiene al segreto che la esercita nelle forme e nei limiti imposti dalla menzogna”.