Quello che accade in quella mattinata fiorentina del 15 aprile 1944 all’ingresso della villa di Montalto, sui primi colli di Firenze, è stato rievocato più volte. Un’auto scura giunge davanti ai cancelli della costruzione ottocentesca dove da qualche tempo, lasciata Roma, ha trovato rifugio, con la famiglia, il filosofo Giovanni Gentile. Già ministro dell’istruzione, fondatore dell’Enciclopedia Italiana, ritenuto l’intellettuale più prestigioso del regime fascista, il filosofo presiede l’Accademia d’Italia che, dopo che l’Italia si è spaccata in due nel settembre 1943, si è incamminata anch’essa verso i territori della Repubblica Sociale Italiana, traslocando da Roma a palazzo Serristori, a Firenze.
Gentile, come tutti i giorni, si è fatto portare in città dall’autista. E’ stato alla sede dell’Accademia dove ha incontrato diversi collaboratori e vi ha convocato il questore di Firenze, per essere aggiornato sulle indagini sulla tragica morte di Fanelli, il suo segretario, vittima pochi giorni prima, nella casa di campagna dove abitava, di una selvaggia irruzione di soldati della divisione “Goering”.
In quel 1944 la strada che dal centro conduce a Montalto si percorre in un quarto d’ora. L’autista, giunto in prossimità della villa, suona il clacson. La custode esce per aprire il cancello. L’auto, con Gentile a bordo, è lì, ferma, davanti all’ingresso. Quello che succede nei pochi istanti successivi è riassunto, con burocratica prosa, nel rapporto di polizia: “Due giovani, dall’età di 20 e 25 anni, entrambi con bicicletta che portavano a mano, si avvicinavano. Il primo di essi, fattosi avanti, domandò: “Siete voi il professore?”. Avuta risposta affermativa, tutti e due gli sconosciuti gli spararono più colpi di rivoltella e subito inforcate le biciclette si dileguarono. L’autista, visto il proprio padrone accasciato nella vettura, senza indugio lo trasportò all’ospedale di Careggi dove giunse cadavere”.
Poche righe di un verbale poliziesco a cui corrisponderanno, nei decenni successivi, decine di approfondimenti storici, contrastanti interpretazioni politiche e polemiche mai sopite. Settanta anni dopo, l’interesse non si è ancora spento: ecco infatti fresco di stampa il denso libro di Luciano Mecacci, La Ghirlanda Fiorentina e la morte di Giovanni Gentile, Adelphi edizioni.
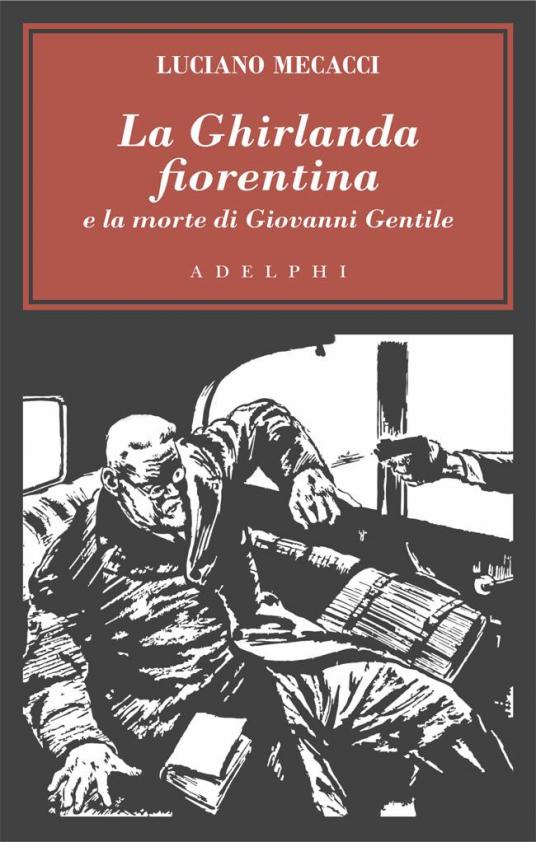
Il saggio si apre quasi come un mosaico da ricomporre. Inizialmente affronta il lato investigativo di quel 15 aprile, sgombrando pazientemente il campo dai cangianti e depistanti scenari che via via si sono succeduti. Dunque, come in ogni “giallo politico” italiano che si rispetti, si fanno i conti con atti processuali volatilizzati, prove sostituite, testimoni reticenti, mitomani che riscrivono la storia.
Alla fine Mecacci stringe una verità pressoché inoppugnabile e risaputa: l’azione è condotta dai GAP comunisti su ordine del Partito Comunista, l’unica forza del resto che dentro il Comitato di Liberazione Toscano rivendica l’azione. Era il rifiuto perentorio del penoso appello di Gentile alla conciliazione nazionale sotto la regia di quello stesso Mussolini che aveva portato il Paese alla distruzione e alla guerra civile.
L’appello, prima sotto forma di un discorso pronunciato da Gentile a Roma, il 24 giugno 1943, dunque appena prima dello sbarco alleato in Sicilia e del Gran Consiglio del Fascismo che sfiducia Mussolini, viene reiterato in articolo di Gentile uscito sul Corriere della Sera il 23 dicembre 1943.
In questo lasso di tempo è accaduto di tutto: l’arresto di Mussolini da parte del re e la sua liberazione da parte delle SS di Hitler, l’insediamento del governo Badoglio e l’armistizio con gli alleati reso noto l’8 settembre con successivo e traumatico “tutti a casa” nel corso del quale il popolo italiano vede lo sbando del Regio Esercito con i nostri reparti abbandonati a se stessi e la fuga da Roma del re e dei generali.
È la spaccatura dell’Italia in due (Regno del Sud e Repubblica di Salò) e l’avvio, da parte dei primi nuclei di partigiani che salgono in montagna, della Resistenza.
È l’inizio di quella guerra partigiana alla quale non sì è precettati da alcuna autorità ma dalla propria convinzione morale e che porta una minoranza di italiani a prendere le armi in un conflitto che, come ha dimostrato lo storico Claudio Pavone, ha una triplice connotazione: è guerra d’indipendenza per liberare il Paese dall’occupante nazista; è una guerra civile tra italiani che ha come posta finale la sconfitta del fascismo in tutte le sue declinazioni, dal regime ventennale autoritario alle ultime versioni mussoliniane messe in scena con la Repubblica di Salò; è, infine, anche scontro di classe, almeno nelle intenzioni di molti partigiani che auspicano un ribaltamento sociale finalizzato a uno sbocco rivoluzionario.
Non a caso Claudio Pavone aveva intitolato la sua opera principale Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza: lì vi affrontava finalmente un tema troppo a lungo rimosso e che invece costituisce il nodo centrale della Resistenza e del suo rappresentare la sorgente di una rinnovata moralità, una moralità che essendo davvero tale, e non solo moralismo (ovvero rispetto di norme consolidate e diffuse), obbliga ogni coscienza individuale, ancora prima che le formazioni o gli schieramenti in campo, a fare i conti anche con l’incandescente e tragico tema della violenza.
L’interrogativo è quello che Primo Levi si pone ne I sommersi e i salvati: “Esiste una violenza utile?”. Levi risponde: “Purtroppo, sì”, aggiungendo che, in questo percorso terribile, “la sofferenza è un sottoprodotto, un di più”. “Un di più” però tutt’altro che irrilevante e sul quale si tracciano confini invalicabili e che aiutano a rammentare sempre – è ancora Levi che lo ricorda – come oppressore e vittima “sono nella stessa trappola, ma è l’oppressore, e solo lui, che l’ha approntata, e fatta scattare”.
Non è un caso che il punto centrale del libro di Mecacci, punto che tuttavia nel torrentizio fluire di elementi e spunti che formano la ricostruzione a mosaico della vicenda rischia di andare perso di vista, sia dato proprio dal nodo della violenza e dunque dalla motivazione, tutt’altro che segreta, esplicitata infatti prima dell’esecuzione del filosofo, che porta una componente fondamentale della Resistenza quale il PCI a deliberare la condanna a morte del filosofo del fascismo.
Questo nodo attraversa – proprio al centro del saggio – le pagine dedicate a due testi contrapposti che a poche settimane dall’esecuzione di Gentile si confrontano proprio sul tema della moralità (e del moralismo), dunque della questione morale, calata nel terribile scenario che sta caratterizzando in quel periodo l’Italia.
Gentile nel gennaio del 1944 apre con un articolo intitolato “Questione morale” il primo numero di “Italia e civiltà”, una rivista che esordisce proprio a Firenze dove ha trovato rifugio l’Accademia d’Italia e il suo presidente.
Gentile vi ribadisce quanto ha già detto nel suo discorso del 24 giugno 1943 in Campidoglio a Roma quando chiamando gli italiani alla pacificazione per far cessare “le lotte interne, le persecuzioni, le recriminazioni maledette che intorbidano e dividono gli animi”, non vede altra soluzione che affidarsi “a un uomo che ebbe già la fiducia di tutti gli italiani e parve la voce antica e sempre viva della Patria”.
Mussolini, insomma, come terapia e antidoto alla guerra civile. E la “fusione degli spiriti in un volere concorde di italianità” come risposta a quella “questione morale essenziale, sentita da tutti, urgente” davanti al vacillare di dignità, onore e “fedeltà al giuramento prestato”.
Sono temi non nuovi, in Gentile, e vi si riodono quelle motivazioni con le quali, in nome della fedeltà al giuramento al regime mussoliniano da lui patrocinato, aveva preparato la cacciata dall’università italiana, nel 1931, dei pochi coraggiosi che in coscienza avevo respinto l’intimazione che avrebbe consentito loro di stare in cattedra a patto di assumere un nuovo dovere. Quello, imposto per legge, di formare sudditi fedeli al fascismo.
Quasi a rispondere all’articolo di Gentile all’inizio del febbraio del 1944, su “La nostra lotta”, organo clandestino del Partito Comunista nell’Italia occupata dai tedeschi, esce un articolo – che poi si saprà scritto dal latinista Concetto Marchesi, già rettore magnifico di Padova, riparato in Svizzera – durissimo nel respingere le tesi di Gentile. A questo articolo che Marchesi, attraverso il filosofo Antonio Banfi, fa arrivare a Milano nelle mani di Girolamo Li Causi, responsabile della stampa clandestina del PCI, sarà apposto dallo stesso Li Causi il finale col verdetto di morte sancito verso Gentile:
“Per i manutengoli del tedesco invasore e dei suoi scherani fascisti, senatore Gentile, la giustizia del popolo ha emesso la sentenza: morte!”.
Ma Banfi non solo è tramite dell’articolo che uscirà su “La nostra lotta”. Quasi ad affrontare in modo esaustivo e definitivo le ultime prese di posizione di Gentile, nel gennaio del 1944 ha fatto uscire un suo breve saggio – non a caso intitolato “Moralismo e moralità” – sulla rivista “Studi filosofici”, appena prima che le autorità fasciste impongano la cessazione delle pubblicazioni. Chiarissima nel saggio la distinzione che fa Banfi, in aperta polemica con Gentile, tra moralismo e moralità: “Il moralismo, nonostante tutte le sue intenzioni pedagogiche, mira piuttosto a giudicare il mondo che a costruirlo moralmente; che anzi alla sua costruzione si oppone proprio con il suo astratto idealismo scettico, con il suo soggettivismo, col suo disprezzo per l’oggettività etica e la realtà umana”.
La moralità, invece, non è un’architettura astratta ma il lavoro quotidiano che, davanti alla “disarmonia etica” che ferisce l’individuo e la società, opera per partecipare e ricostruire insieme: “affermare libertà e giustizia in un mondo di schiavitù e ingiustizia significa moralmente non un atto di fede di un’anima bella che si ritrae dal mondo ma la volontà di un’attività concreta per cui da questo mondo – dalla sua estrema negatività vissuta e sofferta – deve sorgere libertà e giustizia, come feconde forme di vita”.
Dentro questa visione morale la violenza, non più esclusivo tratto connotativo dello Stato che governa in modo esclusivo l’uso della forza ma terreno su cui si trova a procedere chi ha risposto all’appello della sua coscienza a liberare il Paese dall’invasore e dalla dittatura, trova la sua giustificazione: “Così nessun fine giustifica la violenza come mezzo e tanto meno la violenza si giustifica come fine a se stessa; ma la violenza – conclude Banfi nel suo saggio – può divenire forza costruttrice di un mondo, in cui si libera, si concreta e si estende la vita morale, e perciò assunta in questa e in questa illuminata”.
Il saggio si rivolge prospetticamente ai giovani, quelli più sensibili intellettualmente e impegnati contro il nazismo e il fascismo, che sul nodo della violenza e del suo uso si stavano interrogando non teoricamente ma nella dimensione più tragica e quotidiana. Banfi indicava la necessità di una soluzione che andava in un senso che decenni dopo Rossana Rossanda, che di Banfi era stata allieva alla Statale di Milano, sintetizzerà: “Banfi aveva scritto “Moralismo e moralità” per noi. Bisognava chiudere con l’Italia, la sola che avevamo veduto, dove il confine tra il fascismo e il non fascismo era stato incerto, ora lo sapevamo, e senza la guerra sarebbe durato”. Dove quel riferimento alla “guerra” indica non solo la lotta per l’indipendenza nazionale che impegnava le formazioni partigiane ma la guerra civile che era deflagrata in quel preciso contesto storico.
Quella “guerra civile” nella quale si colloca anche l’azione dei Gap che eseguono la sentenza di morte contro Gentile, il massimo ideologo del fascismo.
Altri aspetti rilevanti offre il saggio di Mecacci su cui, se lo spazio non fosse tiranno, ci si dovrebbe soffermare: ad esempio il puzzle accademico e culturale che la morte di Gentile frantuma e poi ricompone, portando alla luce la strabiliante capacità di molti “chierici” italiani di adattarsi ai più drastici cambiamenti senza cadere mai di sella.
Sfilano in ruoli assai diversi Croce e Banfi, Marchesi e Calogero, un lucidissimo Dionisotti e un amletico Garin, avversato da un sulfureo ma trasparente Mario Manlio Rossi. Sul palcoscenico transitano in tanti: chi apportando adamantina chiarezza e chi dissimulazione (più o meno onesta), rancorosi umori personali e consapevolezza intellettuale. Sullo sfondo altre figure ancora. Sono le ombre degli uomini dell’intelligence europea alle prese con Firenze e con il futuro dell’Italia. Come quel professor John Purves, studioso scozzese di letteratura italiana, che sin dal ’38, al tempo del viaggio di Hitler a Roma e a Firenze, viene mandato in avanscoperta sull’Arno. E ne torna a Londra con un diario (la “Ghirlanda fiorentina”, questo il titolo che dà al suo quadernetto) denso di note su personaggi che ha incontrato. Una ghirlanda di nomi, del mondo politico e culturale, da sfogliare, uno per uno. In vista del futuro che stava per arrivare.

