Nel mese di marzo e aprile, ho avuto modo di viaggiare in Giappone soprattutto nelle zone rurali di Shikoku e Setouchi, oltre che girare nella regione di Kansai (Kyoto, Nara, Osaka e dintorni). Shikoku è una delle quattro isole principali che costituiscono l’arcipelago nipponico, pari a tre quarti della superficie della Sicilia. Setouchi è il nostro mare interno, una sorta di mediterraneo giapponese circondato da Honshu, l’isola più grande dell’arcipelago, Kyushu (un’isola assai più grande della Sicilia) e la stessa Shikoku, con una miriade di piccole isolette sparse all’interno. È una regione bellissima con clima mite e acqua cristallina. Non era proprio la prima volta che visitavo quella zona, ma in precedenza ero stato solo una volta in una città di Shikoku e solo per pochi giorni. Quindi, anche per me era tutto da scoprire.
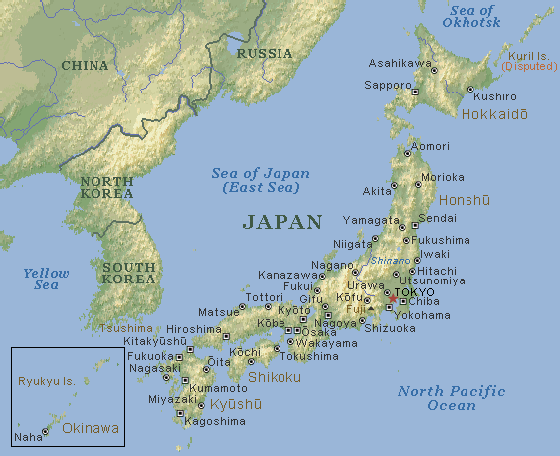

Giappone Shikoku e Setouchi
Lo scopo di questo viaggio, originariamente, era accompagnare un amico architetto italiano, docente presso una prestigiosa università del nord Italia, che aveva ottenuto una borsa di studio per una ricerca in Giappone. Lui era interessato a studiare minka, l’architettura vernacolare giapponese, e a indagare conoscenze e tecniche di vita sostenibile ancora praticate nelle zone rurali del mio paese. A parte il fatto che condivido pienamente i suoi interessi accademici, era per me un’occasione imperdibile per osservare ancora una volta, con i miei occhi, l’entità dell’impatto della modernizzazione nipponica iniziata con la Rivoluzione Meiji alla fine dell’Ottocento – e accelerata in modo esponenziale dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale – per cercare di comprendere il meccanismo socio politico che ha permesso un tale scempio irrecuperabile.
Il nostro itinerario, che comprendeva molte zone rurali ma anche zone urbane, sembrava studiato apposta per attraversare in pochi giorni tutta la Storia di questo paese dal dopoguerra a oggi, dal passato al presente, scoprendo “fisicamente” la natura della devastazione socio-culturale e ambientale che gli stessi giapponesi hanno compiuto su se stessi negli ultimi decenni. Uno scempio immane, di cui quasi nessun orientalista o iamatologo all’estero parla. Di solito si parla del Giappone antico, rappresentato dalla bellezza eterna dei giardini e delle arti tradizionali, oppure del Giappone moderno, rappresentato dalla tecnologia della Sony o della Toyota, e non viene quasi mai approfondita la ricerca sul loro rapporto contraddittorio, o meglio, sul vero ritratto della devastazione del primo compiuta ad opera del secondo. Un processo di trasformazione cominciato nella seconda metà dell’Ottocento, ma che solo negli ultimi decenni ha finito per cancellare ogni traccia del Giappone anteguerra. Oggi quello che vediamo comunemente in Giappone è una bruttezza diffusa, quantità abnorme d’insegne e cartelli, paesaggi naturali ovunque ricoperti dal cemento, periferie infinite senza identità, architettura scadente con finti chalet svizzeri accanto a villette all’americana con bovindo.

In città, spesso non c’è un muro senza insegne. Hanno qualcosa di giapponese ?
Va detto però che nemmeno la maggior parte dei giapponesi sembra rendersene conto. Tutto sembra rimanere invisibile, quando invece tutto è sotto gli occhi di tutti, senza mistero. Semplicemente, l’argomento non viene mai inquadrato nel campo visivo della Storia. Eppure, questa trasformazione del territorio e della cultura della vita quotidiana, manipolata, in questo caso, dallo Stato, non riguarda solo la recente storia del dopoguerra, ma ha a che fare con l’essenza stessa del Giappone. Non è la prima volta che cancelliamo con tanta nonchalance quello che abbiamo, soprattutto il nostro passato. In realtà è un gesto, direi, consueto, già ripetuto nella Storia del Giappone. Di questo parleremo meglio un’altra volta, per ora basti dire che è nel nostro DNA. Solo che questa volta la vastità della devastazione è immensa, sicuramente peggio delle due bombe atomiche cadute su quello stesso suolo nel 1945.
Un americano in Giappone
Ma per parlare di quest’argomento, vorrei soffermarmi un attimo sul nostro incontro con Alex Kerr (1952), un signore americano che vive in Giappone da oltre 40 anni. Vi chiederete cosa c’entra un americano, ma nessuno meglio di lui ha mai osservato e raccontato con lucidità quello che sto per raccontarvi del Giappone.
Alex Kerr è arrivato per la prima volta in Giappone da ragazzino, nel 1964, l’anno delle Olimpiadi di Tokyo, per via del lavoro di suo padre che era un avvocato che lavorava per la marina americana. La famiglia Kerr ha vissuto un paio di anni a Yokohama e al piccolo Alex piacevano molto le case tradizionali giapponesi, eleganti con la loro struttura architettonica complessa, che all’epoca esistevano ancora normalmente. Dopo il suo ritorno in America, ha compiuto studi sul Giappone e sulla Cina, rispettivamente all’università di Yale e a quella di Oxford, per poi rientrare in Giappone nel 1971, quando fece un lungo viaggio in autostop attraversando l’arcipelago da nord a sud. Fu alla fine di quel viaggio che arrivò nella Valle di Iya, in mezzo alle profonde montagne di Shikoku, e s’innamorò del paesaggio incontaminato e delle sue architetture vernacolari che in giapponese chiamiamo minka (letteralmente significa “casa popolare”). Dall’anno successivo iniziò a esplorare centinaia di minka della zona per trovarne una per sé, e finalmente nel 1973 acquistò un terreno con una minka del 18° secolo abbandonata da 17 anni e iniziò a ristrutturarla. In questa zona, come nelle altre, le minka erano case di contadini, ma quella acquistata da Kerr (in realtà pagò solo il terreno, la casa era gratis) era più grande delle altre. Più tardi la battezzò Chiiori con due ideogrammi 篪庵. “Chi” (篪) (si pronuncia “ci”), che significa flauto di bambù, e “iori” (庵), piccola casa, eremo.
Da allora “salvare” vecchie minka dall’incuria e dall’abbandono, e ristrutturarle e dar loro una nuova vita come strutture alberghiere, è diventata per lui una sorta di missione.
Oggi Kerr non vive più a Chiiori, che è diventata anch’essa una struttura alberghiera. Si può prenotarla e dormire lì. Così abbiamo fatto anche noi. Verso la fine di marzo abbiamo soggiornato a Chiiori una notte. Ed è stata un’esperienza memorabile. È forse la minka meglio ristrutturata che io abbia mai visto. Ha un grande spazio vuoto, bellissimo. L’amico architetto, entrandoci dentro, ha esclamato “il trionfo dello spazio vuoto!”. Chiiori ha mantenuto molto bene la sua fisionomia originale fatta di legno massello con travi e pilastri molto grossi, muri di terra e vegetali e tetto di paglia mirabilmente restaurato, ma è dotata di tutte le innovazioni tecnologiche che rendono possibile viverci anche in pieno inverno, tutte abilmente nascoste, a cominciare dal riscaldamento sotto il pavimento. All’interno delle minka di una volta, d’inverno, faceva molto freddo e a marzo a Iya la temperatura è ancora molto bassa.

Una cascata a Iya. Il villaggio di Ochiai nella Valle di Iya. Chiiori.
Qualcuno potrebbe rimanere molto stupito nel sapere che questo spazio così raffinato e ricco di qualità era una volta una casa di contadini. Tutta questa bellezza, oggi ulteriormente sottolineata da piccoli tocchi squisiti del proprietario come Ikebana o meravigliose calligrafie sulle Shôji (le porte scorrevoli con la struttura di legno ricoperta di carta giapponese), era a portata del popolo. La qualità e la bellezza non erano concetti necessariamente legati al lusso, che Bruno Munari considerava stupido. La minka è il risultato di una progettazione coerente con l’ambiente, con la tecnica e i materiali disponibili sul territorio. È una specie di corpo semi-vivente che sembra cresciuto dalla terra stessa e respira e invecchia col tempo. Non si oppone né ignora l’entropia come l’architettura moderna. Per questo vi regna un’estetica realmente organica che l’uomo da solo difficilmente riuscirebbe a realizzare. Eravamo letteralmente ammirati da quella casa, e profondamente riconoscenti del pensiero e dell’azione di Alex Kerr, proprio perché in questo viaggio, più entravamo a conoscenza del vecchio Giappone, più ci rendevamo conto di cosa e quanto abbiamo perso nel corso della costruzione del nuovo Giappone: conoscenza del territorio, rapporto sostenibile con esso, con il tempo, qualità altissima della progettazione, bellezza… sotto tutto questo scorreva la vita.

L’interno di Chiiori: trionfo dello spazio vuoto Calligrafia di Kerr. Si cena intorno al fuoco. 
Il soffitto di Chiiori. Ikebana a Chiiori. Chiiori nell’ambiente circostante.
Un vero bun-jin
Dopo pochi giorni siamo andati a incontrare lo stesso Kerr che abita oggi a Kameoka, al nord di Kyoto. Il suo assistente nella mail mi aveva spiegato che Kerr abita all’interno di un tempio shintoista. Poiché non funzionava bene il navigatore dell’auto in cui viaggiavamo, abbiamo fatto un po’ fatica a trovare il tempio, ma quando siamo arrivati davanti a un ingresso molto antico, era inconfondibile. La porta aveva un piccolo tetto ricoperto di tegole tradizionali e sotto il tetto era appeso il festone sacro fatto di corde di paglia intrecciate che di solito si cinge attorno a divinità shintoiste come un albero secolare. Sembrava davvero l’ingresso di un mondo a sé. Dopo la porta, subito a sinistra, c’era una piccola casa bassa in stile giapponese tipica di qualche decennio fa che sarebbe piaciuta moltissimo al piccolo Kerr. L’interno della casa era molto curato e impreziosito con oggetti e mobili antichi e bellissimi. Alcuni, come il paravento dorato, fanno parte della sua collezione di arti antiche.
Kerr ci invita nella sua ima, soggiorno, una grande stanza di tatami ricoperti da un grande tappeto. Ci siamo seduti a un tavolo basso alla giapponese. Ci viene servita una tazza di tè verde. Un lato della stanza è una grande vetrata che si affaccia su un giardino che sembra quello di un vero tempio zen. Sulla parete a sinistra abbiamo notato una magnifica opera di calligrafia fatta in un inchiostro particolare, di color blu, dove in kanji si legge Yû-gen, uno dei concetti estetici del medioevo giapponese al quale si riferiva anche Zeami, l’inventore del Teatro Nô. Scopriamo solo più tardi che è opera di Kerr stesso. A ogni angolo oggetti, mobili, opere d’arte, fiori, tutto di una bellezza straordinaria, mai urlata. Belli ma in qualche modo discreti. C’era un’armonia che solo un vero intenditore riuscirebbe a mettere in scena. Probabilmente era un ambiente molto ricco, anche in senso economico, ma non era il lusso che contava, era la conoscenza raffinata, un vero valore culturale, una vera armonia che difficilmente troviamo nel Giappone di oggi. Siamo entrati in un altro ambiente “perduto” nel resto del Paese, diverso da quello della minka. Entrambi erano comunemente presenti nella vita fino a pochi decenni fa, ma ora non li troviamo più quasi da nessuna parte. I due ambienti, per noi, sono stati una buona “misura” per comprendere l’entità della perdita.

Il soggiorno con oggetti da collezione e la calligrafia in cui si legge “Yû-gen”
Kerr è un americano, ma è molto più giapponese di tutti noi. Ha una conoscenza vastissima della cultura giapponese antica e medievale, di arte e di letteratura. Non solo le conosce al pari degli accademici, ma si cimenta a volte in alcune arti, come l’arte della calligrafia, realizzando opere che hanno una fattura a dir poco eccellente. Meglio ancora, sa “gustare” la bellezza. Infatti non è un accademico ma un bun-jin, una figura giapponese ormai estinta che si può tradurre con “letterato”, ma con un’accezione particolare. Significa colui che non solo conosce le arti e le ama, ma che le sa “gustare”. Un vero “dilettante” nel senso nobile della parola. Per essere un vero bun-jin, le conoscenze le devi andare a cercare sempre alle radici. E le radici della cultura giapponese guardano molto lontano, alla Cina, alla Corea, ai paesi sud-asiatici, in India, e Kerr le aveva studiate. Quindi in ogni sua riflessione si sentono incrociare mille radici che hanno un’estensione pan-asiatica! Questo ha reso Kerr un amante della cultura giapponese piuttosto atipico. Ne è profondamente innamorato, ma allo stesso tempo riesce a essere anche libero di prendersi a volte una distanza dal nostro atteggiamento troppo attaccato alla perfezione delle forme finali, per quanto esse siano perfette. Del resto le forme sono solo lo strato finale della creazione. Molto più importante è conoscere la profondità che giace sotto e che motiva lo strato finale, vale a dire “le radici” in cui scorre la vita. Tuttavia, guardare verso “le radici” non sembra più addirsi al mondo contemporaneo. Lo sguardo del vero bun-jin, ecco cosa abbiamo perso completamente nella cultura giapponese. E me l’ha insegnato un americano con la sua casa, la sua gentilezza, e attraverso le sue parole. Circa trent’anni fa, il mio maestro di Kyôgen mi disse che un giorno sarebbero stati gli stranieri a insegnarci a come sederci sul tatami. Ebbene, quel “un giorno” non era poi così lontano.
Un vero ritrattista della società giapponese
Ma Kerr non è solo un bun-jin eremita che si isola dalla società di oggi, è anche uno dei ritrattisti più lucidi e attivi della società giapponese contemporanea. I suoi saggi non parlano solo, come quelli di tanti altri japanologists, di zen, templi, giardini o di cerimonia del tè, non osannano nemmeno il Giappone come nazione di forte economia super tecnologizzata (del resto non lo è più). Analizzano invece senza timore il meccanismo socio-politico dell’enorme devastazione che il Giappone ha saputo praticare su se stesso a discapito della grande bellezza dei paesaggi, delle arti e delle persone. Come abbiamo potuto combinare una simile follia?! Direte: anche da noi abbiamo distrutto molto del nostro patrimonio. Ma non c’è proprio paragone, in Italia i centri storici si è in qualche modo riusciti a salvarli. Direte: avete comunque conservato grandi arti tradizionali! Sì, certo, tutte conservate, ma come qualcosa di nicchia, senza radici, cose che non hanno più niente a che vedere con la vita odierna. Vengono lasciate come una piccola consolazione, due gocce d’acqua sulla terra desolata del Sol Levante.
Due suoi libri, Lost Japan, e Dogs and Demons, sono forse fra le opere più attente al volto del Giappone di oggi. Fra i due, Lost Japan, scritto in giapponese col titolo Utsukushiki Nihon no zanzô (“Le immagini che restano del bel Giappone”) nel 1993, è più autobiografico, più nostalgico, con numerose osservazioni, a volte ironiche a volte taglienti, raccolte nelle sue esperienze personali, su Iya, sul Kabuki, sulle arti antiche, sulla calligrafia, e su tanti altri aspetti della sua vita in Giappone, comprese le esperienze lavorative che ha avuto per una grossa società immobiliare statunitense che operava all’epoca in Giappone.
Kerr racconta che negli anni Settanta si poteva vivere ancora in un sogno, si poteva sognare ancora un vecchio Giappone. C’erano ancora le “immagini restanti del bel Giappone” che abbiamo ammirato a Chiiori e a casa sua. E Kerr è stato un testimone preziosissimo, ha assistito all’enorme cambiamento storico che il mio paese stava vivendo in quegli anni. Intorno alla casa nel tempio c’erano ancora tanti campi coltivati, case antiche che formavano i vecchi quartieri di una volta. Tutto questo oggi non c’è più. Sembra che solo all’interno di quel tempio il tempo si sia fermato da quarant’anni.
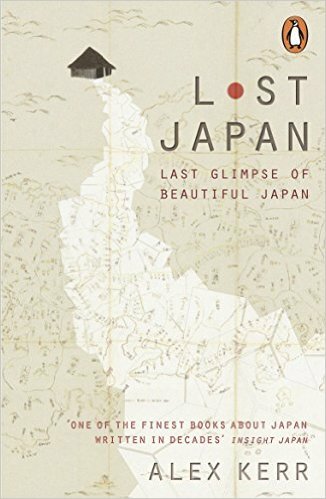
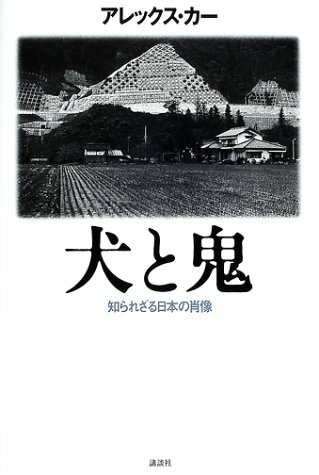 Copertina Lost Japan Copertina di Dogs and Demons, edizione giapponese.
Copertina Lost Japan Copertina di Dogs and Demons, edizione giapponese.
Nel suo secondo libro Dogs and Demons: the fall of modern Japan (il titolo giapponese è Inu to Oni: il ritratto del Giappone sconosciuto) del 2002, Kerr illustra invece in modo più scientifico, munito di numerosi dati statistici, il meccanismo politico-sociale che ha portato a realizzare una vera trasformazione del territorio e della cultura del vecchio Giappone. Il titolo Dogs and Demons viene da un’antica leggenda cinese. Un imperatore chiese al pittore di corte quale fosse il soggetto più facile e quale più difficile da dipingere. Il pittore rispose che il soggetto più difficile era il cane e quello più facile era il demone. La morale è che ciò che è più vicino a noi, qualcosa di apparentemente ordinario, meno appariscente è in realtà molto difficile da rappresentare bene, mentre chiunque riuscirebbe a dipingere un soggetto di finzione straordinaria. Anche nella società moderna è più difficile risolvere i problemi quotidiani, quindi nessuno vi si vuole cimentare, o non vi riesce bene, mentre tutti vogliono spendere tanti soldi per costruire monumenti straordinari. Qui Kerr sceglie di essere un vero pittore che cerca di rappresentare il soggetto più difficile che nessuno ha mai voluto dipingere: i veri fattori che hanno portato a realizzare un’enorme distruzione del territorio (natura) e della tradizione (cultura), insomma, le nostre radici.
Una nazione drogata di edilizia
Quando si parla del Giappone odierno, si parla sempre della tecnologia, pensando che l’economia giapponese si appoggi totalmente su quel settore. Invece il settore su cui lo Stato ha investito maggiormente nel dopoguerra è stato quello dell’edilizia, vale a dire i lavori pubblici e la costruzione delle abitazioni residenziali. Il settore dell’edilizia in Giappone si è sviluppato grazie a intensi appoggi di politici e di tecnocrati dei ministeri, spesso spudoratamente corrotti, e in Dogs and Demons, Kerr elenca dei dati statistici incredibili.
Nel 1998, i lavoratori del settore rappresentavano il 10.1 % di tutti i lavoratori giapponesi, il doppio rispetto all’UE. I soldi spesi per l’edilizia in Giappone superano di gran lunga quelli spesi negli USA per gli armamenti. Nel 2001 l’edilizia rappresentava il 13% del PIL giapponese, mentre nello stesso periodo in America lo stesso settore registrava solo il 5% del PIL. Il Giappone ha speso per i lavori pubblici realizzati nei 13 anni tra il 1995 e il 2007 circa 650mila miliardi di yen, quasi 4 volte più di quanto spendeva l’America nello stesso periodo, nonostante il Giappone abbia una superficie (di cui tra l’altro il 70% è zona montana, quindi non idonea all’edificazione) pari a un venticinquesimo del suolo americano. Kerr continua a snocciolare dati. Abbiamo 2800 dighe sul nostro territorio (che è poco più grande di quello italiano) e in programma (nel momento della pubblicazione del libro) altre 500 da costruire (!!!). Tutte queste cifre sull’edilizia sono impressionanti e i promotori principali sono i due ministeri, il Ministero del Territorio e dei Trasporti e il Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca.

Tipica “protesi” applicata al versante di una montagna. Le rive cementificate di un fiume .
Qui bisogna leggere bene il significato di queste cifre. Purtroppo la maggior parte di questi lavori sono stati inventati per spendere soldi, non perché fossero davvero necessari. E come una macchina infernale, una volta avviati non c’è modo di fermare questi progetti, molto spesso devastanti per l’ambiente. Solo che in Giappone il Ministero dell’Ambiente esiste solo per dare consensi formali e non ha alcuna normativa efficace né alcun effettivo potere per esaminare questi progetti edilizi inutili e dannosi e fermarli. Tutto questo perché nel dopoguerra lo Stato ha deciso di privilegiare l’economia a discapito di tutto il resto.

In Giappone moltissime coste sono ricoperte da tonnellate di tetrapot per essere “protette” dalle onde.
In questo modo, lo Stato ha cementificato senza particolari necessità moltissime coste, fiumi e versanti di montagna, quasi sempre con vaghe motivazioni spesso ingiustificate, tipo “sicurezza” o “allargamento dei terreni agricoli” che spesso si rivelano false. Inoltre ha iniziato a piantare, subito dopo la guerra, nel 1947, boschi artificiali a monocoltura di alberi di sugi (si legge “sughi”, una specie di cipresso) che sono arrivati a coprire il 45% della totalità delle foreste giapponesi, con l’intento dichiarato di utilizzare il legname per l’edilizia. Peccato che subito dopo si sono accorti che i legnami importati dall’estero costavano molto meno, e i boschi di sugi sono stati abbandonati provocando il soffocamento del territorio, l’abbassamento della capacità di contenimento dell’acqua nel suolo e l’impoverimento della biodiversità, oltre a far scoppiare negli ultimi trent’anni una diffusissima allergia di pollini di sugi che prima non esisteva. Oggi tantissimi giapponesi non possono separarsi dalla mascherina nel periodo tra febbraio e aprile, non perché siano raffreddati, né perché l’aria è inquinata come a Pechino, ma per proteggersi dai temutissimi pollini di sugi. Hanno cercato di industrializzare i boschi (tra l’altro un progetto totalmente fallito, visto che è stato abbandonato) senza mai avere una minima visione ambientale.
È un territorio, quello giapponese, che assomiglia sempre di più a un robot se non a un cadavere stretto nella sua protesi di cemento, piuttosto che un ambiente naturale della vita. E nonostante questi scempi, diretti dallo Stato, che durano ormai da decenni, Kerr sostiene che la situazione non accenna a cambiare.

Bosco di monocoltura di sugi. Allergici ai pollini di sugi.
Addestramento dei cittadini per agevolare il flusso del sistema
Cosa dicono i locali e gli ambientalisti di fronte a queste situazioni? Ci sono stati casi di inquinamento ambientale molto gravi come quello di Minamata, reso famoso in Occidente grazie alle fotografie di Eugene Smith. Ma al di là dei casi più gravi, non sembra che gli abitanti protestino più di tanto. Perché? Perché gli stessi locali sono sempre stati comprati per accettare i grandi lavori pubblici. È una pratica molto diffusa. Anche le centrali nucleari sono state costruite in tutto il territorio nazionale con lo stesso metodo. Un’intera zona, abitanti compresi, viene “comprata” e diventa completamente asservita a queste grandi opere pubbliche. I contadini sono costretti ad abbandonare i loro campi per andare a lavorare come operai nei cantieri. La distruzione dell’ambiente è connessa alla distruzione della categoria professionale fondamentale.
Inoltre i cittadini non vengono informati correttamente. La propaganda è molto forte e molto sottile nel mio paese. Le pubblicità delle grandi agenzie di viaggio e le guide ci illustrano sempre paesaggi naturali meravigliosi (che esistono ancora da qualche parte) per creare il mito della nazione e del popolo che ama le bellezze della natura. Ma prima ancora dell’informazione, la colpa è della formazione. Il sistema educativo giapponese non forma il senso critico, la capacità di pensare, ma ti addestra come un bravo soldato ubbidiente e resistente, un modello di lavoratore perfettamente adatto alle esigenze del capitalismo. La “trasformazione” non riguardava solo il territorio, ma anche l’uomo e le sue azioni.
Ogni volta che rientro in Giappone, non posso non notare un’altissima efficienza in ogni aspetto della società. Come già raccontato in un altro articolo, il Giappone è il paese che ha praticamente eliminato l’attesa, almeno in città. L’atto di far aspettare qualcuno viene considerato quasi come un’onta, un disonore, soprattutto in ambito professionale. In nome dell’efficienza, si fa di tutto per non far aspettare clienti, utenti, passeggeri, chiunque.
Poter contare sui mezzi che arrivano sempre puntuali o uscire fuori dall’ufficio comunale in pochi minuti con il documento desiderato in tasca sono cose meravigliose (perché qui sarebbero fantascienza), ma nel “Sistema Giappone” questo aspetto dell’efficienza sembra presagire qualcosa di molto inquietante.
Prima di tutto, quando ci si trova dalla parte del cliente/utente/passeggero quest’efficienza è fantastica e molto gradita, ma nei panni dei lavoratori che sostengono quest’efficienza, essa significa una pressione sociale enorme e ore infinite di lavoro. Ma non solo. In Giappone l’eliminazione dell’attesa non dà un vero sollievo alle persone, non le libera veramente ma le imprigiona ulteriormente nel sistema, in un flusso continuo e ininterrotto molto veloce da cui non si esce più. Persino chi gode dell’efficienza del sistema, infatti, per starci dentro deve a sua volta correre, correre, correre, nessuno escluso, dai bambini ai vecchi. Nonostante l’eliminazione dell’attesa, nessuno ha più tempo per sé. Altro che andare a guardare le proprie radici! Non ne abbiamo più il tempo. Un sistema molto spietato e logorante nel quale non tutti riescono a sopravvivere bene. Qualcuno tenta una fuga da questo sistema ben chiuso, a volte con conseguenze tragiche, ma anche di questo parleremo in un’altra puntata.
Per stare dentro questo sistema c’è bisogno di un notevole “addestramento” sin dalla più tenera età. Cosa a cui fortunatamente voi non siete chiamati. I giapponesi, soprattutto nelle zone urbane, sono altamente “addestrati” in questo senso. Della “disciplina” come fattore fondamentale della “biopolitica” del mondo moderno, di cui parla Michel Foucault, potete osservare un’applicazione quasi perfetta in Giappone. Là si ha l’impressione che la “disciplina” sia penetrata molto più profondamente sotto la pelle dei singoli cittadini. Le loro azioni vengono gestite non sempre dalla loro libera volontà, ma dalla disciplina e dal protocollo che sono stati inculcati loro sotto la pelle. Potrebbe sembrarvi di parlare di un film sul futuro prossimo, ma è già una realtà.
In diverse circostanze molto quotidiane possiamo notare come si distinguono i “non addestrati” dagli “addestrati”. Avendo viaggiato questa volta con un paio di persone italiane, ho avuto modo di osservare le clamorose differenze. Facciamo un esempio molto semplice. In Giappone, quando si prende il treno o il metrò bisogna conservare il biglietto fino alla fine del viaggio perché all’uscita bisogna riconsegnare il biglietto, un tempo al personale, oggi nella buca di un apparecchio che c’è all’uscita, e se il biglietto non è valido non si esce. Inoltre, la maggior parte dei giapponesi ormai non compra più il biglietto ma usa una tessera prepagata ricaricabile che si chiama “PASMO” che ha reso molto più veloce il passaggio. Non c’è più bisogno di comprare i biglietti ogni volta che si prende il treno (già un notevole risparmio di tempo), basta passare la PASMO sopra l’apparecchio sia all’ingresso che all’uscita. Funziona anche con la tessera tenuta dentro la borsa. Lo scopo ultimo della PASMO è di mantenere un rapido flusso della folla all’interno delle stazioni. E quei pochi che invece hanno comprato il biglietto, molto prima di arrivare all’uscita ce l’hanno già pronto in mano, in modo da evitare di mettersi a cercarlo proprio davanti al tornello. Ma i miei accompagnatori italiani non avevano mai quest’accortezza (confesso, ormai nemmeno io) e ogni volta che scendevamo a una stazione, proprio arrivati all’uscita, ci mettevamo a cercare il biglietto in tutte le tasche creando una “vergognosa” congestione dietro di noi. Agli occhi di tutti, risultavamo chiaramente elementi difettosi della società.
 Il flusso continuo di una grande quantità di passeggeri.
Il flusso continuo di una grande quantità di passeggeri.
Non crediate che i giapponesi siano chiamati a fare un addestramento specifico per passare velocemente l’ingresso della stazione (anche se ne sarebbero capaci), è l’intera educazione scolastica che mira a impartirci questo senso di disciplina e prontezza. Sembrano piccoli dettagli, ma quando tutta la popolazione delle zone urbane si comporta in un dato modo e ripete diligentemente gli stessi gesti, fa un certo effetto. Voi direte che è un segno di civiltà. In parte è vero, ma bisogna leggere lo scopo finale di tutto questo.
Tanto per cominciare, sono “addestrati” per che cosa? Lo scopo dell’addestramento sembra, a prima vista, quello di ottenere la comodità delle persone, per stressarci di meno, per farci star bene, almeno così t’insegnano a scuola, e ne siamo convinti, e in parte è vero. In Giappone si ha sempre questa sensazione. Sono tutti cortesi, ordinati, e quindi anche più veloci. È vero che non dover aspettare dà sempre un vantaggio. Essere diligentemente serviti, oltre che facilitare la tua vita, ti dà una sensazione piacevole, ma qui arriva il punto. Dov’è lo scopo finale di tutto questo? Chi è il vero beneficiario? Durante questo viaggio, finalmente, sono arrivato a una conclusione: lo scopo finale non è il bene delle persone (che invece si troverebbe in quelle immagini restanti del bel Giappone), quanto piuttosto il bene del sistema. L’obiettivo è eliminare qualsiasi cosa possa ostacolare il suddetto flusso del sistema. La nostra “comodità” non è altro che un sottoprodotto ingannevole. Quel che conta davvero è il mantenimento della velocità continua del flusso, che è il sogno del capitalismo. All’interno di questo sistema, però, non c’è più spazio per l’armonia raffinata che abbiamo conosciuto da Alex Kerr. Il flusso è troppo veloce per poter fissare bene “le immagini restanti del bel Giappone”. Questo sistema “efficace” non prevede gli elementi di diversità che compongono la vitalità e organicità “selvaggia” di qualsiasi cultura vera. È talmente chiaro che qui l’uomo non è più il soggetto che conta, non è più al centro. Il rapporto è ormai capovolto. Heidegger ci ammoniva già tanti anni fa, eppure siamo noi a non capire ancora la situazione. Quando si ha l’impressione che la tua vita sia diventata molto comoda, veloce, tecnologizzata, in realtà il sistema ti ha reso dipendente, riducendoti semplicemente a uno dei suoi innumerevoli “terminali” perennemente connessi al sistema stesso. E purtroppo “i terminali” non saranno più capaci di inventare di nuovo una cultura così ricca e bella come quella che avevamo.

