«Mario è morto il 29 novembre del 2010, buttandosi dal quinto piano di un ospedale romano. Si è “schiantato”, come direbbe lui. Gli piaceva la parola “schiantarsi”. […] “schiantarsi” e/o “ingoiare una polpetta avvelenata” al momento giusto, quando cioè uno è sazio dei giorni, era una teoria ampiamente condivisa in tutta la famiglia Monicelli».
Così ricorda Chiara Rapaccini, scrittrice, illustratrice, autrice di libri per l’infanzia (e non solo: Amori sfigati, Rossa), per oltre trent’anni compagna di Mario Monicelli, sul numero 596 di “Bianco e Nero”. Interamente dedicato al regista, di cui proprio oggi ricorrono i dieci anni dal suicidio, le quasi duecento pagine della rivista ospitano contributi firmati da storici (Cardini, De Luna, Mondini), studiosi e critici cinematografici (Anile, Brunetta, Crespi, Gili), giornalisti e scrittori (Deaglio, De Cataldo, Di Paolo), oltre ai ricordi e le testimonianze in prima persona di collaboratori, interpreti, amici. Fra questi, appunto, c’è quello di Rapaccini, che traccia con straordinaria leggerezza e un pizzico d’irriverenza (a cominciare dal titolo, Muoiono solo gli stronzi, tratto da un suo celebre auto-epitaffio) il profilo di un Monicelli visto da vicino.
E non solo: Rapaccini racconta che il giorno successivo alla morte del regista aveva telefonato a Furio, il fratello minore. Classe 1924 (sarebbe morto un anno più tardi), raffinato scrittore (Il gesuita perfetto, L’amore guasta il mondo), ormai quasi cieco, Furio le aveva risposto così: «“Non capisco perché mio fratello faccia sempre tutto di testa sua […]. Avevamo deciso che se un giorno ci fosse venuto in mente di andarcene, si sarebbe fatto insieme. C’è un’organizzazione fantastica in Olanda, mi pare ad Amsterdam. Ti vengono a prendere con una bella macchina moderna e poi fanno tutto loro…”. Lo disse con lo stesso tono con cui avremmo potuto dire “Avevamo deciso Mario e io di andare al cinema, e invece lui testardo è andato a mangiarsi una pizza…”».
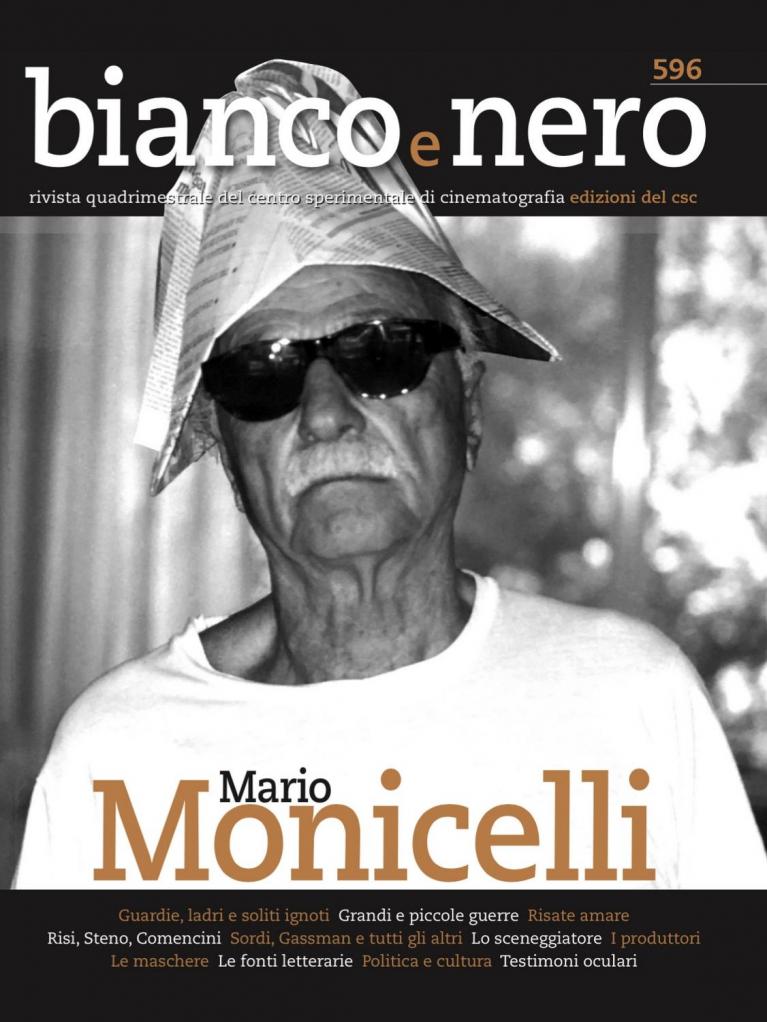
Anche il padre di Mario e Furio, il giornalista e drammaturgo Tomaso Monicelli, aveva deciso di “fare di testa sua”, ingoiando la “polpetta avvelenata” a soli 63 anni. Socialista che aveva malauguratamente tralignato verso il nazionalismo interventista ai tempi della guerra italo-turca, oppositore del fascismo finito ai margini dopo la Liberazione, Monicelli senior si tolse la vita nel 1946. Una sessantina d’anni più tardi, in un’intervista, il figlio ricorderà: «Il cadavere di mio padre l’ho trovato io. Verso le sei del mattino ho sentito un colpo di rivoltella, mi sono alzato e ho forzato la porta del bagno. Tra l’altro un bagno molto modesto».
Mario Monicelli è tutto lì, in quel dettaglio (“un bagno molto modesto”) rifilato in chiusura, quasi en passant. Con infallibile senso del racconto, verrebbe da dire. Scabro, con punte di durezza, commosso ma a ciglio asciutto (guai al ricatto del sentimento!), Monicelli ha sempre prediletto le scene “figlie”, in antitesi alle “scene madri” del melodramma, e i «finali netti, il più possibile rapidi e privi di equivoci».
Nel libro-conversazione La commedia umana, uscito in occasione del novantesimo compleanno del regista, Sebastiano Mondadori l’aveva definito “il maestro dei funerali”. A ripercorrerli mentalmente uno per uno ne viene fuori un elenco impressionante. Difficile ricordarli tutti: quello “a piedi” di Totò e i re di Roma; quello di Cosimo/Memmo Carotenuto finito sotto un tram in I soliti ignoti (Tiberio Murgia: «Sono sempre i più meglio che se ne vanno»; e Totò: «Oggi a lui, domani a te»); quello di Romanzo popolare («uno dei più belli della mia carriera»), con le bare che sbucano dai vicoli per incolonnarsi in fila indiana; quello di Perozzi/Philippe Noiret in Amici miei, con i quattro sodali superstiti che ne approfittano per prolungare una volta di più lo scherzo; quello clairiano, a passo di corsa, di Panni sporchi. E poi la lunga teoria di esequie fasciste, tanto pompose quanto dementi, che costellano come siparietti il fantapolitico (ma neanche troppo) Vogliamo i colonnelli!; il deposito di bare di Un borghese piccolo piccolo, vero e proprio inferno in terra; la preparazione della salma in Viaggio con Anita, con la chiosa a freddo di Renzo Montagnani che avverte i congiunti di tappare i buchi del padre appena deceduto, «sennò cola giù tutto»: «Una scena di estrema durezza», ricordava Monicelli, «non c’è più un essere, ma un pezzo di carne morta. Non c’è spirito, non c’è più niente». Nell’ultimo Le rose del deserto si arriva persino all’ibridazione fra cerimonia nuziale e cerimonia funebre, con i commilitoni del soldato Sanna che, complice il padre domenicano Simeone (Michele Placido), celebrano il matrimonio per procura che il morto attendeva da mesi. «Di matrimoni ne ho girati pochi, anche perché mi vengono male», precisava il regista. «Dev’essere un disagio istintivo. René Clair era uno che li sapeva girare benissimo, capace di irridere con finezza… Io invece sono brutale».
A questo proposito, in un suo saggio Gianni Canova evocava addirittura Sartre: essere morto, nel cinema di Monicelli, è essere preda dei vivi. «I funerali monicelliani – così gretti e così distratti, così di corsa e così impacciati», scrive Canova, rivelano la sostanziale asocialità della società italiana (dell’umanità tutta?), tanto da far risaltare, per contrasto, le rare eccezioni: la fucilazione nel prefinale de La Grande guerra, la veglia funebre dell’operaio Pautasso (Folco Lulli) in I compagni, l’epicedio di Brancaleone (Vittorio Gassman) al moribondo Abacuc (Carlo Pisacane) in L’Armata Brancaleone: «Abacucco, e se anco fosse? Io credo che anderai a star bene… Sarà sempre melio di questa vita che ci toccò in sorte».
Ed è ancora su questa falsariga, a metà tra omaggio e scaramanzia, che si erano mossi nel 2006 Daniele Ciprì e Franco Maresco in una bellissima puntata del programma I migliori nani della nostra vita. In procinto di partire per le riprese in Tunisia de Le rose del deserto, spalleggiato di volta in volta da Tatti Sanguineti e dal critico Gregorio Napoli, Monicelli si muove sapido fra teschi e tombe, scherza sull’altro vegliardo Manoel De Oliveira, idolo indiscusso della cinefilia mondiale («Io non vedo l’ora che muoia, sennò rimango sempre in second’ordine»: ma il portoghese riuscirà a batterlo almeno all’anagrafe, morendo nel 2015 a 106 anni suonati), soprattutto, memore del fasto funebre riservato a Fellini e a Sordi, si preoccupa di come la sua morte «verrà festeggiata [sic!] dal comune di Roma», all’epoca guidato da Walter Veltroni. «Meglio sotto una duna del deserto…», incalza l’inconfondibile voice over di Maresco. «…Che sotto una lastra al Campidoglio», conclude Monicelli, con un mezzo sorriso.
Passeggiando fra le tombe del camposanto di Bagheria in compagnia di Napoli, Monicelli snocciola i suoi celebri epitaffi, a cominciare dal già ricordato “Muoiono solo gli stronzi”, variante carnascialesca e volutamente sboccata del duchampiano “D’ailleurs, c’est toujours les autres qui meurent”, d’altronde sono sempre gli altri che muoiono. Nella sua testimonianza su “Bianco e Nero” Rapaccini ne ricorda altri due, meno noti ma altrettanto penetranti. Il primo è “La vita è un dépliant” o “un’affacciata alla finestra”, vale a dire uno sguardo veloce su un’eternità apparentemente carica di promesse; il secondo è l’ancor più perentorio “Di esser stato vivo non gli importa”, che pare quasi un esercizio (stoico? Leopardiano?) di disaffezione alla vita.
Mi perdoneranno i lettori se la faccio tanto lunga con questa faccenda della morte. Ad alcuni di loro, forse, suonerà persino di cattivo gusto. Tuttavia, mi pare una delle poche cose indiscutibili quando si parla di Monicelli. Di questo toscano per finta (era nato a Roma, non a Viareggio come diceva in giro), di famiglia ostigliese, formatosi a Milano e vissuto soprattutto a Roma, si è detto tutto e il suo contrario. Inevitabile, credo, per un individuo venuto alla luce insieme al “secolo breve”, pochi giorni prima che l’Italia entrasse nella Prima guerra mondiale, e che ha mancato di poco i cento anni, settanta dei quali passati a realizzare film (il primo lungometraggio, I ragazzi di via Pál, girato con Cesare Civita e Alberto Mondadori, è del 1935, l’ultimo, Le rose del deserto, del 2006). Una carriera che, anche solo per la sua estensione, non facilita il compito allo storico, né consente periodizzazioni o etichette di comodo.
Chi è veramente Mario Monicelli? «Un mistero», risponde Paolo Virzì in una delle interviste di “Bianco e Nero”. E prosegue: «Quello degli ultimi anni, con una forte passione militante? O quello che – sempre negli ultimi anni – faceva incazzare Scola e Scarpelli perché giocava a fare il qualunquista, e prendeva in giro tutti coloro che avevano un’identità politica sicura e assertiva? O quello che, molti anni prima, aveva girato I compagni, uno dei pochi grandi film italiani sulla classe operaia? Di nuovo: era quello che a cena diceva a Laura Morante e a Giuliana De Sio che la piantassero con certi discorsi, perché le donne non hanno l’anima? O quello che in Romanzo popolare o in Speriamo che sia femmina ha tratteggiato dei ritratti femminili così forti? O ancora quello di Amici miei, vero e proprio manifesto del maschilismo? O, pirandellianamente, tutti costoro assieme? Io credo che Mario Monicelli abbia interpretato un personaggio, secondo la vecchia regola letteraria per cui in un romanzo, per prima cosa, devi inventare il narratore. Mario Monicelli è stata una creazione di Mario Monicelli».

Al di là delle ragioni anagrafiche e delle tentazioni letterarie, parlare di Monicelli è difficile perché è sempre stato difficile affrontare il (macro)genere con cui si identifica la stagione più matura e fertile della sua carriera, passato alla storia come “commedia all’italiana”. Qui le ambivalenze si moltiplicano. Italo Calvino, per esempio, se da un lato dichiarava apertamente di trovarla «detestabile», poiché «quanto più la caricatura dei nostri difetti vorrebbe essere spietata, tanto più si rivela compiaciuta e indulgente», dall’altro rimane, col suo racconto Furto in una pasticceria, l’ispiratore del capostipite del genere, I soliti ignoti, diretto appunto da Monicelli nel 1958. In modo non dissimile, Lino Micciché, dopo aver censurato la commedia all’italiana come frutto di un’ideologia «monoliticamente e trionfalmente piccolo-borghese», finirà molti anni dopo per dedicare a Monicelli un evento speciale del Festival Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.
Alle riserve, per così dire, “di contenuto”, si affiancano poi quelle “formali”: la commedia all’italiana e i film di Monicelli non hanno mai goduto del plauso incondizionato dei cinefili – sia pure con eccezioni importanti, come quelle di Tatti Sanguineti o di Steve Della Casa, che al regista aveva già dedicato nel lontano 1986 un pionieristico “Castoro”. Secondo Alberto Pezzotta, quello del disinteresse di Monicelli (e di Comencini, di Risi, di Scola, e di tanti altri) nei confronti del “linguaggio”, del “cinema-cinema”, è un luogo comune da sfatare; per quanto, nel caso di Monicelli, avallato se non incoraggiato dal regista stesso, che detestava i cinefili («sono la rovina del cinema») e insisteva ad autodefinirsi non autore, bensì artigiano.
Da spettatore, aveva conosciuto il cinema muto; e negli ultimi anni, quasi rammaricandosi di aver ceduto troppe volte al dialogo nel corso della carriera, aveva sostenuto a più riprese, con una veemenza degna d’un jeune-turc, che il vero cinema era quello: La folla di Vidor, la Giovanna d’Arco di Dreyer, i melodrammi sadomasochistici di von Stroheim, le comiche di Chaplin e Keaton. Ma non si batteva certo il petto per il cinema consumato in sala: «Non c’è più l’esercizio? Tanto meglio, chi se ne frega!», sbottava in un’intervista con Goffredo Fofi, due anni prima di morire. «E insisto anche nel confutare chi dice “Se non c’è lo schermo grande, se non c’è il buio…”. Ma che vuol dire? Non è la grandezza dello schermo che conta. Se tu capisci l’arte, che lo schermo sia grande o piccolo che importanza ha?».
Come per molti di quella generazione, la sua vocazione – chiamiamola così – era sbocciata grazie al cinema francese. In particolare, grazie a un film con Jean Gabin protagonista, La bandera, scritto (con Charles Spaak) e diretto da Julien Duvivier nel 1935. «Un film che mi ha spinto a dire “ecco cosa vorrei fare io”», ricordava Monicelli. «C’è un momento in cui i due protagonisti, il legionario Gabin e un suo compagno [Robert Le Vigan] … e allora uno dei due, che per tutto il film aveva detto che ognuno di loro era andato lì per ragioni che nessuno voleva dire, innominabili, d’improvviso e senza motivo apparente, durante questa pausa in una marcia, mentre sta lì seduto col compagno evoca la ragione per cui si trova lì… ma appena lui comincia a raccontare, l’altro si alza in piedi e va a pisciare. Fine della scena».
Al di là dell’auto-mito-biografia, per dire la consapevolezza – anche – stilistica del Monicelli regista, basterebbero le sciabolate espressioniste di film come Guardie e ladri (diretto in coppia con un altro straordinario e meticoloso artigiano come Steno) e I soliti ignoti, che fotografano una Roma in bianco e nero, gelida e invernale, inedita nella commedia di allora – e non solo; o l’uso della profondità di campo e i movimenti di macchina, complessi ma sempre “invisibili”, di film come La Grande guerra e I compagni, accuratissimi anche sotto il profilo della ricostruzione storica; o ancora, la sbrigliata fantasia coloristica e linguistica dei due Brancaleone, incursioni in un Medioevo del tutto inventato e, proprio per questo, più vero del vero; o infine, per contrasto, le luci “rubate” e le atmosfere plumbee delle opere degli anni Settanta, come Romanzo popolare, Amici miei e Un borghese piccolo piccolo. Qualcuno l’ha definito un eclettico. Lui scrollava le spalle e diceva che un regista fa sempre lo stesso film: il suo era quello di un gruppetto di disperati che si imbarca in un’impresa smisurata e fallisce miseramente.
Si sente ripetere spesso che la generazione dei Monicelli e dei Risi non ha avuto padri e non ha lasciato figli – artisticamente parlando. «Quando penso alla carne della mia carne, chissà perché, divento subito vegetariano», commenta sarcastico il Perozzi in una delle prime scene di Amici miei; e in Temporale Rosy, uno dei film monicelliani più personali e sfortunati, un allenatore incita così il pugile sul ring: «Ricordati che l’avversario potrebbe essere tuo figlio: perciò picchia, picchia senza pietà!».
Questo rapporto di mutua insofferenza (per non dire di vera e propria ostilità) aveva poi trovato la propria consacrazione nella storica puntata di Match del 1977, in cui Alberto Arbasino metteva sadicamente a confronto Monicelli con un allora giovane Nanni Moretti: il primo nei panni dell’anziano campione di un cinema ormai stracco e sostanzialmente conservatore, il secondo in quelli del debuttante pronto a far piazza pulita. Col senno di poi, i limiti di questo schema “generazionale” appaiono più evidenti che mai; e si potrebbe perfino osservare, con una punta di malignità, che mentre l’allora sessantaduenne Monicelli faceva a pezzi un certo familismo italiano con il sulfureo Un borghese piccolo piccolo, quarant’anni dopo il sessantaduenne Moretti non trovava di meglio che ripiegare sul nucleo famigliare con l’assai modesto Mia madre.
Per quanto debole, il paradigma arbasiniano ha continuato a godere di una certa credibilità. Può capitare dunque che persino Vincenzo Buccheri, critico di straordinario acume e studioso fra i migliori della sua generazione, finisca per adagiarvisi senza troppa originalità. Buccheri descrive (siamo nel 2005) un Monicelli ormai «superato dai tempi e smentito dai suoi stessi film», ostinatamente impegnato in una difesa a oltranza della commedia «contro chi, specie fra i giovani, ne addita gli aspetti negativi, di consolazione e conservazione», ma soprattutto ben deciso a regolare i conti (!) con quel che resta del “giovane cinema”, arrivando a negare, in veste di presidente della Giuria, il Leone d’Oro del 2003 a Buongiorno, notte di Marco Bellocchio.
Di tutt’altro tenore il parere di Wu Ming 1, coetaneo di Buccheri che nel 2010 ha provocatoriamente messo a confronto Amici miei e il pasoliniano Salò, individuandone le segrete affinità: ed ecco che Monicelli diventa una sorta di maestro “eretico” e “scandaloso”, sulla falsariga del poeta-corsaro di Casarsa. Del resto, pochi mesi prima di morire, durante la trasmissione-evento Raiperunanotte aveva dichiarato senza mezzi termini che «la speranza è una trappola inventata dai padroni… una cosa infame inventata da chi comanda», incitando i giovani e i precari a dare semmai «una bella botta, una bella rivoluzione, che non c’è mai stata in Italia», attirandosi gli strali dei benpensanti.
Monicelli “cattivo maestro”, dunque? Oppure “maestro di libertà”? Forse sarebbe ora di ricomporre quel mosaico pirandelliano di cui parla Virzì. In questi dieci anni si è andata formando una nuova leva di spettatori, poi divenuti studiosi a loro volta: una generazione che ha relegato in soffitta le contrapposizioni del passato e che nella propria videoteca tiene i DVD di Monicelli a fianco di quelli di Moretti; che aveva vent’anni (o poco più, o poco meno) in quell’autunno del 2010 in cui Monicelli aveva deciso di “schiantarsi” giù dalla finestra; e che vedeva in quel vecchio socialista un po’ burbero non tanto la testimonianza vivente di un cinema che avevamo sfiorato a malapena, ma un compagno di strada, un po’ più anziano e un po’ più colto forse, pronto muoversi al nostro fianco con un atteggiamento misto di perplessità e curiosità, come testimoniano alcuni fra gli ultimi contributi monicelliani, come Un altro mondo è possibile (sul G8 di Genova, dove sfuggì per un soffio a una carica della polizia) e Lettere dalla Palestina. Non a caso, nei giorni successivi alla sua morte, durante le manifestazioni studentesche contro la riforma Gelmini era apparso uno striscione: “Ciao Mario, la faremo ’sta rivoluzione”. Uno sguardo nuovo sulla sua opera potrebbe essere un buon modo per incominciare.

