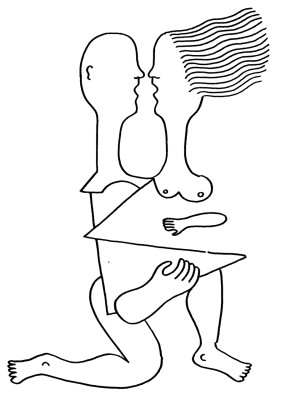Il pubblico dei media si sta rapidamente formando una cultura sul tema, fino a qualche tempo fa familiare a pochi, dello scontro tra sunniti e sciiti. è la conseguenza degli eventi, per esempio della tensione altissima tra Arabia Saudita e Iran dopo le quarantasette esecuzioni in un giorno in cui i sauditi hanno decapitato, tra gli altri, il leader (sciita) della protesta contro il regime. Ma anche di certe tendenze ben radicate nella visione occidentalocentrica dei problemi del mondo. Da un lato, abbiamo provato a districarci nelle faide politico-religiose del Medio Oriente per capire “chi sta con noi” e “chi sta con loro”, e ci è stato spiegato che i sunniti sarebbero quelli che stanno con noi. Dall’altro, questa cosa dei sunniti contro gli sciiti, con quel suo tratto da derby (Juve-Toro, Milan-Inter, Coppi-Bartali), si presta bene alle semplificazioni, prima fra tutte quella che drammaticamente ci tocca da un paio di decenni: lo scontro di civiltà, quell’idea del mondo e della politica mutuata dalle fiabe in cui c’è sempre uno buono per natura contro uno cattivo per natura. E ovviamente siamo noi a decidere chi è l’uno e chi è l’altro.
Il problema, però, è che sunniti e sciiti si combattono e si ammazzano da secoli. Da prima ancora che si inventassero per loro quei due nomi. Lo fanno, a dir poco, dal 661 d.C., da quando cioè Alì, genero di Maometto, quarto califfo dopo il Profeta, fu ucciso con un colpo di spada avvelenata mentre entrava nella moschea di Kufa per guidare la preghiera. A quel punto Alì (onorato come capostipite dello sciismo) aveva già combattuto almeno una grande battaglia contro Mu’hawiya, governatore della Siria, l’uomo che gli contendeva il comando dell’islam e che sarebbe diventato il successivo califfo, e per così dire il capostipite del sunnismo.
Storia vecchia, dunque, difficile considerarla un fatto nuovo. Infatti quel che il Medio Oriente ci grida in faccia è ben altro: e cioè, che cade a pezzi non questo o quello Stato, non il tal regime, non un certo schieramento, ma un’impalcatura narrativa neocolonialista che ha retto per circa un secolo e che ora proprio non ce la fa più.
Era giusto il 1915 quando Mark Sykes propose al collega François Georges-Picot di spartire tra Regno Unito e Francia i territori del barcollante impero ottomano tirando “una riga diritta dalla seconda K di Akko (San Giovanni d’Acri, oggi Israele, ndr) e la seconda K di Kirkuk (oggi Iraq)”. Il Trattato venne poi firmato solo nel 1916 ma in quella frase c’era già tutto il secolo a venire, cioè il lungo tratto in cui, dopo averlo inventato, abbiamo sottoposto il Medio Oriente a un continuo a crudele esperimento politico e sociologico.
Consideriamo le parole di Sykes. Dal punto di vista culturale, esprimevano il più totale disprezzo per le realtà locali. Tirare quella famosa “riga diritta” voleva dire non tenere alcun conto di ciò che la storia e la geografia avevano sin lì prodotto, sul terreno, per popoli, tribù, civiltà, economie, attitudini politiche. E significava, anche, avviare quel processo di divisione e frammentazione che è proseguito senza soste fino a oggi. L’impero ottomano, grande entità multiculturale, multietnica e multireligiosa, fu prima spaccato in due, poi in quattro, in sei, all’infinito. La Francia prese a sostenere la lotta degli ebrei di Palestina contro gli inglesi, e gli inglesi ad appoggiare le rivolte arabe in Siria. E via via, di intervento in intervento, fino a ciò che vediamo ogni sera nei tg: l’Iraq è ormai diviso in quattro (Kurdistan, governo centrale sciita, area sunnita e califfato dell’Isis), la Siria è sull’orlo della grande spartizione (Israele vuole l’annessione ufficiale del Golan, la Turchia un pezzo dell’area curda a Nord, la Giordania una fascia di sicurezza a Sud, l’Arabia Saudita sogna la creazione di un’enclave sunnita, la Russia combatte per garantire uno Stato agli eredi di Assad…), la Libia è esplosa in cento frammenti, lo Yemen tagliato in due dalla guerra civile.
Aperto il vaso di Pandora della frammentazione, abbiamo poi incentivato la naturale tendenza dei conflitti ad assestarsi secondo quelle stesse linee di demarcazione etnica, politica, religiosa, persino tribale che avevamo pensato di ignorare ma che nel frattempo erano diventate oggetto di rivendicazione, bandiera, sogno, persino vendetta. è solo un caso che due dei primi Stati indipendenti a nascere in Medio Oriente siano Israele e Arabia Saudita, imparagonabili tra loro ma accomunati da una forte matrice nazional-religiosa, luoghi santi dell’ebraismo e dell’islam compresi? In questo secolo il settarismo, religioso o pseudo religioso, molto marginale con l’impero ottomano, è dilagato ovunque nella regione, alimentando guerre e terrorismi e spingendo verso il baratro dell’estinzione molte minoranze. Prima fra tutte, per numero e peso, quella cristiana: che all’epoca di Sykes e Georges-Picot formava il 10% dell’intera popolazione, nel 2010 era scesa al 5% e nel 2020 sarà poco oltre il 3%.
In questo secolo siamo passati dal “fardello dell’uomo bianco”, messo in versi da Kipling e tradotto in politica da Regno Unito e Francia, alla “battaglia per la democrazia” degli Stati Uniti, come dettato dallo spostamento degli equilibri mondiali. Ma nella sostanza poco è cambiato. E se alziamo lo sguardo, quel che vediamo è un paesaggio in rovina.
è quindi abbastanza ridicolo paventare, oggi, una guerra settaria tra sunniti e sciiti visto che abbiamo fatto quasi di tutto, ieri, per innescarla. Ci siamo schierati con il sunnita Saddam Hussein per aiutarlo a lanciare una guerra contro l’Iran sciita dell’ayatollah Khomeini (1980-1988). Poi abbiamo fatto la guerra al sunnita Saddam, prima per proteggere i curdi (ai quali peraltro era stato promesso uno Stato autonomo che non abbiamo mai voluto far nascere) e poi per insediare in Iraq un regime sciita (2003), al quale abbiamo poi rimproverato uno scarso rispetto per le esigenze delle minoranze sunnite irachene e pure per i curdi. Troviamo detestabile che la minoranza alawita del dittatore Assad controlli la Siria dove il 70% della popolazione è sunnita, ma legittimo che la monarchia sunnita del Bahrein opprima la maggioranza sciita (70%) e, in caso di proteste, chiami l’esercito saudita a sparare sulla gente, com’è successo nella primavera del 2011. E così via.
Questa politica neocoloniale è a fine corsa ovunque, perché i problemi del Medio Oriente non sono poi tanto diversi da quelli dell’Africa e persino dell’Europa, che dopo tanti decenni di pace è tornata a rivedere la guerra in casa propria. Questa politica dev’essere messa in soffitta, perché è ormai chiaro che il pianeta Terra è troppo ricco di persone, culture e sfumature per uniformarsi a un unico modello, foss’anche il più benevolo che riusciamo a inventare. Se non arriviamo a questa consapevolezza, il futuro sarà identico a questo tempo presente. Ma tanto più drammatico e travagliato.
Pensiamo solo al rapporto con i musulmani. Le ricerche del Pew Research Center ci hanno mostrato che, entro il 2050 e per la prima volta nella storia, il numero dei fedeli dell’islam sarà più o meno pari a quello dei cristiani: circa 2,8 miliardi di musulmani, cioè il 30% della popolazione mondiale, e 2,9 miliardi di cristiani, il 31%. Pensiamo alle attuali tensioni e proiettiamole nel prossimo futuro. Davvero vogliamo arrivare a quel mondo nuovo e complicato raccontandoci (e, quel che è peggio, raccontandolo ai musulmani stessi) che in Arabia Saudita ci sono i nostri amici “moderati”, anche se a Riad nel 2012 il gran muftì Sheikh Abdul-Aziz Alal-Sheikh, lo stesso che si è precipitato a esaltare le 47 esecuzioni in un giorno, ha emesso una fatwa per dare sanzione positiva al matrimonio coatto delle bambine di dieci anni?
Davvero crediamo di essere agenti di pace e sviluppo in Medio Oriente se i cinque Paesi del Consiglio di sicurezza dell’Onu (Usa, Francia, Gran Bretagna, Russia e Cina) sono anche i cinque maggiori produttori e venditori di armi nel mondo, e se i sei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar), che tutti insieme non arrivano a 40 milioni di abitanti, sono inondati dal 60% di tutte le armi che finiscono in Medio Oriente, una regione con quasi 400 milioni di abitanti?
Se non vogliamo cambiar strada per il bene del Medio Oriente, per il bene “loro”, facciamolo almeno per il nostro. Perché le azioni che un tempo potevamo intraprendere in casa d’altri, sapendo che mai si sarebbero ritorte contro di noi, ora sempre più spesso ci trasportano le loro conseguenze sull’uscio di casa. Le stragi di Parigi ne sono un atroce esempio. Ma una lezione ancora più dura e utile dovremmo averla imparata dalla crisi dei migranti, che a sua volta ha trovato un acceleratore nei disastri della Siria e della Libia.
Mentre le morti in mare si susseguono senza fine (3.770 annegati nel Mediterraneo nel 2015), l’Europa va in frantumi. Non sull’economia, non sulla finanza, non sulle politiche sociali ma sull’accoglienza ai migranti. Si costruiscono muri, vengono ripristinate le frontiere gioiosamente abbattute solo nel 1993 col Trattato di Schengen, Nord e Sud dell’Unione si dividono tra chi subisce il primo “urto” dei migranti e chi non vuole partecipare degli oneri. Ogni Paese decide in proprio e ovviamente, essendo le migrazioni un problema globale e collettivo, decide male. La Germania fa il gesto, bello e interessato, di accogliere i profughi siriani: a cascata, la Danimarca diviene terreno di transito verso la Svezia, che in un solo anno deve accogliere 160mila richiedenti asilo. Risultato: la Svezia chiude le frontiere con la Danimarca, che le chiude con la Germania che ha già rinforzato i controlli. Alla fine, i paesi europei del Mediterraneo tornano a essere soli a gestire il flusso dei migranti.
La preoccupazione e l’isteria per i migranti, poi, nascondono il solito refrain dello scontro di civiltà, la propaganda politica più cinica e disinvolta è sempre a un millimetro dalla vecchia bufala dell’Eurabia, l’Europa infine conquistata dall’islam pronto a sfruttare la sua unica arma letale: il ventre delle donne. Non servono a nulla studi e proiezioni, di nuovo quelli del Pew Research Center, in base ai quali nel 2050 i musulmani in Europa saranno pari al 10% della popolazione, al massimo il 12% se le migrazioni dovessero continuare fino ad allora con questa intensità, come di certo non avverrà. Nessuno ascolta, e pochissimi riescono a tarare le decisioni politiche sulla realtà e non sull’angoscia.
Così si chiude il cerchio: gli sbagli del passato, evidenti nel presente, decidono del nostro futuro.
Eccolo, il vero fardello dell’uomo bianco.