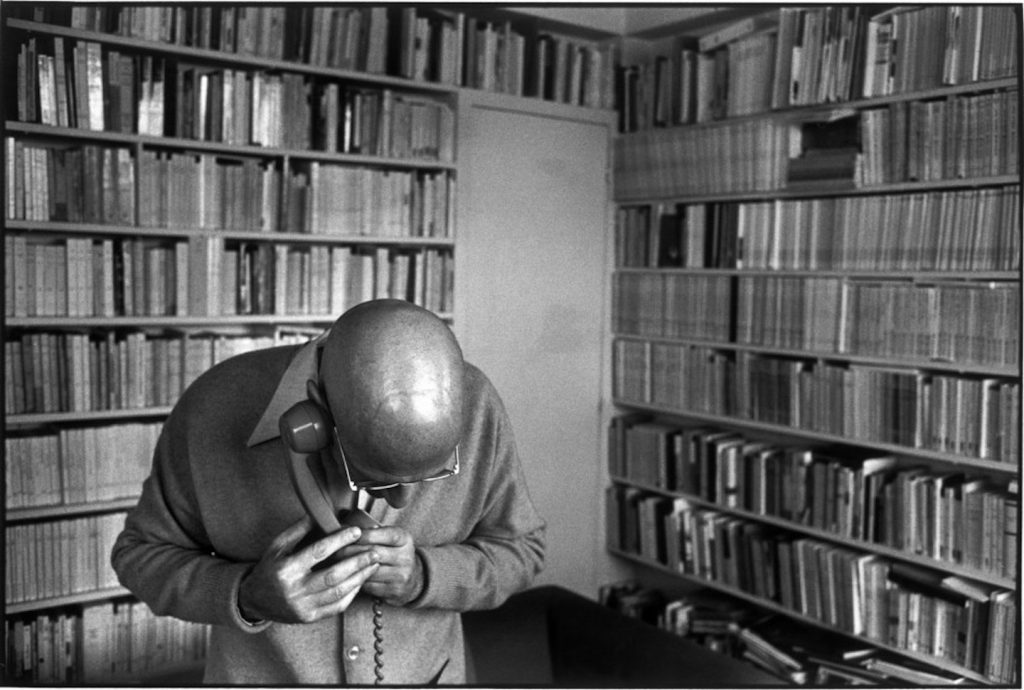Da noi i personaggi dettano legge alla percezione. Gli occhi si rivolgono preferibilmente verso le figure che vanno e vengono, spuntano e scompaiono. Perché le ho suggerito di utilizzare l’anonimato? Per nostalgia del tempo in cui ero assolutamente sconosciuto e, quindi, quel che dicevo aveva qualche possibilità di essere inteso. Il contatto immediato con l’eventuale lettore non faceva grinze. Gli effetti del libro si riflettevano in luoghi imprevisti e disegnavano forme a cui non avevo mai pensato. Il nome costituisce una facilitazione.
Vorrei proporre un gioco: quello dell’“anno senza nome”. Per un anno si pubblicheranno soltanto libri privi del nome dell’autore. I critici dovranno sbrigarsela con una produzione completamente anonima. Ma penso che, forse, non avrebbero nulla da dire: tutti gli autori aspetterebbero l’anno successivo per pubblicare i loro libri…
Crede che, oggi, gli intellettuali parlino troppo? Che ci ingombrino con i loro discorsi al minimo pretesto e, spesso, anche senza il minimo pretesto?
La morte degli intellettuali mi sembra uno strano concetto. Di intellettuali, non ne ho mai incontrati. Ho incontrato persone che scrivono romanzi e persone che curano i malati. Persone che studiano economia e persone che compongono musica elettronica. Ho incontrato persone che insegnano, persone che dipingono e persone di cui non ho ben capito se facessero qualcosa. Ma non ho mai incontrato intellettuali. Viceversa, ho incontrato molte persone che parlano dell’intellettuale. E, a forza di ascoltarli, mi sono fatto un’idea di che tipo di animale si tratti. Non è difficile, è il colpevole. Colpevole un po’ di tutto: di parlare, di tacere, di non fare nulla, di impicciarsi di ogni cosa… Insomma, l’intellettuale è la materia prima da giudicare, da condannare, da escludere…Non penso che gli intellettuali parlino troppo, perché per me non esistono. Ma penso che il discorso sugli intellettuali stia passando il limite e sia poco rassicurante. Ho una brutta mania. Quando le persone parlano tanto per parlare, quando fanno discorsi campati per aria, cerco di immaginare dove porterebbero le loro parole se fossero trascritte nella realtà. Quando “criticano” qualcuno, quando “denunciano” le sue idee, quando “condannano” ciò che scrive, li immagino in una situazione ideale in cui hanno pieno potere su di lui. Riporto le loro parole al primo significato: “Demolire”, “abbattere”, “ridurre al silenzio”, “seppellire”. E vedo schiudersi la radiosa città in cui l’intellettuale sarebbe certamente imprigionato e impiccato, a maggior ragione se fosse anche un teorico. È vero, non viviamo in un regime in cui gli intellettuali vengono mandati nelle risaie; ma, in realtà, mi dica, ha mai sentito parlare di un certo Toni Negri? Non è forse in prigione proprio in quanto intellettuale?
Ma, allora, che cosa l’ha indotta a trincerarsi dietro l’anonimato? Un certo uso pubblicitario che, oggi, certi filosofi fanno o lasciano fare del loro nome?
Questo non mi turba minimamente. Nei corridoi del mio liceo ho visto grandi uomini di gesso. E ora, sulla prima pagina dei giornali, in basso, vedo la fotografia del pensatore. Non so se l’estetica sia migliorata. La razionalità economica lo è sicuramente…In fondo, mi colpisce profondamente una lettera scritta da Kant, quando era già molto vecchio: contro l’età, la vista che si abbassava e le idee che si confondevano, si affrettava, così racconta, a terminare un libro per la fiera del libro di Lipsia. Racconto questo episodio per dimostrare che non ha nessuna importanza. Pubblicità o no, fiera o no, il libro è tutt’altra cosa. Non riusciranno mai a farmi credere che un libro sia brutto perché si è visto il suo autore alla televisione. Ma neanche che sia buono per questa sola ragione.
Se ho scelto l’anonimato, non è per criticare questo o quello, cosa che non faccio mai. È un modo per rivolgermi più direttamente all’eventuale lettore, l’unico personaggio che mi interessa:
“Siccome non sai chi sono, non avrai la tentazione di cercare le ragioni per cui dico quello che leggi; lasciati andare, di’ semplicemente: è vero, è falso, mi piace, non mi piace. Punto e basta”.
Ma il pubblico non si aspetta che la critica fornisca dei giudizi precisi sul valore di un’opera?
Non so se il pubblico si aspetti che il critico giudichi le opere o gli autori. Ma credo che i giudici fossero già lì prima che il pubblico potesse dire di che cosa aveva voglia. Sembra che Courbet avesse un amico che si svegliava di notte urlando: “Giudicare, voglio giudicare”. È incredibile quanto le persone amino giudicare. Si giudica ovunque, di continuo. Probabilmente, per l’umanità, è una delle cose più semplici da fare. Ma lei sa che l’ultimo uomo, quando l’ultima radiazione avrà ridotto in cenere il suo ultimo avversario, prenderà un tavolo sbilenco, si siederà e comincerà il processo al responsabile? Non posso fare a meno di pensare a una critica che non cerchi di giudicare, ma di far esistere un’opera, un libro, una frase, un’idea; accenderebbe dei fuochi, guarderebbe crescere l’erba, ascolterebbe il vento e prenderebbe al volo la spuma del mare per disperderla. Riprodurrebbe, invece che dei giudizi, dei segni di vita; li chiamerebbe, li strapperebbe dal loro sonno. Talvolta li inventerebbe? Tanto meglio, tanto meglio. La critica sentenziosa mi fa addormentare; vorrei una critica fatta di scintille di immaginazione. Non sarebbe sovrana, né vestita di rosso. Porterebbe con sé i lampi di possibili tempeste.
Ma ci sono talmente tante cose da far conoscere, talmente tanti lavori interessanti, che i media dovrebbero parlare tutto il tempo di filosofia?
Certamente, tra la “critica” e coloro che scrivono libri esiste un disagio di lunga data. Gli uni non si sentono capiti e gli altri credono che si voglia fare pressioni su di loro. Ma il gioco è questo. Mi sembra che oggi la situazione sia abbastanza particolare. Abbiamo istituzioni povere, mentre ci troviamo in una situazione di sovrabbondanza. Tutti si sono accorti dell’esaltazione che spesso accompagna la pubblicazione (o la riedizione) di opere, che peraltro talvolta sono interessanti. Si tratta, sempre, nientemeno che della “sovversione di tutti i codici”, dell’“antagonista della cultura contemporanea”, della “discussione radicale di tutto il nostro modo di pensare”. Il suo autore deve essere un marginale incompreso.
In compenso, non c’è dubbio che gli altri debbano essere rispediti nell’oscurità da cui non avrebbero mai dovuto uscire; non erano nient’altro che la schiuma di “una moda irrilevante”, un semplice prodotto istituzionale, ecc.
Si dice che si tratta di un fenomeno parigino e superficiale. Io vi percepisco, invece, gli effetti di un’inquietudine profonda. Il sentimento del “nessun posto libero”, “o lui o me”, “uno alla volta”. Si sta in fila indiana, a causa dell’estrema esiguità di luoghi in cui poter ascoltare e farsi sentire.
Ne consegue una specie di angoscia che prorompe in mille sintomi, più o meno curiosi. Da qui, in coloro che scrivono, il sentimento della loro impotenza di fronte ai media, ai quali rimproverano di dominare il mondo dei libri e di far esistere o scomparire quelli che piacciono o dispiacciono. Da qui, nei critici, il sentimento di non riuscire a farsi ascoltare, a meno di alzare il tono e di tirar fuori dal cappello un coniglio alla settimana. Da qui anche la pseudopoliticizzazione, che maschera, dietro alla necessità di condurre una “battaglia ideologica” o di stanare i “pensieri pericolosi”, l’ansia profonda di non essere né letti né ascoltati. Da qui anche la fobia fantastica del potere: ogni persona che scrive esercita un potere inquietante a cui bisogna cercare di porre, se non un termine, almeno dei limiti. Da qui anche l’affermazione un po’ incantatrice che, attualmente, tutto è vuoto, desolato, privo di interesse e di importanza: affermazione che, evidentemente, proviene da coloro che, non facendo nulla, pensano che gli altri siano di troppo.
Ma non crede che la nostra epoca sia realmente priva di spiriti all’altezza dei suoi problemi e di grandi scrittori?
No, non credo al ritornello della decadenza, dell’assenza di scrittori, della sterilità del pensiero, dell’orizzonte cupo e tetro. Credo, al contrario, che ci sia un’abbondanza eccessiva. E che non soffriamo per il vuoto, ma perché i mezzi per pensare a tutto quello che accade sono troppo pochi. Ci sono moltissime cose da conoscere: fondamentali, terribili, meravigliose o strane,insieme minuscole e capitali. E poi c’è una curiosità immensa, un bisogno, un desiderio di conoscere. Ci si lamenta sempre che i media imbottiscono la testa delle persone. In questa idea c’è della misantropia. Credo, invece, che le persone reagiscano; più si cerca di convincerle, più si interrogano. Lo spirito non è una cera molle. È una sostanza reattiva. E il desiderio di saperne di più, meglio e diversamente, cresce man mano che si cerca di imbottire le teste.
Se questo è vero e se aggiungiamo a questo che, all’università e in altri luoghi, si stanno formando grandi quantità di persone che possono servire da scambiatori tra la massa di cose e l’avidità di sapere, si può ben presto dedurre che la disoccupazione degli studenti è la cosa più assurda che esista. Il problema è di moltiplicare i canali, le passerelle, i mezzi di informazione, le reti televisive e quelle radiofoniche, i giornali. La curiosità è stata un vizio stigmatizzato di volta in volta dal Cristianesimo, dalla filosofia e persino da una certa concezione della scienza. Curiosità, futilità. Eppure, la parola mi piace. Mi suggerisce una cosa affatto diversa: evoca la “cura”, l’attenzione che si presta a quello che esiste o potrebbe esistere; un senso acuto del reale, che però non si immobilizza mai di fronte a esso; una prontezza a giudicare strano e singolare quello che ci circonda; un certo accanimento a disfarsi di ciò che è familiare e a guardare le stesse cose diversamente; un ardore di cogliere quello che accade e quello che passa; una disinvoltura nei confronti delle gerarchie tradizionali tra ciò che è importante e ciò che è essenziale.
Sogno una nuova età della curiosità. I mezzi tecnici ci sono; il desiderio c’è; le cose da conoscere sono infinite; le persone che possono impegnarsi in questo lavoro esistono. Di che cosa soffriamo? Di scarsità: canali stretti, striminziti, quasi monopolistici, insufficienti. Non si tratta di adottare un atteggiamento protezionista per impedire alla “cattiva” informazione di invadere e di soffocare la “buona”. Bisogna, invece, moltiplicare i tragitti e le possibilità di andare e venire. Nessun colbertismo in quest’ambito. Il che non significa, come spesso si teme, uniformizzazione e livellamento verso il basso. Significa, al contrario, differenziazione e simultaneità di reti differenti. Immagino che, a questo livello, i media e le università potrebbero avere funzioni complementari, invece di continuare a opporsi.
Lei ricorda la mirabile frase di Sylvain Lévy: l’insegnamento comporta un uditore; appena ce ne sono due, diventa volgarizzazione. Anche i libri, l’università, le riviste colte sono dei media. Si dovrebbe evitare di chiamare media i canali di informazione ai quali non si può o non si vuole accedere. Bisogna capire come far agire le differenze; sapere se si debba instaurare una zona riservata, un “parco culturale” per le fragili specie dei colti, minacciati dai grandi rapaci dell’informazione, mentre tutto il resto dello spazio sarebbe una vasto mercato per la paccottiglia.
Non mi sembra che una simile ripartizione corrisponda alla realtà. Peggio: non mi sembra affatto augurabile. Per far agire le differenze utili non deve esserci nessuna ripartizione.
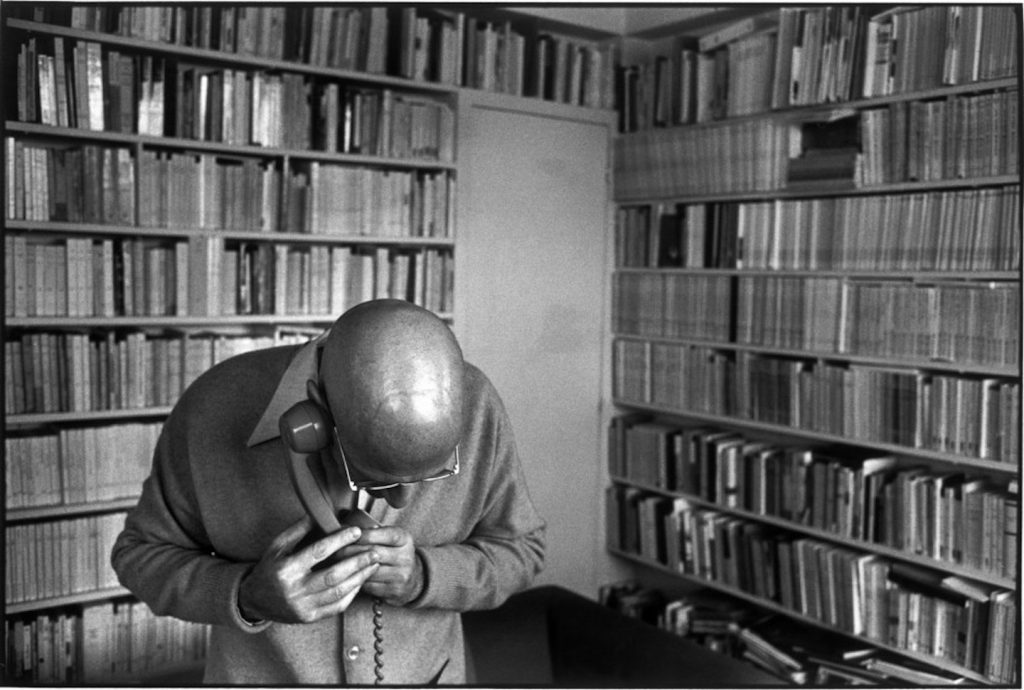
Proviamo a fare qualche proposta concreta. Se tutto va male, da dove si può cominciare?
Ma no, non va tutto male. In ogni caso, credo che non si debba confondere la critica costruttiva contro le cose con le geremiadi ripetitive contro le persone. Per quanto riguarda le proposte concrete, esse appaiono come dei gadget, se prima non vengono precisati alcuni princìpi generali. Questo, prima di tutto: il diritto al sapere non deve essere riservato né a un’età della vita, né a certe categorie di individui; si deve poterlo esercitare ininterrottamente e in forme molteplici.
Ma questa voglia di sapere non è ambigua? Alla fine, che cosa se ne farà la gente di tutto questo sapere che sta acquisendo? A che cosa potrà servire?
Una delle funzioni principali dell’insegnamento consisteva in questo: la formazione dell’individuo andava di pari passo con la determinazione del suo posto nella società. Oggi bisognerebbe concepire l’insegnamento in modo tale da permettere all’individuo di modificarsi a suo piacimento; e questo è possibile soltanto alla condizione che l’insegnamento sia una possibilità offerta “in permanenza”.
Insomma, lei è per una società colta?
Dico che il collegamento alla cultura deve essere continuo e il più polimorfo possibile. Non dovrebbero esserci, da una parte, una formazione che si subisce e, dall’altra parte, un’informazione a cui si è sottomessi.
Che ne sarà, in una società colta, della filosofia eterna?… Abbiamo ancora bisogno di lei, dei suoi interrogativi senza risposta e dei suoi silenzi di fronte all’inconoscibile?
Che cos’è la filosofia, se non un modo di riflettere, non tanto su ciò che è vero e ciò che è falso, ma sul nostro rapporto con la verità? Talvolta ci si lamenta che in Francia non esista una filosofia dominante. Tanto meglio. Non c’è nessuna filosofia sovrana, è vero, ma c’è una filosofia o, piuttosto, della filosofia in attività. La filosofia è il movimento per cui ci si distacca – con sforzi, esitazioni, sogni e illusioni – da ciò che è acquisito come vero, per cercare altre regole del gioco. La filosofia è lo spostamento e la trasformazione dei quadri di pensiero, il modificarsi dei valori ricevuti, tutto il lavoro che si fa per pensare diversamente, per fare diversamente, per diventare altro da quello che si è. Da questo punto di vista, gli ultimi trent’anni sono stati un periodo di intensa attività filosofica. L’interferenza tra l’analisi, la ricerca, la critica “colta” o “teorica” e i cambiamenti nel comportamento, la condotta reale delle persone, la loro maniera di essere, il loro rapporto con se stesse e con gli altri, è stata costante e considerevole. Un attimo fa dicevo che la filosofia è un modo di riflettere sulla nostra relazione con la verità. Bisogna aggiungere; è un modo di chiedersi: se questo è il rapporto che abbiamo con la verità, come dobbiamo comportarci? Credo che sia stato fatto e che si stia continuando a fare un lavoro considerevole e molteplice, che modifica, contemporaneamente, il nostro legame con la verità e la nostra maniera di comportarci. E questo in una congiunzione complessa tra una serie di ricerche e un insieme di movimenti sociali. È la vita stessa della filosofia. È comprensibile che alcuni piangano sul vuoto attuale e si augurino, nell’ordine delle idee, un po’ di monarchia. Ma quelli che, almeno una volta nella loro vita, hanno provato un tono nuovo, una nuova maniera di guardare, un altro modo di fare, quelli, credo, non sentiranno mai il bisogno di lamentarsi perché il mondo è errore, la storia satura di inesistenze; è tempo che gli altri tacciano, in modo da non sentire più il suono della loro riprovazione…