Vent’anni fa usciva nelle sale cinematografiche italiane Pulp Fiction, il capolavoro di Quentin Tarantino. Era il 16 dicembre 1994, nove mesi dopo l’imprevista e straordinaria vittoria elettorale di Silvio Berlusconi, sei giorni prima delle sue dimissioni consegnate nelle mani di Oscar Luigi Scalfaro il 22 dicembre. Nessuno stabilì allora un nesso tra questa storia postmoderna di gangster, sermoni, sodomie, gare di ballo, teste esplose, non-luoghi di Los Angeles, tra il gioco sadico e farsesco istituito dal giovane regista americano e quello che succedeva nel nostro paese, dove una crisi sociale e politica, durata oltre dieci anni, arrivava a compimento segnando un deciso e irreversibile giro di boa.
Pulp Fiction diventò immediatamente un film di culto, premiato a Cannes con la Palma d’Oro e anche con un Oscar, nell’anno seguente, fissando con la sua apparizione nei cinema un punto di non ritorno, sia per il modo in cui era narrato sia per i temi che offriva agli sconcertati, oppure entusiasti, spettatori. Quello che Pulp Fiction rivelava in quel momento preciso era il dominio incontrastato stabilito dalle immagini nella nostra realtà quotidiana. Alberto Morsiani in un libro dedicato all’opera di Tarantino (Quentin Tarantino. Pulp Fiction, Lindau) ha sintetizzato tutto ciò in modo icastico: Tarantino aveva capito d’istinto che le immagini erano diventate il nostro vero oggetto sessuale, l’oggetto del nostro desiderio. Anche se l’autore de Le iene, film antefatto di Pulp fiction, non aveva letto Jean Baudrillard, il suo Sistema degli oggetti o Lo scambio simbolico e la morte, usciti tra gli anni Sessanta e Settanta, mostrava che erano proprio le immagini a ossessionarlo, e anche a ossessio
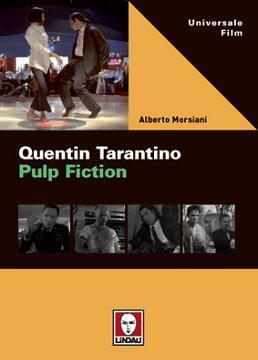
L’ascesa del tycoon brianzolo sanciva in 1994 il cambiamento di paradigma, anche se la lettura allora prevalente – lo sarebbe rimasta per due decenni a seguire – era quella modellata sulla critica pasoliniana della società dei consumi. Non che non ci fosse anche questo, ma certamente Tarantino ci mostrava da Los Angeles un mondo in cui la Legge non esisteva, dove l’istanza del godimento era dominante (non a caso l’unico poliziotto, o presunto tale, uno che veste la divisa della Legge, è un sadico violentatore perverso). Certo, Pasolini aveva declinato quell’universo nel film-parabola Salò o le 120 giornate di Sodoma, ancor oggi un’opera inguardabile per la sua tetra e assoluta visione, tuttavia Tarantino con il suo passo ironico e ludico spiazzava la lettura del regista italiano, creando una storiaccia assurda e paradossale, in cui gli eroi sono dei personaggi stereotipati, pure marionette, dominati dalla fatalità dell’accadere, e insieme da un movimento narcisistico nato dall’interno di ciascuno di loro, fino a diventare regola generale dell’universo umano.
Morsiani lo dice con molta efficacia: i personaggi di Pulp Fiction sono stereotipi, che vogliono assomigliare a se stessi. Se un tempo l’ossessione era di assomigliare agli altri, di essere uno nella folla – l’età delle ideologie novecentesche, il “Tutti”, come è stato detto da un recente romanzo di formazione italiano –, dopo Tarantino l’ossessione è quella di “assomigliare solo a se stessi”. Se ci fosse stato allora lo smartphone – c’erano già i cellulari, anche nel film, dotati di antenne estraibili –, senza dubbio Vincent e Julius, i due killer al soldo di Marsellus, si sarebbero probabilmente fatti degli autoscatti, Selfie, tra i cadaveri delle vittime, o negli spazi urbani da loro frequentati. L’ascesa della televisione commerciale sanciva in Italia in quel decennio – gli anni Novanta che ancora attendono il loro interprete – la diffusione del narcisismo di massa. Christopher Lasch l’aveva annunciato vent’anni prima, con il suo La cultura del narcisismo (Lasch scompare peraltro in quel 1994), indicando proprio negli strumenti di riproduzione di suoni e immagini – registratori e macchine fotografiche – gli strumenti dell’ascesa del narcisismo; “la vasta camera dell’eco”, come aveva scritto). Ogni personaggio nel film “vive per se stesso, si riassume in un punto iperpotenziale: gli altri non esistono virtualmente più” (Morsiani); tanto che Jules, il gigantesco nero del film, rivolgendosi a se stesso pronuncia la frase: “Let’s get into character!”.

Quello che ancora colpisce in questo film, rivisto oggi, oltre al ritmo, la distribuzione narrativa degli eventi, le inquadrature, le storie efferate, la violenza, la casualità, la follia dei comportamenti, l’imprevedibilità, tutti aspetti che ancora funzionano, è “la democrazia universale della rappresentazione” offerta agli spettatori in quel dicembre di vent’anni fa. La rappresentazione, ci dice Tarantino, ha assorbito dentro di sé ogni altra cosa. Dopo quarant’anni di dominio incontrastato di televisione, cartoni animati, pubblicità, packaging, segni, lettere e cifre distribuite ovunque, dopo l’esplosione dello star system, come aveva scritto Edgar Morin in un libro preveggente (Le star, 1957), eravamo entrati – anno 1994 – nel regno della pura rappresentazione. Il film di Tarantino offriva la prova provata di tutto questo, assorbendo dentro di sé ogni altro riferimento visivo, dagli spot pubblicitari ai vecchi film, dalle marche di prodotti alimentari a quello delle automobili, investendo praticamente tutto quello che appariva sulla superficie visiva del mondo, colonizzando così ogni angolo possibile dell’immaginario personale e collettivo. L’elenco completo delle citazioni filmiche più o meno palesi occupa almeno un paio di fitte pagine, come mostrano i molti libri che sono stati scritti su Pulp Fiction, dove gli autori si divertono a scoprire le criptocitazioni del regista.
La bravura di Tarantino era consistita nel trasformare la normalità dell’esistenza in un’allucinazione protratta, ma anche il suo contrario: l’allucinazione della normalità. Tutto è imprevisto e imprevedibile nel regno senza Norma, ma anche senza Trasgressione (questo è il punto, come sarebbe stato detto dagli psicoanalisti anni dopo), in cui si muovono i suoi personaggi dediti a un’impressionante immoralità. Quello che non fu subito chiaro era proprio questo: l’annullamento delle regole e insieme delle eccezioni, della normalità e contemporaneamente della trasgressione. Non si sapeva più bene cosa fosse una trasgressione là dove l’arbitrio era eretto a norma. Pasolini questo non lo diceva vent’anni prima nella sua caliginosa pellicola.
Tarantino stordiva con la sua alterazione narrativa, spostando inizio e fine, mescolando le carte della successione temporale, facendo morire, poi resuscitare i suoi personaggi in una sequenza di fatti alterata. Ma non era solo o tanto questo il suo punto di forza. In effetti, rivisto vent’anni dopo, con il finale che si richiude ad anello sull’inizio – la rapina nel diner, l’Hawthorne Grill, dove si trovano Jules e Vincent –, sappiamo che la struttura del film è un cerchio, e ci offre una lettura parareligiosa, o presunta tale, del rapporto tra caso e grazia, tra vita e morte. Una meditazione non ultimativa, e neppure assoluta sul destino singolare, tentativo di sottrarre, almeno per un istante i suoi personaggi al dominio incontrastato delle immagini, perché Tarantino profeta del post-postmoderno contiene dentro di sé ancora un’istanza moderna, quella che poi rende la società americana, nonostante il culto warholiano delle immagini ripetibili, assolutamente imprevedibile.
Jules, il killer nero, con la sua speranza di grazia, palesata negli ultimi minuti del film, rientra nel millenarismo evangelico delle sette religiose americane descritto da Harold Bloom in La religione americana (Garzanti), saggio dedicato all’avvento della società post-religiosa. Nonostante il suo nichilismo Pulp Fiction contiene anche quest’aspetto, che è, almeno in termini cronologici, la causa stessa del sorgere della democrazia dell’immagini.
Visto a questa distanza temporale, vent’anni non sono pochi, e dopo la fine del berlusconismo, pratica politica postmoderna all’italiana, il film di Tarantino appare come premonizione di quello che sarebbe accaduto, ma anche una sua critica implicita, perché nonostante la sua insistenza sugli aspetti del simulacro – ancora Baudrillard – Pulp fiction presenta almeno un personaggio che pare smentire tutto l’universo del delirio comunicativo che la pellicola ci offriva a piene mani.
Butch, il pugile, è infatti il personaggio positivo, positività naturalmente non priva di ambiguità, come in ogni film di Tarantino. Butch contravviene al contratto truffaldino con Marsellus, lo spietato boss, di andare al tappeto alla quinta ripresa del match che sta per combattere. Frega il gangster e abbatte l’avversario – in realtà lo uccide, anche senza volerlo davvero –, quindi scappa con i soldi che ha ricevuto per la truffa, e con quelli ricavati dalle puntate sulla propria vittoria. Nel seguito della storia Butch salva Marsellus, il nemico, che ha tentato di uccidere con l’automobile, dalle mani dei suoi aguzzini che lo stanno violentando, recuperando in questo modo il passato eroico della propria famiglia. Un vero cow boy, opposto e simmetrico all’idiota comandante del bombardiere che sgancia l’atomica sull’Unione Sovietica nel Dottor Strananore.
Il pugile di Tarantino si batte contro il Male, pur essendone stato parte. Butch possiede uno dei talismani magici di questa fiaba postmoderna: l’orologio. Il suo bisnonno ha combattuto nella Prima guerra mondiale portando con sé l’orologio d’oro da polso, che passa poi al nonno, il quale muore in guerra durante il Secondo conflitto mondiale. L’oggetto arriva sino al figlio, che è pilota nella guerra del Vietnam. Catturato dai nordvietnamiti, il genitore di Butch conserva nascosto nel sedere per cinque anni l’orologio, fino a che, morente, lo passa a un commilitone, il quale per altri due anni lo custodisce nell’ano (situazione che ha il gusto dello sfregio tipico dell’epos di Tarantino in questo film, e non solo lì). In una delle scene del film, chiaramente un sogno, Tarantino ci narra la storia dell’orologio e la sua consegna al piccolo Butch da parte del commilitone del padre, così da farne uno dei motivi narrativi della pellicola. Sarà proprio la dimenticanza di questo oggetto da parte di Fabienne, la donna di Butch, a spingere questi a tornare sui suoi passi fino alla propria casa, per ritrovarlo e portarlo con sé. L’ossessione dell’analità, come rimarca Morsiani, allude anche alle radici protestanti dell’intera cultura americana bianca (si veda il tema dell’analità in Norman O. Brown, La vita contro la morte, Adelphi, autore cult degli anni Sessanta, insieme al Marcuse di L’uomo a una dimensione): tempo e denaro. Inoltre, l’orologio manifesta l’ossessione per il controllo del tempo produttivo: tempo della storia narrata e tempo di produzione della storia narrata (Pulp fiction come film del mondo post-fordista?).
Butch incarna con Jules, il nero diventato improvvisamente “credente” per via del miracolo occorsogli nel corso di una sparatoria, l’aspirazione a una diversa verità nella società dei simulacri raccontata visivamente da Tarantino. L’America dalle molte facce.
Vent’anni dopo Pulp Fiction rivela altri elementi che ci permettono di leggere ciò che è accaduto dopo il Papi di Arcore. Il primo che colpisce è l’insistenza sull’estetica vintage nell’episodio in cui Vincent accompagna fuori a cena la moglie del suo boss, il terribile Marsellus, Mia. “Che cazzo di posto è questo?”, domanda Vincent. “È il Jack’s Rabbit Slim’s. Hai l’aria di un ragazzo anni ’50. A un amante di Elvis dovrebbe piacere”, risponde Mia. Il locale dove lei ha prenotato un tavolo reca la scritta: “La cosa più simile a una macchina del tempo”. All’interno c’è Surf music e luci al neon. Alle pareti poster di vecchi film di serie B, mentre il personale è composto di sosia di vecchi divi, da Elvis a Dean Martin, Marilyn Monroe, James Dean, ecc. I due si siedono dentro una vecchia automobile e ordinano.

Siamo in pieno vintage, con un rovesciamento interessante, come nota Morsiani: mentre il divo è stato nel suo passato un cameriere, qui nel locale i camerieri somigliano ai divi. Tutto il film lavora su questa dimensione del passato prossimo, perché nel postmoderno alla Tarantino ogni cosa è già stata vista. In effetti, non è solo sulla manipolazione temporale del racconto che il regista americano agisce, ma anche sulla dimensione tempo in generale, in particolare il tempo rispetto alla memoria.
Rivisto oggi, dopo la Leopolda numero cinque, dopo il bric a brac renziano allestito nell’ex stazione di Firenze, si comprende come il vintage sia diventato uno degli elementi centrali della cultura post Pulp fiction. Sono i cortocircuiti temporali ad appassionare Tarantino, e non solo lui. L’attuale Presidente del Consiglio, nato nel 1975, appartiene di fatto alla generazione venuta dopo Tarantino. Lo stile del regista americano prefigura quello che è accaduto successivamente, ovvero: la contemporaneità come proliferazione incontrollata delle immagini. Con una precisazione: solo alcuni oggetti vengono risignificati nell’ambito delle carabattole offerte dal grande magazzino della civiltà americana (non era forse quello il grande magazzino dove, alla fine di Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, anno 1981, veniva posta l’Arca dell’Alleanza?). La favola bella raccontata da Tarantino è diventata una realtà politico-sociale: tutto il passato deve confluire in un eterno presente (Morsiani).

Possibile? Probabile. La generazione-Tarantino non è solo quella dei cinici con la patente (sarcasmo adolescenziale, più spregiudicatezza), ma anche quella performativa esibita dai suoi personaggi, nel continuo scambio tra parola e atto, tra atti di parola e parole di atti. Il tutto condito da quella che è il termine chiave dell’intero fil, al di là della sua violenza (più suggerita che veramente vista): cool; termine che indica la capacità che possiedono i personaggi di Pulp fiction di tenere sempre sotto controllo la situazione, “incorporando proprio per questo momenti di gioco, di godimento improvvisato e immediato che sembrerebbero l’esatto contrario del rigido professionismo”. Cool sta per freddezza e insieme gioco, indica l’aspetto fascinoso che i suoi “cattivi” manifestano. Siamo in quella zona in cui l’istantaneità totale delle cose, per dirla con Morsiani, rivela “una sovraesposizione alla trasparenza del mondo”. Pulp Fiction ha pronosticato Renzi? Forse è troppo ipotizzarlo, ma un troppo forse non tanto lontano dal vero.

