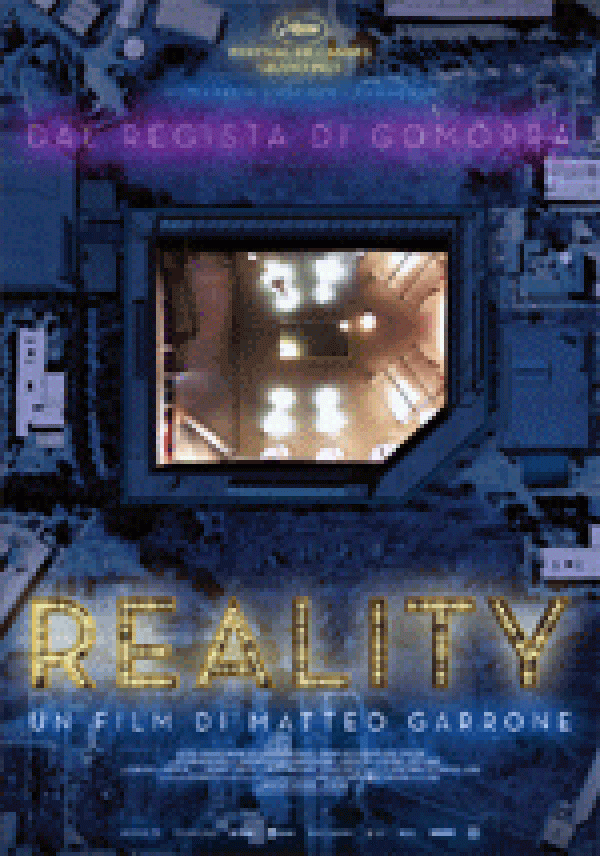Abbiamo visto Reality regia di Matteo Garrone.
Cosa vuol dire oggi in Italia – e forse non solo – scrivere e dirigere un film complesso, compiuto e d’autore? Su cosa ponderano critici e addetti ai lavori di film come questo di Garrone? Citano Pasolini, citano Guy Debord, parlano di genocidio culturale e di antropologia. Non per essere per forza ‘contro’, per volersi distinguere: ma di cosa parliamo quando parliamo di Cinema? Cosa pensano i nostri autori quando decidono di fare un film?
Questa storia e i suoi critici sono a tutti gli effetti nel sonno della ragione, satolli e scoglionati, solipsisti e presuntuosi. Solo apparentemente svegli, attenti e profondi, per stanchezza collettiva. Prendete il micromondo raccontato in questo film, quello che Marx chiamava proletariato straccione Lumpenproletariat (il ceto infimo delle grandi città, formato di elementi economicamente e socialmente instabili, per effetto della disoccupazione e della sottoccupazione – troverete in qualsiasi enciclopedia questa definizione), aggiungete una sottocultura tipica del sud Italia, sanfedista, reazionaria e terribilmente ingenua – senza voler ricordare Masaniello da un lato né tantomeno “il clan dei casalesi” dall’altra – e viene fuori questo soufflé cotto male in cui non si riconoscono gli ingredienti e rimane uno strano sapore in bocca, anche un po’ eccessivo e da surgelato. In un mondo della periferia urbana napoletana, dove tutto avviene e tutto è possibile – anche per stereotipi – cosa ci racconta Matteo Garrone? Di un affettuoso – ma non onesto – padre di famiglia che nella speranza casuale di partecipare al Grande Fratello inizia a sragionare e a perdere il senno. C’è il concetto sfruttato dell’omologazione pasoliniana? C’è in questa storia un rapporto sociale fra individui mediato dalle immagini di debordiana memoria? E poi: c’è ancora un’antropologia nelle società di massa occidentale? Ma veniamo a questo film che ci vuole raccontare… Cosa? Siamo confusi, sinceramente. Ipotizziamo, l’uomo che cerca un affermazione sociale effimera e ottiene solo un ossessione distruttiva? Un popolo che ha perso i suoi valori e vuole i soliti quindici minuti di celebrità individuale? Oppure che gli esseri umani sono schiacciati dal mondo che li circonda, per cui si fanno condizionare fino all’alienazione? Sinceramente non lo capiamo e se fosse questo sarebbe il solito topolino asfittico. A questo aggiungete un regista che non riesce a coniugare dramma e ironia, tragedia, fiaba e farsa, per cui non si sa quando e perché si debba riflettere o ridere. E di cosa, poi? Della piccola gente che sopravvive come può e chiede quasi nulla alla vita?
Un’idea di regia confusa che non ha imparato niente né da Rossellini ma neanche dal teatro Eduardo de Filippo. Una scelta registica che indugia sulle mostruosità fisiche e morali di povera gente senza storia e senza ambizioni, che ricordano per distacco e indifferenza più certi primi piani fisici dei film della Wertmuller anni Settanta che non la lezione di Fellini o i quadri di Groz o di Botero. In queste opere c’è amore verso le persone, affetto e comprensione ed anche un’affettuosa presa in giro dei difetti umani. Invece nel film di Garrone sembra tutto preso a pretesto per raccontare con una lente deformata qualcosa di cui non si sa bene cosa si vuole dire e capire. Come voler guardare il mondo attraverso uno specchio deformato e voler parlare dei massimi sistemi sull’essere umano e le sue fragilità senza avere molto da dire.
E’ vero, il Grande Fratello è solo un pretesto (come potrebbe essere una lotteria che si vuole vincere o un terno al lotto tanto atteso; pretesto, come nelle pochade degli anni Trenta di opere teatrali minori di Eduardo o Peppino De Filippo. Un po’ come i pretesti cinematografici di Salemme, oggi), ma sono un pretesto anche le pressioni di un quartiere su un uomo che candido non è, come la psicologia di Luciano che non viene assolutamente esplorata ma data come una cartolina d’altri tempi. Insomma abbiamo visto un pastiche irrorato di luoghi comuni, senza alcuna vera drammaticità né tragedia, tantomeno farsa o fiaba nera. Tutti generi seri e importanti da affrontare e gestire con acume e sensibilità.
Il film inizia con una carrellata sulla città e il regista raggiunge un uomo nella folla, Luciano (un bravo Aniello Arena, ergastolano e attore della compagnia La Fortezza che Armando Punzo ha creato con i detenuti del carcere di Volterra) il classico uomo senza qualità napoletano, dark queen per gioco, pescivendolo accomodante e paziente di mattina e intrallazzatore di piccole frodi con dei robottini da cucina nel resto del giorno. Un uomo che fa lo sconto ai clienti della pescheria e trascina quasi via da una chiesa una donna momentaneamente sua complice nelle truffe. Ha una moglie affettuosa, tre figli piccoli abbastanza normali e una parentela fatta di donne intorno alla sua famiglia. La vita procede normale, senza grandi aspettative, in una realtà in cui non risulta nessuna contraddizione sociale. Ha una classica casa piena di mobilia un po’ cafona e una pescheria. Insomma, tutto normalissimo: fatta eccezione forse per questo suo bisogno di protagonismo che si sfoga senza ambizioni vestendosi da dark queen nelle feste familiari e nei matrimoni. A proposito quanto è lungo e inutile narrativamente il matrimonio iniziale e che gusto saprofita nel mostrarci i mostri di oggi. Un giorno Luciano, per fare contento sua figlia che piange, fa un provino per il Grande Fratello in un centro commerciale dell’Hinterland. E inaspettatamente viene chiamato a Roma per le selezioni ufficiali. Con la famiglia al completo giunge a Cinecittà – e qui c’è una voglia del regista di seguire l’immaginario di Fellini, sul genere Ginger e Fred ma ha anche il pudore di non camminare parallelo al grande Maestro e quindi non produce che un timido tentativo di imitazione abbozzato – e il buon Luciano resta affascinato e stupito da quel mondo così lontano dal suo. Torna convinto che sarà scelto per il programma e il quartiere lo innalza a figlio prodigo. Un caffè di qua, un saluto di là e il buon Luciano aspettando la telefonata da Roma decide di vendere la pescheria, fa già sogni di gloria per la vincita che otterrà. Ma la convocazione ritarda e lui inizia a fissarsi nell’attesa, fino a – novello Francesco d’Assisi – a regalare ciò che ha ai poveri per dimostrare che merita la redenzione televisiva. E di attesa in attesa dimentica la moglie, dimentica i figli e aspetta fiducioso anche quando la fiducia non può sussistere.
Un cast composto da quasi tutti attori non professionisti, ma tutti scelti forse a rappresentare se stessi e quindi credibili e convincenti. Gli sceneggiatori sono Maurizio Braucci, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso. La fotografia è del compianto Marco Onorato, il montaggio di Marco Spoletini. Ha ottenuto il Grand Prix al festival di Cannes 2012.