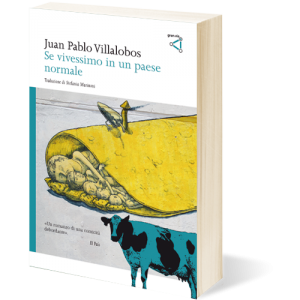(L’incipit del romanzo di Juan Pablo Villalobos, Se vivessimo in un paese normale, Gran Vía, 2014. – Lagos de Moreno, Messico, fine anni Ottanta: in una catapecchia alla periferia del paese vivono il tredicenne Oreste e la sua scombinata famiglia…)
 Professionisti dell’insulto
Professionisti dell’insulto
«Va’ a farti quella gran puttana di tua madre, bastardo! Vaffanculo!»
Sì, lo so che non è il modo migliore per iniziare, ma la mia storia e quella della mia famiglia sono piene di insulti. Se devo raccontare le cose per come sono successe veramente, dovrò scrivere un sacco di parolacce. Giuro che non c’è altro modo, perché la storia si svolge nel luogo in cui sono nato e cresciuto, a Lagos de Moreno, Altos de Jalisco, regione che per sua maggior disgrazia si trova in Messico.
Per chi non è mai stato da queste parti, lasciatemi dire una volta per tutte quattro cose sul mio paese: ci sono più mucche che persone, più charros che cavalli, più preti che mucche e alla gente piace credere all’esistenza di fantasmi, miracoli, navicelle spaziali, santi e roba simile.
«Che bastardi! Siete dei figli di puttana! Vogliamo vedere le vostre facce da coglioni!»
A gridare era mio padre, un professionista dell’insulto. Si esercitava a tutte le ore, ma la sua sessione intensiva, per la quale sembrava allenarsi tutto il giorno, si svolgeva tra le nove e le dieci, all’ora di cena. E del telegiornale. La routine serale era un mix esplosivo: quesadillas sul tavolo e politici in televisione.
«Ladri schifosi! Corrotti di merda!»
Ci credereste che mio padre era un professore di liceo?
Con quella boccuccia?
Con quella boccuccia.
Mia madre dal comal vigilava sullo stato della nazione, girando le tortillas e controllando il livello di collera di mio padre, benché intervenisse solo quando lo vedeva sull’orlo del collasso, quando cioè mio padre decideva di soffocarsi durante la sequenza di sproloqui dialettici con cui assisteva al telegiornale. Solo allora mamma si avvicinava per somministrargli sulla schiena qualche pacca ben assestata, perfezionata dall’esercizio quotidiano, finché mio padre non sputava il pezzo di quesadilla e perdeva quel colorito violaceo con cui adorava terrorizzarci. Pura stramaledetta minaccia di morte incompiuta.
«Su, calmati, che ti verrà qualcosa» lo rimproverava mia madre diagnosticandogli ulcere gastriche e colpi apoplettici, come se non fosse sufficiente rischiare di essere uccisi da una letale combinazione di mais industriale e formaggio fuso. Quindi cercava di farci passare lo spavento, di tranquillizzarci, esercitando la contraddizione materna.
«Lasciatelo, gli serve per sfogarsi».
Noi lo lasciavamo, soffocarsi e sfogarsi, perché in quel momento eravamo concentrati in una guerra fratricida per le quesadillas, una battaglia selvaggia per l’autoaffermazione dell’individuo: tentare di non morire di fame. Sulla tavola era tutto un arraffare del cavolo, sedici mani, con le loro ottanta dita, in lotta per accaparrarsi le tortillas. I contendenti erano i miei sei fratelli e mio papà, tutti tecnocrati altamente specializzati in strategie di sopravvivenza in famiglie numerose.
La battaglia si inaspriva quando mia madre annunciava che le quesadillas stavano per finire.
«Tocca a me!»
«È mia!»
«Tu ne hai già mangiate ottanta!»
«Non è vero».
«Chiudi il becco!»
«Ne ho prese solo tre».
«Silenzio! Lasciatemi ascoltare!» ci interrompeva mio padre, che preferiva gli insulti alla tele a quelli dal vivo.
Mia madre spegneva il fuoco, abbandonava il comal e ci dava una quesadilla a testa; questa era la sua visione dell’equità: ignorare gli squilibri del passato e distribuire le risorse in parti uguali. L’ambientazione di quelle battaglie quotidiane era casa nostra, una sorta di scatola delle scarpe con un coperchio-tetto in lamina di amianto. Vivevamo lì da quando i nostri genitori si erano sposati, cioè, ci vivevano loro, noialtri arrivammo dopo, espulsi dall’utero materno uno dopo l’altro, uno dopo l’altro, e infine, come se non bastasse, in coppia. La famiglia crebbe ma la casa non lo fece di conseguenza, per cui dovemmo stringere i materassi, spingerli contro le pareti, condividerli, per poterci stare tutti. Nonostante il passare degli anni, sembrava che la casa fosse ancora in costruzione, data l’assenza di finiture. La facciata e i muri perimetrali mostravano senza pudore i mattoni di cui erano fatti e che, volendo attenersi alle convenzioni sociali, sarebbero dovuti rimanere nascosti sotto uno strato di intonaco e pittura. Il pavimento era pronto per posarvi le mattonelle di ceramica, ma il processo non si era mai concluso. Identica situazione con le piastrelle, inesistenti nelle zone del bagno e della cucina a loro destinate. Sembrava che la nostra casa amasse andare in giro nuda, o quanto meno vestita leggera. Per non dilungarci, non entreremo nei dettagli sulla precarietà degli impianti della luce, dell’acqua e del gas, basti dire che c’erano cavi e tubi dappertutto e a volte era necessario prendere l’acqua dalla cisterna con un secchio legato a una corda.
Tutto questo accadeva più di venticinque anni fa, negli anni Ottanta, periodo durante il quale io passai dall’infanzia all’adolescenza e dall’adolescenza alla gioventù, allegramente condizionato da quella che alcuni definiscono visione provinciale del mondo, o sistema filosofico municipale. A quell’epoca pensavo, tra le altre cose, che tutte le persone e i fatti che apparivano in televisione non avessero niente a che vedere con noi e con il nostro paese, che le scene sullo schermo accadessero in un altro livello di realtà, una realtà emozionante che non aveva né avrebbe mai riguardato la nostra misera esistenza. Fino a quando una sera, all’ora delle quesadillas, ci capitò un’esperienza incredibile: il nostro paese era il protagonista del telegiornale. Si fece un silenzio così profondo che oltre al racconto dell’inviato si riusciva a sentire il lieve tocco delle nostre dita che sostenevano le tortillas nel loro cammino verso la bocca. Nemmeno davanti a una tale sorpresa smettemmo di mangiare; se pensate che sia impossibile inghiottire quesadillas in mezzo allo stupore generale significa che non siete cresciuti in una famiglia numerosa.
Lo schermo mostrava due fermo immagine alternati, mentre l’inviato continuava a ripetere che la sede del comune era stata occupata dai ribelli; la via principale del centro era bloccata da mucchi di spazzatura che il conduttore del telegiornale chiamava barricate e da un copertone che bruciava con l’inseparabile e arrivista colonna di fumo. In quel momento guardai dalla finestra della cucina di casa nostra, situata in cima al Colle di Merda, e confermai la versione del notiziario. Riuscivo a distinguere quattro, cinque nubi nere, sinistre e puzzolenti, che offendevano la vista della parrocchia illuminata. Menzione a parte merita la parrocchia, un obbrobrio in pietra rosa visibile da qualsiasi punto del paese e sede di un esercito di preti che ci obbligava a seguire il suo credo di arroganza e infelicità.
La notizia chiariva le conversazioni sussurrate tra i miei genitori, le insistenti telefonate dei colleghi di mio papà – Sono il professor Tizio, passami tuo padre. Sono il professor Caio, passami tuo padre. Se fossi stato più attento non avrei avuto bisogno di vedere il telegiornale per rendermi conto di quello che stava accadendo, ma d’altra parte vivevo nella fase suprema dell’egoismo: l’adolescenza. Alla fine mio padre interruppe il linciaggio nazionale dei nostri ribelli locali con dei gesti incazzati che gettarono in aria pezzetti di nixtamal.
«Cosa dovrebbero fare se li fregano alle cazzo di elezioni? Non vogliono perdere? E allora non organizzino queste elezioni di merda e piantiamola di farci prendere per il culo!»
Quello stesso giorno, un po’ più tardi, una camionetta con megafono passò lentamente davanti a casa nostra imponendoci a squarciagola un incomprensibile gesto di civismo, che consisteva nel rinunciare alla strada e nel rimanere chiusi in casa. Fino a nuovo avviso. Se avevano mandato l’ordine persino sul Colle di Merda, dove c’erano solo poche case separate l’una dall’altra da ampie estensioni di acacie spinose, voleva dire che eravamo nella merda.
Mia madre corse in cucina e tornò con gli occhi in lacrime e la voce tremante.
«Amore mio» annunciò a mio padre, e in casa questo inizio affettuoso serviva sempre da prologo alle catastrofi, «ci rimangono solo trentasette tortillas e ottocento grammi di formaggio».
Entrammo in una fase di razionamento delle quesadillas che finì col radicalizzare le posizioni politiche di tutti i componenti della famiglia. Conoscevamo alla perfezione le montagne russe dell’economia nazionale grazie allo spessore delle quesadillas che ci serviva mia madre. Avevamo persino creato delle categorie: quesadillas inflazionistiche, quesadillas normali, quesadillas della svalutazione e quesadillas dei poveri – citate in ordine, dalla più opulenta alla più misera. Le quesadillas inflazionistiche erano belle grosse per evitare che si guastasse tutto il formaggio comprato da mia madre, in preda al panico di fronte all’annuncio di un nuovo aumento del prezzo degli alimentari e al pericolo tangibile che il conto della spesa passasse dai milioni ai miliardi di pesos. Le quesadillas normali erano quelle che avremmo mangiato tutti i giorni se fossimo vissuti in un Paese normale, ma se fossimo stati in un Paese normale non avremmo mangiato quesadillas, per cui le chiamavamo anche quesadillas impossibili. Le quesadillas della svalutazione perdevano sostanza per ragioni psicologiche, più che economiche, erano le quesadillas della depressione cronica nazionale – e le più comuni in casa dei miei genitori. E infine c’erano le quesadillas dei poveri, in cui la presenza del formaggio era letteraria: le aprivi e al posto del formaggio fuso mia madre aveva scritto la parola “formaggio” sulla superficie della tortilla. Quello che non avevamo ancora conosciuto era la minaccia della privazione quesadillesca.
Mia madre, che in vita sua non aveva mai espresso un giudizio politico, si mise dalla parte del governo pretendendo l’annientamento dei ribelli e l’immediata restaurazione del diritto umano al cibo. Mio padre sosteneva lo stoicismo e replicava che la dignità non si baratta con tre quesadillas.
«Tre quesadillas?» contrattaccava mia madre, istigata all’ironia femminista dalla disperazione, «come si vede che non fai niente! Questa casa ha bisogno come minimo di cinquanta quesadillas al giorno»…