È arrivato tardi il teatro di Thomas Bernhard in Italia, sulla scia delle prime traduzioni di novelle e romanzi e di una certa fama mediatica dell’autore come misantropo e nichilista. Nel 1982, dopo la pubblicazione dell’Italiano da Guanda e di Perturbamento da Adelphi, il Gruppo della Rocca mette in scena La forza dell’abitudine (del 1974), calcando sui lati clowneschi di un testo che raffigura uno degli interni soffocanti, intinti nella rabbia del fallimento, dell’autore austriaco. Caribaldi, direttore di circo insoddisfatto delle misere, ignobili piazze dove è costretto a esibirsi, cerca di fare eseguire ai suoi recalcitranti sottoposti – un giocoliere, un domatore, un buffone e la nipote – il quintetto La trota di Schubert. Tutto si svolge in un’asfittica roulotte, uno dei luoghi spogli che spesso caratterizzano i drammi dello scrittore (altrove avremo grandi stanzoni, finestre imponenti, volte che pesano sulla solitudine e sull’afasia umana di personaggi nascosti dietro fiumi di parole, inflitte come tormenti ai disgraziati complici che si sono condannanti a vivere al loro fianco). Caribaldi è una delle figure tipiche di un autore che lavora, come è stato più volte sottolineato, sulla ripetizione e sulla variazione sul tema, creando gorghi di ossessione che tutto travolgono, fino a devastanti finali, spesso a sorpresa; è consumato dal mal di schiena, con una gamba di legno, si affida a un’altra arte, la musica, quella classica, per sviluppare la concentrazione. Ma il suo obiettivo di eseguire alla perfezione La trota, un esercizio imposto da perlomeno quindici anni ai suoi artisti, non raggiunge mai lo scopo; e lo vediamo in continuazione trascinarsi sul pavimento in cerca della pece greca per rendere scorrevole l’archetto del violoncello, che sempre di nuovo cade e si perde.
Sono storpi, paralitici, ciechi o precipitanti verso la cecità o la sordità i protagonisti delle opere teatrali di Bernhard. Molto spesso sono vecchi, impegnati a difendersi dal gelo, ricoprendosi, avvolgendosi in panni o coperte pesanti. Oppure sono folli, al grado della mania, della fissazione, o del ricovero in manicomio, come il Voss-Ludwig che torna a casa dallo Steinhof su insistenza della sorella Dene in Ritter, Dene, Voss; o come il Kant affetto da glaucoma che va a curarsi in America portando, in cambio, la luce della sua filosofia, affidata per lo più a un pappagallo che tutto ha memorizzato e che erompe spesso nel grido “Imperativo imperativo imperativo”, in Immanuel Kant: allo sbarco del transatlantico, sul quale si evoca più volte il naufragio del Titanic, il filosofo troverà a accoglierlo medici e infermieri del manicomio di New York. Le donne svolgono molte volte la funzione di introdurre il personaggio maschile, che entra in scena in un secondo momento, come nel Presidente, in Prima della pensione, in Ritter, Dene, Voss; oppure evocano l’ombra dell’uomo assente, come il marito morto di Alla meta, padrone di fabbriche che ha dato sicurezza economica ma non esistenziale alla moglie, o come la governante Frau Zittel di Heldenplatz, che ricostruisce per frammenti, come un puzzle, la personalità e il suicidio del professor Josef Schuster, ebreo dal nome poco israelita che significa “calzolaio”, uno che si è dovuto rifare più volte le scarpe per sfuggire alle persecuzioni razziali.

La malattia rode spesso anche le cose, come il bosco del terzo testo di successo del nostro autore, La brigata dei cacciatori, una grande foresta che deve essere abbattuta, mentre il suo proprietario, il generale, si sta spegnendo per una malattia inguaribile di cui nulla (apparentemente) sa.
Siamo in un mondo terminale, i cui protagonisti sono accigliati tiranni, che fanno il vuoto intorno a sé, in preda a manie e ossessioni, chiusi in ambienti oppressivi, in un “finale di partita” dove non scorgiamo nessun segno di amore, di passione, di affetti neppure come rimpianto, ma dove ascoltiamo una continua querimonia contro un mondo “ignobile”, “infame”, etimologicamnte che non si può nominare, contro il quale ci si scaglia senza risparmiare un solo fiato di una voce svuotata per sovrabbondanza. Siamo oltre Beckett, annullati dall’eccesso di parole sparate contro gli altri, come una diffamazione dell’esistenza e della stessa possibilità di conoscenza attraverso il linguaggio. Siamo contro l’amato Wittgenstein, e il consiglio finale del suo Tractatus: “Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere”. Siamo in una musica atonale che prorompe da una lussureggiante sinfonia mahleriana.
Il teatro di Bernhard in Italia
La forza dell’abitudine apre la strada al teatro di Bernhard in Italia. Esso viene rilanciato dal primo volume dei testi pubblicato nello stesso 1982 da Ubulibri, con gli storpi cinici o vittime di Una festa per Boris (1970), con La forza dell’abitudine (1974), con il vecchio bilioso odiatore dell’umanità di Il riformatore del mondo (1980). A rinforzare l’idea che l’autore sia guardato come un “caso”, segnaliamo il fatto che il volume non contiene un’introduzione che presenti lo scrittore e il ruolo del suo teatro all’interno di un’opera composita, sviluppatasi già con notevoli risultati tra la poesia e la narrativa, ma si chiude con una lunga intervista che cerca di mettere in risalto gli aspetti di misantropia e di nichilismo dell’uomo. Ubulibri pubblicherà la maggior parte dei restanti testi teatrali in altri quattro volumi: il secondo, del 1986, comprende La brigata dei cacciatori (1974), Minetti (1976) e Alla meta (1981); il terzo (1990) è costituito da L’apparenza inganna (1983), Ritter, Dene, Voss (1986) e Semplicemente complicato (1986); il quarto, nel 1999, torna a L’ignorante e il folle (1972), a Immanuel Kant (1978) e a Prima della pensione (1979); la pubblicazione si ferma con l’uscita, nel 2004, di Il presidente (1975), Il teatrante (1984) e Elisabetta II (1987), lasciando fuori Die Berühmten (Le celebrità, 1976), Über allen Gipfeln ist Ruh (Su tutte le vette è pace, 1982) e Heldenplatz (Piazza degli eroi, 1988), edito da Garzanti nel 1992, testamento dell’autore austriaco (morto il 12 febbraio del 1989), il testo più “politico” o perlomeno quello che più esplicitamente legge le tendenze antisemitiche e neonaziste dei tempi, già però avvertite come una minaccia, in altri modi, in opere precedenti.
Intanto, da Minetti in poi, in Italia spesso le messe in scena precedono la pubblicazione dei testi. All’inizio sono solide compagnie tradizionali, spesso di zone di confine, a introdurlo: così Minetti porta, nel 1984, la firma di Marco Bernardi e la sigla dello Stabile di Bolzano; Alla meta ha la regia di Piero Maccarinelli, che continuerà a frequentare Bernhard con altri titoli. Questo teatro di grandi vecchi avrà interpreti indimenticabili in Roberto Herlitzka (il grande industriale Herrestein, senza gambe e in carrozzella, di Elisabetta II, ma anche altri personaggi, fino ai recenti Il soccombente e Minetti) e in Gianrico Tedeschi (Il riformatore del mondo e Minetti). Ma molti attori e registi di diverse generazioni e tendenze si misurano con Bernhard, da Alessandro Gassmann (La forza dell’abitudine) a Renato Sarti (Ritter, Dene, Voss) a Paolo Graziosi (Il teatrante) a Umberto Orsini (Il nipote di Wittgenstein) a Franca Nuti (Alla meta) a Micaela Esdra (ancora Alla meta) a Franco Branciaroli (Il teatrante). Mostrano interesse per Bernhard anche voci più “sperimentali” come Renzo Martinelli di Teatro i, con un Prima della pensione chiuso tra sipari, in una teca di plexiglas, con l’idea che la verità si mette in scena ma non si lascia scorgere, o come Teatrino Giullare con Alla meta. Archivio Zeta, una compagnia che sui monti tra Emilia e Toscana fa dell’indipendenza la sua bandiera, ha messo in scena Il presidente alla ricerca dei perturbamenti politici contenuti nei fiumi di parole di un testo scritto, in modo assolutamente non cronachistico, negli anni del terrorismo; alla fine del 2015 Pietro Babina ha firmato la regia di un Ritter, Dene, Voss con i colori acidi di un’esposizone di arte contemporanea.
Nel 1990 escono da Ubulibri i Dramoletti, brevi pièce all’acido cloridrico sul mondo teatrale, culturale e politico viennese e tedesco: i tre che hanno per protagonista il regista Claus Peymann, che ha firmato le prime di molte opere teatrali del nostro autore, a Stoccarda, poi a Bochum, infine a Vienna, vengono invece portati in scena nello stesso anno da Carlo Cecchi con Gianfelice Imparato, con il titolo della seconda pièce, che ha come personaggio lo stesso Bernhard: Claus Peymann compra un paio di pantaloni e viene a mangiare con me. Il critico Franco Quadri scrive di questo spettacolo (“la Repubblica”, 7 novembre 1990):
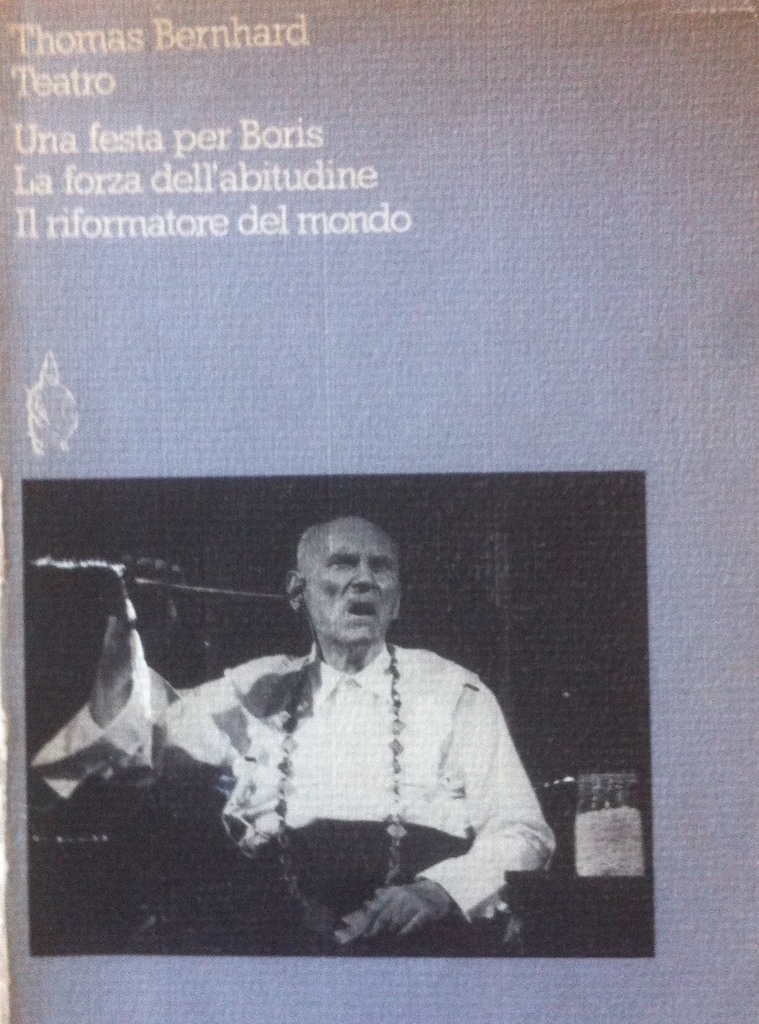
Lo spunto iperrealistico che sta sotto al paradosso gli serve [a Cecchi] a costruire su quelle basi di documentata verità una figura immaginaria, al livello dei protagonisti di Minetti o del Teatrante. Mentre il dramoletto si fa commedia vera e propria, questo Peymann oltrepassa il modello e il suo mondo si sottrae alle strettoie dell’argomento teatrale, in un contesto che Titina Maselli rende fiabesco con pochi elementi scenici allusivi. Dal buio indistinto di Bochum, ci ritroviamo a Vienna grazie a un lunghissimo divano, a vetrine in plexiglas galleggianti nell’aria, a un paesaggio punteggiato di lumini dietro all’asse altalenante su cui i due teatranti addentano un sandwich e assaporano il destino, coi visi trascolorati dai riflessi d’oro del tramonto.
Due anni dopo, Cecchi interpreterà Ritter, Dene, Voss, con Marina Confalone e Anna Bonaiuto.
Anche le opere letterarie arrivano in forte ritardo da noi e sfalsate rispetto all’uscita dei testi teatrali. Per citare solo le ultime due, pubblicate entrambe da Adelphi, Antichi maestri del 1985 esce nel 1992 e Estinzione, pubblicato nel 1986 ma scritto qualche anno prima, come Heldenplatz un testamento, vede la luce in italiano solo nel 1996. Così che tardi, compiutamente solo negli anni 2000, riusciamo a cogliere quella fitta rete di rimandi, intrecci, variazioni che esistono tra le diverse parti di un’opera che assume comunque sempre la teatralità, la messa in scena, come chiave di lettura del mondo.
 Tutto è teatro?
Tutto è teatro?
In Bernhard precipitiamo di fronte a una riesumazione del “Gran teatro del mondo” di barocca memoria, specchio scenico, memoriale, di tutte le passioni, le ambizioni, le insanie della vita, concentrate in quello spazio-mondo che è il palcoscenico: nel nostro caso macchina che gira a vuoto, su se stessa, destinata a non essere compresa, spettacolo di marionette kleistiane, che aspirano alla perfezione dell’assenza di pensiero e più spesso, in una ripetizione senz’anima, precipitano nel burrone dell’ingorgo filosofico, dell’impossibilità di dimostrazione, di esperienza e conoscenza. Bruscon, l’attore dal nome italiano protagonista del Teatrante, lo chiarisce una volta per tutte, nella sua tantalica impresa di rappresentare uno spettacolo sulla Storia, da Cesare a Hitler alla bomba atomica, dramma che contenga tutti i drammi del mondo, che si trova a offrire solo a infimi pubblici “ottusi” (uno degli aggettivi preferiti dall’autore): “recitiamo per tutta la vita / e nessuno che ci capisca / Carcere teatrale a vita / senza la benché minima speranza di grazia / Eppure non arrendersi mai / il teatro è una prigione / con decine di migliaia di detenuti / che non hanno nessuna speranza di essere graziati / Certa è solo la pena di morte / per tutti”. Ha pensato spesso di servire la birra “come un oste”, e essere felice, e invece “sono diventato attore /e sono andato volontariamente / all’ergastolo” (Teatro V, p.187).
La diffamazione dell’arte, ricorrente, diventa più in generale metafora di un essere umano senza centro, perso, lontano dal pensiero, incapace di andare alla radice delle cose, pronto a seguire ogni sorta di simulacri e di interessi ingannevoli. In realtà, la forza di questo teatro eccessivo, filosofico, dimostrativo senza didascalismi, in cui i temi si ripresentano ossessivamente, è quella di costituire un ragionamento sul mondo contemporaneo di assoluto rigore. Intinto forse nella malinconia per modi di esistenza e valori svaniti (la tradizione? l’Austria felix? la società borghese intellettuale della grande Vienna primi novecento, con i continui riferimenti a Wittgenstein, all’intellighenzia ebraica, alla psicanalisi?). Nel teatro e nell’opera letteraria di Bernhard urge il disagio per un presente senza certezze, senza basi, dove ogni cosa può sfumare in un’altra, dove “il socialismo è peggiore del nazismo”, come diranno vari suoi personaggi, dove il nazismo non è mai morto, dove l’assalto alla natura, alle città, ai modi di convivere è continuo e mosso dall’interesse speculativo, dalla mediocrità, dalla furiosa fede solo nell’apparenza, spesso truffaldina.
“Ciò che conta nella Ruota della storia / è la parola” dice ancora Bruscon. E aggiunge: “i critici si limitano /a guardare ottusamente / e non sentono più niente. Noi diamo il massimo / ma loro non lo capiscono […] / Recitiamo per tutta una vita / e nessuno che ci capisca”. Attore come condannato e come “farmaco”, capro espiatorio capace di rivelare la società a se stessa. La sua finzione.
Gran teatro del mondo e teatro dei fallimenti. Analisi delle strutture profonde della contemporaneità in versi veloci, ossessivi, contraddittori, ritornanti con improvvisi o lentissimi sviluppi come gli elementi di una sonata classica (Bernhard fu musicista e fu influenzato nella sua scrittura dalla musica), senza punteggiatura, con un incalzare che sembra sovrastare l’azione scenica. Flatus voci. Tranne poi rendersi conto che i tanti personaggi quasi muti, i servitori che assecondano il sadismo di padroni gonfi di odio per il mondo, perfette vittime consenzienti, in realtà sono loro, spesso, a spingere i loro dominatori avanti nel delirio. I silenzi, le azioni, le pause, i rumori (il tuono che incombe sul finale del Teatrante, prima dell’incendio finale che annullerà tutti gli sforzi), i tic, gli scatti d’ira o di vera e propria pazzia sono una grana fisica altrettanto importante dell’inarrestabile profluvio verbale. Basta vedere ciò che registi come il polacco Krystian Lupa sono riusciti a trarre dal gioco di pause, di silenzi, di sguardi e dalle stesse disperate tirate di un testo come Ritter, Dene Voss; per esempio nel finale, quando Ludwig, sulle note della Marcia funebre dell’Eroica di Beethoven, rovescia furiosamente i quadri di parenti e antenati che opprimono il salotto dove le sorelle lo hanno accudito e contrastato in una vera e propria scena analitica dell’ipocrisia sociale e della follia familiare.
Sotto la conversazione di Bernhard, inesauribile, travolgente, maniaca, urge la repressione dei corpi, la divisione tra desiderio e convenzioni sociali, tra viversi e essere, tra scienza, filosofia, conoscenza e apparenza. La chiacchiera fissata su carta aspetta registi e attori di valore, non convenzionali, che possano restituire profondità e contraddittorietà a un dissolvimento senza fine, a un continuo slittamento nell’afasia, nella cecità, nel dolore, nello smarrimento.

Bernhard in più opere diffama il teatro, giocando a distruggerlo, perché ne riconosce l’impotenza, strettamente intrecciata alle sue virtù rivelatrici. “Io odio il teatro anima e corpo / e lo detesto da morire / per me è la cosa più ripugnante che ci sia / ma proprio per questo mi ci sono dedicato / Io odio il teatro / e tutto quello che ha a che fare con il teatro / e mi ci sono dedicato / lei ci si è dedicato per amore / io mi ci sono dedicato per odio […] io detesto il teatro/ esso mi attrae / perché lo detesto / lei ama gli attori / io li detesto / Lei ama il pubblico / io lo detesto / Lei ama il palcoscenico / io lo detesto / detesto / tutto ciò che lei ama / amo / tutto ciò che lei detesta / io amo quel che lei detesta”. Quasi un mantra, è quello con cui Bernhard si rivolge al suo regista fidato in Claus Peymann compra un paio di pantaloni e viene a mangiare con me (p. 27-28), un dramoletto (dramma da consumare velocemente, come un’omelette: l’aspetto comico, sarcastico, umoristico è una delle tinte portanti dei labirinti bernhardiani; una vertigine in cui l’accumulo di comicità si trasforma in inquietudine, in tragedia, e in cui le tragedie vengono portate al livello della contemporaneità più stupida attraverso umori dissacranti). Una dichiarazione di poetica, potremmo dire, se non fosse evidente, da altre opere, e principalmente da quelle “autobiografiche”, come il Thomas Bernhard personaggio sia altro dal Thomas Bernhard reale, e come le identità non siano mai sicure, sempre traballanti in giochi di scatole cinesi, in baracconi di specchi che come nella Signora di Shangai di Orson Welles non permettono di capire dove sia la persona reale (ma persona vuol dire in latino maschera), finché, per accumulo o per esplosione, l’effetto di tutte quelle superfici riflettenti non generi un incendio, non vada a creare uno specchio ustorio di ogni certezza.
I romanzi procedono così: un personaggio racconta qualcosa che ha saputo da un altro personaggio, che riferisce a sua volta qualcosa imparato da altri, e così via; una storia viene ricostruita attraverso confidenze, memorie, diari, rendiconti incompleti, inattendibili, mutili, affidati a supporti labili. È stata ripetuta all’estremo la citazione, da un documentario biografico, in cui l’autore racconta il proprio metodo narrativo come un palcoscenico buio che all’improvviso si accende mostrando personaggi, in uno spazio sempre artificioso che ha per scopo arrivare, attraverso la luce, a chiarezza o iperchiarezza. Parole in corsivo dell’autore: con quell’inquietante “iperchiarezza”, che rende gli “accadimenti di natura esteriore e interiore” particolarmente evidenti, più che evidenti, proprio grazie al loro mettersi in scena (e quindi simularsi, e in un certo senso celarsi, mettersi in maschera).
Niente è certo. Il Bernhard Minetti dell’omonima pièce, interpretato da Bernhard Minetti, non è il vero Bernhard Minetti: è un attore emarginato, che dopo trent’anni dovrebbe tornare al palcoscenico, nel ruolo del vecchio che trova la saggezza estrema attraverso la perdita e la follia, ossia re Lear. Naturalmente non ce la farà: morirà seppellito dalla neve al termine del suo delirio di fine anno, su una panchina, come un barbone, indossando la maschera di Lear fatta – dice lui – da Ensor. Ritter, Dene, Voss contiene nel titolo i cognomi degli attori del primo allestimento (con la regia di Peymann): ma scarta da un’altra parte, in una ricca famiglia viennese che riporta in scena Ludwig Wittgenstein, reso ospite del manicomio come il Paul del Nipote di Wittgenstein. Immanuel Kant viaggia verso l’America su un transatlantico. Nel raccontino Goethe schiatta!, portato in scena con un altro gioco di specchi dal critico Renato Palazzi, Goethe morente vuole conoscere Wittgenstein, che considera suo erede. E via spostando, tra acronie, intrecci indistricabili tra arte e vita, tra impossibilità di aderire ai ruoli e sgretolamenti di maschere. Come quella dei buoni democratici tedeschi, che rivelano il nazismo profondo, in Prima della pensione, in cui un giudice riabilitato nella nuova Germania celebra con le sorelle i compleanni di Himmler, indossando l’uniforme giovanile delle SS; come i cinguettanti giudici profondamente nazisti del dramoletto Gelati, uccisi a sorpresa; come in Heldenplatz, il lavoro che porta più esplicitamente alla luce un’inquietudine per le nuove derive razziste xenofobe antisemite dell’Europa negli anni in cui Haider e Bossi stavano appena facendo i primi passi, ancora non era caduto il Muro di Berlino e non era scoppiata la guerra nella ex Iugoslavia (e si parla molto, come già in Estinzione, scritto nel 1981-82, della politica come affarismo, dieci anni prima del nostro “Mani pulite”).

Attraverso l’esagerazione (e la diffamazione), Berhnard si cala totalmente nella intrattabile materia della storia. Sotto l’eccesso di parole, sotto le circonlocuzioni di frasi simili al tracciato di un labirinto che riporta sempre allo stesso punto – o comunque lontano dall’uscita – urgono i corpi e uno sguardo che perfora la cronaca, per andare a fondo. Oltre ogni tipo di teatro politico.
Nella tirata contro i socialisti ottusi e collusi di Heldenplatz – non diversi dai clericali e dai nazionalsocialisti – conclude che in Austria oggi (fine anni ottanta) è peggio “che cinquant’anni fa”. Il nazismo ha una nuova veste, ma la stessa ferocia basata sull’odio del diverso, sulla protezione della piccola patria, sulla consorteria, sul familismo amorale diremmo noi italiani, sull’antisemitismo. Bernhard ci parla del nuovo fascismo globalizzato dell’omologazione, del consenso, quello dei mass media e prima ancora della società di massa. Caduta e catastrofe sono in agguato, e poco possono la cultura, la scienza, la musica, e le arti. E pochissimo gli attori e gli “artisti”, ossia acrobati, giocolieri e simili, quelli che hanno fatto della precisione e dell’esercizio straordinario la loro radicale differenza.
Quotidianamente sono in agguato l’errore, il fallimento, lo slittamento, lo slabbramento, l’imperfetta sovrapposizione tra apparenza e verità, fino a che questa non diventi indecidibile e sia seppellita sotto un fiume di parole, di idiosincrasie. Slitta la relazione tra personaggio e interprete, tra immagine pensiero e cosa, tra fenomeno e sostanza. Tra linguaggio e mondo, notava il filosofo Aldo Gargani in La frase infinita. Thomas Bernhard e la cultura austriaca (1990). Con un senso di vertigine, il nostro autore scrive, nel raccontino che dà il titolo alla raccolta L’imitatore di voci (1978; edizione italiana Adelphi, 1987, p. 11):
Per noi, sul Kahlenberg, l’imitatore di voci ha effettivamente imitato altre voci, più o meno celebri, completamente diverse da quelle imitate per la Società di Chirurgia. Abbiamo anche potuto esprimere dei desideri, e l’imitatore di voci ci ha accontentati con la massima premura. Quando però gli abbiamo fatto la proposta di chiudere il programma imitando la propria voce, lui ha detto che non ne era capace.
Terrificare il pubblico
L’attore è personaggio centrale di questa costruzione (o decostruzione). Minetti ritorna come interprete di vari testi, con la sua presenza scenica che riempie gli squallidi stanzoni vuoti bernhardiani, come in Semplicemente complicato, approdato a Parma nel 1988. Ritorna, come figura ideale, vecchio, spigoloso, mobilissimo, in La forza dell’abitudine, in L’apparenza inganna, in Il riformatore del mondo. L’attore è qualcuno che interpreta, che commenta qualcun altro; una voce che risponde a un’altra voce; una persona che ne evoca un’altra. È qualcuno che con strazio cerca una verità, per non arrivarci. In Minetti lancia contro lo spettatore sentenze che illustrano la sua funzione, una delle sue funzioni, perché negli specchi bernhardiani l’attore, l’interprete, sarà anche marionetta, essere umano esasperato dalla necessità della prestazione, gigione destinato alla solitudine e allo scacco. Il mondo pretende di divertirsi e invece va turbato dal teatro; il pubblico va terrificato dalla presenza dell’attore, sentiamo dire in Minetti: “ prima lo deve raggirare / e poi lo deve terrificare / I grandi attori hanno sempre terrificato il loro pubblico / poi lo hanno raggirato / poi lo hanno terrificato / attratto nella trappola della storia / nella trappola dello spirito / nella trappola dei sentimenti / attratto nella trappola / e terrificato /il peggior nemico dell’attore / è il suo pubblico / quando lo sa / si esalta nella sua arte / ogni istante l’attore deve dirsi / ora il pubblico s’avventa sulla scena / È in questo stato che deve recitare / contro il pubblico / contro i diritti umani capisci” (Teatro II, pp. 115-116). E più avanti, dopo aver riflettuto che gli uomini esistono solo per ingannarsi a vicenda e che “Può darsi / che tutto / sia una mistificazione”, afferma che “un artista è autentico artista / quando è completamente pazzo / quando si è precipitato nella pazzia / incondizionatamente / facendone il proprio metodo” (p.118). Amleto. Re Lear, che dalla pazzia arriva alla desolata cognizione del mondo. La corona di Riccardo III, infitta dolorosamente sul capo del vecchio Minetti di Semplicemente complicato. Ma anche la follia, in questo gioco serissimo che mette sottosopra tutte le certezze, non è un rimedio.

Tra biografia e finzione
I personaggi fittizi non riescono mai del tutto a ancorarsi a attori e individui (anche Peymann e Bernhard, in questo “Gran teatro del teatro”). La recita può essere un nascondersi per navigare come pesci nell’acqua del mondo, come il giudice nazista di Prima della pensione, o un modo per rendere appena più sopportabile la malattia di esistere. L’attore è teatro e ha bisogno di essere guardato. Come le due sorelle di Ritter, Dene, Voss che nella vita fanno le attrici, senza troppo impegno, recitando solo nelle parti che gradiscono, perché grazie alle ricchezze familiari possiedono comunque il 51 per cento del teatro: esse recitano soprattutto nella scena domestica, l’amore per il fratello l’una, la voglia di fuga dall’ipocrisia e dalla routine borghese, mai portata a termine, l’altra. Ma in questi scenari, Bernhard inserisce i veleni di uno svelamento che continuamente torna a mettersi in maschera. Come, per esempio, in questo brano di A colpi d’ascia, romanzo del 1984, pubblicato in Italia da Adelphi nel 1990 (p. 76):
Inspirai profondamente, dicendo poi a me stesso, ma in verità in modo tale che le persone della sala da musica non potevano non sentirmi, tu hai vissuto solamente una vita recitata, non una vita vera, solo un’esistenza recitata, non un’esistenza effettiva, tutto ciò che ti riguarda e tutto ciò che sei è sempre stato soltanto una recita, mai qualcosa di effettivo e di reale.

Una confessione, a voce alta: perché gli altri possano sentirla. Teatrale.
Qui sta la dimensione storica meno effimera di Bernhard: nella trasposizione continua, nei suoi attori quasi personaggi e quasi persone, nei suoi artisti folli e nei loro fallimenti, nelle architetture utopiche, masochistiche, e nei trattati impossibili da scrivere dei romanzi (che ritornano come echi nel teatro), nell’accumulo di salottiera stupidità che esplode sotto le pistolettate di un attentatore, sotto il divampare della malattia, sotto la coscienza che non c’è una meta ma che la noia si sposta da un non-luogo a un altro non-luogo (Alla meta, che ha avuto una notevole, originale messa in scena di Teatrino giullare, con manichini indossati dagli attori, a sottolinearne gli aspetti “marionettistici”), nell’oscillare tra tragedia e commedia, tra errore e orrore, tra biografia e finzione, tra verità e invenzione. Alla fine questo è lo specchio ustorio che si materializza dal baraccone del luna park, per bruciare tempi di crisi, di insostanzialità, di apparenza, di spettacolo che svia dal potere del potere reale, dalla dittatura della materia (economica, politica, della merce da vendere sempre e comunque e da eleggere a metro di valutazione del mondo e dei suoi rapporti), una materia che si fa segno infinitamente scambiabile, immateriale e pervasivo, ma saldamente, brutalmente, nelle mani di pochi.
La voci dell’Anschluss
Per uscire dall’illusione, Bernhard architetta inganni, ciarlatanerie, esibizioni, irritazioni, diffamazioni, in fughe infinite di parole, con sovrapposizioni, rimandi, confusioni tra apparenza e realtà, in costruzioni incombenti che spesso neanche l’arte, fragile, destinata allo scacco, può redimere. Monumenti al presente che franano spesso in poderosi, invadenti, frastornanti finali. Come in Heldenpaltz, la storia di un professore ebreo fuggito al nazismo e ritornato dopo la guerra a Vienna. Che non riesce a sopravvivere al nuovo antisemitismo, alla nuova ondata di odio per il diverso, e si suicida.
Il testo scatenò una battaglia alla sua prima rappresentazione, nel novembre del 1988, pochi mesi prima della morte dello scrittore, tra una folla che assediava il Burgtheater accusando l’autore di denigrare la patria, e i sostenitori di Bernhard che tributarono al dramma mezz’ora di applausi. Non mostra il protagonista, già defunto: lo racconta in assenza, attraverso il suo vestito rimasto integro dopo il volo dalla finestra, attraverso le sue ossessioni e quelle di chi è rimasto. Rivelando, anche in questo caso, sotto le parole, una spessa grana fisica: il professore si è ucciso anche a causa delle voci che ossessionano la moglie, le urla plaudenti al discorso dell’Anschluss dell’Austria alla Germania nazista sulla Heldenplatz nel 1938.
Nel finale quelle voci prendono consistenza quasi di corpi, di armi che minacciano di dilaniare, ancora: si aprono le finestre durante un pranzo molto borghese nell’appartamento in via di smantellamento sulla famosa piazza viennese, e salgono le urla dei buoni benpensanti austriaci inneggianti a Hitler, all’uomo del destino, del riscatto, della salvezza. I personaggi rimangono annichiliti da questo frastuono che traduce il ronzio impaurito di tutta la pièce.
 Un’altra “diffamazione” dell’Austria. Ma Bernhard, come il suo imitatore di voci, come il suo pseudo-Minetti interpretato dal vero Minetti, era già altrove. Nelle parole del testamento: mai più le mie opere pubblicate, rappresentate in questa terra. Nelle rampogne, affidate a uno dei suoi personaggi, contro la fotografia, considerata metafora del tradimento della realtà attuata tramite il moltiplicarsi del dominio dell’immagine, “mania meschina da cui è contagiato a poco a poco l’intero genere umano, perché della deformazione e della perversità è non solo innamorato, ma addirittura pazzo e col tempo, a forza di fotografare, scambia in effetti il mondo deformato e perverso per l’unico vero” (Estinzione, p. 27). Nel grido contro le menzogne di stato, contro le città, contro lo sfacelo della natura. Contro la follia del fissare e documentare. Contro l’inefficace potere intimidatorio dell’arte, che non vale l’amore (tormentato, tormentante) per un essere umano (Antichi maestri, 1985). Incapace di sostituire la debolezza dei corpi reali, dei ricordi, del dolore, dei fallimenti.
Un’altra “diffamazione” dell’Austria. Ma Bernhard, come il suo imitatore di voci, come il suo pseudo-Minetti interpretato dal vero Minetti, era già altrove. Nelle parole del testamento: mai più le mie opere pubblicate, rappresentate in questa terra. Nelle rampogne, affidate a uno dei suoi personaggi, contro la fotografia, considerata metafora del tradimento della realtà attuata tramite il moltiplicarsi del dominio dell’immagine, “mania meschina da cui è contagiato a poco a poco l’intero genere umano, perché della deformazione e della perversità è non solo innamorato, ma addirittura pazzo e col tempo, a forza di fotografare, scambia in effetti il mondo deformato e perverso per l’unico vero” (Estinzione, p. 27). Nel grido contro le menzogne di stato, contro le città, contro lo sfacelo della natura. Contro la follia del fissare e documentare. Contro l’inefficace potere intimidatorio dell’arte, che non vale l’amore (tormentato, tormentante) per un essere umano (Antichi maestri, 1985). Incapace di sostituire la debolezza dei corpi reali, dei ricordi, del dolore, dei fallimenti.
Fantasmi
Sono simili a morti che ritornano i personaggi teatrali di Bernhard, come nel grande teatro classico. I suoi testi (commedie? tragedie?) sono danze di spettri affidate a attori vecchi, sull’orlo della pensione, che male si reggono sulle gambe, che non vedono o non sentono, decrepiti e ciechi come tempi nei quali il troppo parlare di gioventù maschera la dittatura di un passato che non cede le armi, ma è pronto a rimbellettarsi e a mordere. Feroce.
Questo testo è una versione rivista e aggiornata di quello pubblicato su “Lo straniero”, anno XVIII, numero 174/175, dicembre 2014 / gennaio 2015.
– See more at: http://www.doppiozero.com/materiali/il-teatro-di-thomas-bernhard-una-diffamazione#sthash.fX3CrKe5.dpuf

