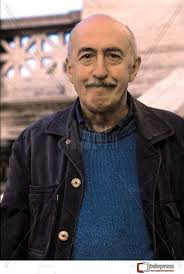La Cinémathèque française, dopo avergli dedicato una retrospettiva nel 2019 e coordinato il restauro dei suoi film, invita alla scoperta della sua filmografia e delle sue numerose vite grazie a una piccola rassegna on-line sulla nuova piattaforma VOD “Henri”. Prima della messa in onda dei suoi cortometraggi d’esordio (Akvareli, Aprili, Tudzhi), lo scorso 12 aprile, Domenica di Pasqua, la Cinémathèque ha presentato un film misterioso e raro che Iosseliani realizzò nel 1988 a Castelnuovo dell’Abate per la televisione francese (La Sept – France 3).

Un petit monastère en Toscane non è un documentario. Non è un reportage nel senso di to report, riportare, riferire un ritaglio di realtà. È «l’aura delle cose che ho amato e conosciuto», dirà Iosseliani dieci anni più tardi, nel 1998, al termine di una proiezione del film al Jeu de Paume di Parigi. «Avete visto l’immagine di un paese, di un certo mondo che sento, e lo stesso villaggio filmato da qualcun altro vi farebbe pensare a tutt’altra cosa». D’altronde lui, l’ha ripetuto spesso, al documentario non ci crede. Il cinema è innanzitutto una questione di sguardo. Ognuno di noi osserva, ama, conosce a modo suo. Quello che Iosseliani volse su Castelnuovo dell’Abate e sul suo piccolo monastero fu proprio lo sguardo di un innamorato. Uno di quegli amanti che, costretti a partire, promettono di ritrovarsi tra vent’anni. Così leggiamo infatti in un cartello dei titoli di coda: «Qui finisce la prima parte del film, il seguito sarà realizzato tra una ventina d’anni in questo stesso posto e con gli stessi personaggi, se tutto va bene». Galeotta la didascalia, il film si presenta quindi come parte prima di un film in divenire.
Sono ormai trentadue gli anni trascorsi dall’inverno in cui Iosseliani arrivò in Toscana per osservare il ritiro di cinque monaci agostiniani francesi. Avrebbe dovuto farvi ritorno dodici anni fa. Oramai tradita, quella promessa perpetua il film nel suo essere prima parte di un’opera incompiuta. Chissà se un giorno, chissà quando, Otar l’innamorato vi farà ritorno. Chissà se “tutto sarà andato bene” e la seconda parte del film potrà essere girata “in quegli stessi luoghi, con quegli stessi personaggi”. Fino a quel momento, che certo mai capiterà, tutto resterà teso in un’eco senza fine.
Cominciamo però da un’altra didascalia, quella che apre il film. È una citazione di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, mistico napoletano e dottore della Chiesa: «Perciò se vogliamo vedere, che cosa sono li beni di questa terra, miriamoli dal letto della morte; e poi diciamo: Quegli onori, quegli spassi, quelle rendite un giorno finiranno: dunque bisogna attendere a farci santi e ricchi di quei soli beni che verranno con noi, e ci renderanno contenti per tutta l’eternità». Così, nel 1758, ragionava il Santo nell’opera Apparecchio alla morte (Considerazione XIII – Vanità del mondo). Come Solone d’Atene prima di lui, l’ammonimento sulla fugacità dei beni terreni è in fin dei conti una questione di prospettiva. L’Ateniese infatti disse a Creso re dei Lidi che: «di tutte le cose bisogna guardare come andranno a finire, ché molti il dio, dopo aver lasciato loro intravedere la felicità, li ha poi abbattuti fino alle fondamenta». «Miriamoli dal letto della morte», «guardare come andranno a finire»: una questione di prospettiva dicevamo, di sguardo, quindi cinematografica.

Otar l’innamorato, curioso, quasi invisibile, osserva i cinque religiosi che del tutto si disposero «di non volere più essere al mondo ma di darsi al servigio di Dio» come il Filippo Balducci del Decameron. Questi avevano passato le Alpi una decina d’anni prima e ripopolato l’antica abbazia di Sant’Antimo dopo più di un mezzo millennio dall’allontanamento degli ultimi monaci Guglielmiti nel 1461 per decisione di Papa Pio II. Lo immaginiamo, per un attimo, farsi fratello tra i fratelli e seguirli sotto la porticina che conduce al santuario. O ancora ridere sotto i baffi quando, durante il pranzo dei monaci, il più giovane dei cinque manda il vino di traverso. “Quasi” invisibile, appunto, perché più del Brunello è la macchina da presa ragione d’allegrezza. Lo sventurato tossisce, i fratelli ridono a fior di labbra, composti, mentre il più anziano si mantiene serio e ascolta il quinto leggere un passo di Adoration ou désespoir. Con la stessa grazia, Iosseliani segue i nostri durante le loro scappatelle nel mondo. Ecco il primo correre appresso a un’automobile per fare l’autostop. Eccoli insieme per le vie del paese, le mantelle nere come gli scolari di Zero in condotta a spasso con Monsieur Huguet. Uscendo dal paese, invitano un paesano a unirsi alla banda. Il vecchio amico declina l’invito, forse stanco, forse intimidito dalla presenza della troupe poco lontana. Subito dopo sorprendiamo uno dei fratelli seduto al tavolaccio del frantoio, fiasco alla mano, proporre un bicchiere di vino ai compari. Per com’è composto il quadro, quasi t’aspetti che d’un tratto Gesù Cristo irrompa nella sala col dito puntato e Pietro al fianco come già fece con San Matteo. E intanto il rumore del torchio, e un canto di bambina in sottofondo.

Come cerchi nell’acqua, i canti dei monaci, degli agricoltori e dei bambini sopravvivono al succedersi delle inquadrature e riecheggiano altrove, associati ormai ad altre immagini, ad altri sguardi. Ecco allora l’orazione dei frati sovrapposta al vino che scroscia dal barile, poi al vecchio contadino che accompagna il bove nella stalla. «In secula seculorum, amen» risuona insieme al muggito dell’animale che rincasa, insieme al canto del gallo. Ecco ancora tre paesani intorno al tavolo, cavalli e cani, e poi i contadini a riposo dopo la raccolta delle olive. Le donne cantano «Mamma mia mi sento male / Figlia mia cos’avrai tu / se non mi date quel’ ch’è nel oreto / mamma mia non guarisco più» mentre risuona ancora la preghiera tra i campi e l’Apecar se ne va via rombando.
Riguardo la colonna sonora del film, un anno dopo, al festival del cinema mediterraneo di Montpellier del 1989 Iosseliani dirà: «Per il film era necessario unire questi due mondi, far sentire la presenza degli uni mentre si filmavano gli altri: questo era il principio di costruzione del film. Per me, in generale, la colonna sonora permette di allargare il campo visivo, ovvero far sentire quel che c’è attorno.»
E “l’attorno” riecheggia costantemente: nelle scene di lavoro ad esempio, quando Iosseliani inquadra in campo stretto la precisione e l’armonia dei gesti. Non c’è gerarchia tra le opere, che sia fuori o dentro il monastero, e tutte dialogano l’una con l’altra. Così la donna nel mattatoio con la fiamma ossidrica, gli uomini al campo e in cucina, i guanti bianchi del cameriere nella casa dei notabili, il bisturi del frate che restaura il manoscritto, l’ovatta sull’affresco che fa sudare il Redentore.

Come Georges Franju prima di lui, Iosseliani riesce a scorgere la vita anche tra le mura mortifere di un mattatoio. Antony Fiant, professore all’università di Rennes, li mette a confronto nell’opera monografica (Et) le cinéma d’Otar Iosseliani (fut). La scena del mattatoio nel Petit monastère appare, agli occhi dello studioso, come una «version douce» del film Le sang des bêtes che Georges Franju girò nel 1949 negli abattoirs parigini di Vaugirard e di La Villette. Degli undici piani che corrispondono alle fasi di lavorazione del maiale, manca in effetti il primo, quello dell’esecuzione dell’animale. Les bêtes che vedevamo dimenarsi (i vitelli in fila sul tavolo), rassegnarsi forse (il cavallo, impassibile) e infine cadere (fatalmente, tutte) negli abattoirs di Parigi, nel mattatoio toscano già non sono più. È vero: nell’immagine di un paese di Iosseliani non c’è posto per l’attimo della morte; ciò detto, è soprattutto un’affinità sonora che accomuna i due film e fa dimenticare le differenze. Infatti, se a La Villette i macellai cantano La mer di Charles Trenet, a Castelnuovo dell’Abate è a una Quanto sei bella Roma appena accennata che spetta esorcizzare il “sangue delle bestie”.
Così come i due mondi (il monastero e il mondo) risuonano tra loro, anche il mondo esterno, quello apparentemente lontanissimo da Castelnuovo dell’Abate irrompe in rare occasioni nell’immagine di un paese. La fine degli anni ‘80 fa capolino nelle pellicce delle ragazze a spasso per il corso, nelle loro scarpe o nelle acconciature voluminose à la Donna Summer. Proprio lei, al secolo LaDonna Adrian Gaines, che ritroviamo a sorpresa nella casa dell’eremita. In questa sequenza, che Iosseliani monta alla metà del film a mo’ d’entracte, vediamo un uomo, forse un contadino, forse un cacciatore, rientrare in casa e prepararsi per la notte. Se Castelnuovo dell’Abate affacciasse sul Tirreno penseremmo al guardiano di un faro. L’eremita alimenta il fuoco nel camino mentre risuona l’Ave Maria dei monaci. Un gatto si avvicina per salutarlo e la macchina da presa esplora il disordine della stanza. Una fisarmonica a terra, gli avanzi di chissà quale pranzo, bottiglie di liquore. Al suono della preghiera si sostituisce quello di un canto popolare. L’uomo si siede sulla branda e accende la televisione. In un nuovo piano la vediamo in campo lungo, Donna Summer, mentre canta Dinner with Gershwin (1987) di fronte all’eremita e gli elenca i propri desideri: «I want to have dinner with Gershwin / I want to watch Rembrandt sketch / I want to talk theory with Curie / Impossible I guess». Quello, indifferente, osserva Chronos dai capelli lunghi e vestito nero che ondeggia nello schermo. Poco dopo il tempo, il 1988, tuonerà di nuovo, stavolta con la voce di Eros Ramazzotti («Nascerò con te / morirò con te ogni volta») che riecheggia in una stradina del paese, ritagliandosi un intervallo tra due scene di messa.

È un altro il tempo di Iosseliani. Secondo lui, appunto, «il film non deve essere organizzato secondo le leggi della drammaturgia, ovvero dal susseguirsi delle situazioni». Un tempo fuori dal tempo in cui prende forma «l’aura delle cose conosciute ed amate». È il tempo della caccia, delle campane, o della sera del dì festivo con i suoi fuochi, la musica e i balli. Una balera dove suonano due fisarmoniche, un clarinetto, un sax. Difficile dire se ci si trovi nel 1924, nel 1946, o nell’88. Come a sottolineare la sua condizione d’innamorato, Otar si cuce un cameo clandestino. È lì nella balera che lo scopriamo ballare durante la festa, sorpreso dal suo operatore tra le braccia di una paesana, la sigaretta sulla punta delle dita mentre dà le spalle ai catechisti dell’obiettività documentaria.
Pensando a Rossellini, André Bazin scriveva infatti che «Rispettare il reale non significa […] accumulare le apparenze, ma al contrario spogliarle di tutto ciò che non è l’essenziale, pervenire alla totalità nella semplicità.» Come Francesco, il giullare di Dio, e quei suoi fratelli che giravano su loro stessi per conoscere la volontà divina. Li amò Rossellini come Iosseliani amò quel monastero, quelle campagne, quei canti. D’altronde «il cinema è l’arte d’amare», si ricorda nell’editoriale del numero di aprile dei Cahiers du Cinéma, dato alle stampe nello stesso periodo della ridiffusione d’Un petit monastère. Un gesto, quello del regista, uno sguardo, quello dell’innamorato, che ci spinge a «Filmare il reale perché lo amiamo, filmare gli attori perché li amiamo. Filmare gli alberi, il mare, il vento, perché li amiamo. Il cinema è un canto d’amore alla vita.»
Nel contrattempo del Covid19 e delle grigie misure di distanziamento, il tempo d’Un petit monastère en Toscane è questo: un controtempo, «un canto d’amore alla vita».
Un petit monastère en Toscane è disponibile in streaming sul sito della Cinémathèque Française, cliccando su questo link.