Se non sempre, talvolta le lettere giungono a destinazione, e i destinatari fanno la differenza. Louis Wolfson possedeva un’edizione di Du côté de chez Swann di Proust, sulla cui. copertina era stampato l’indirizzo dell’editore, Gallimard. Lì spedì il manoscritto del suo primo libro, Le Schizo et les langues. Wolfson, un ex studente di medicina, aveva abbandonato i corsi per problemi psichiatrici. Venne fatto internare più volte dalla madre per disturbi alimentari e relazionali, era schizofrenico certificato. Nel libro raccontava vicende biografiche e in particolare le metodiche che aveva elaborato per sfuggire alla presa della lingua madre rifiutata, l’inglese, attraverso complicate tecniche di traduzione delle parole ascoltate nelle altre lingue che studiava, russo, tedesco, francese, ebraico, yiddish.
Prima circostanza fortunata nella vita di Louis Wolfson, non l’ultima, come vedremo, il manoscritto giunse nelle mani di Jean-Bertrand Pontalis che lo passò per una valutazione a due lettori d’eccezione, Raymond Queneau e Jean Paulhan.
Se il secondo avanzò riserve per il francese bizzarro, il lavoro strabiliante sulla lingua che sostanzia Le Schizo entusiasmò, come senz’altro prevedibile, Queneau, e il manoscritto cominciò a girare come oggetto di culto tra l’élite intellettuale parigina, stralci vennero pubblicati su Les Temps Modernes di Sartre e finalmente, dopo una laboriosa trafila editoriale (le cui tormentose vicende sono narrate da Pontalis nel Dossier Wolfson, sempre di Gallimard), Le Schizo comparve nel 1970 nella collana Connaissance de l’inconscient curata da Pontalis. L’idea originaria era di chiedere un’introduzione a Roman Jakobson, al suo rifiuto gli subentrò Gilles Deleuze. Wolfson si trovò così ad essere a un tempo uno scrittore acclamato a Parigi e un paziente psichiatrico a New York.
Negli anni successivi scrisse un libro ulteriore, Mia Madre Musicista è Morta di Malattia Maligna tra il Martedì e il Mercoledì della Metà di Maggio del Millenovecentosettantasette nel Moritorio del Memorial a Manhattan. In questa seconda opera, le vicende dell’agonia della madre si intrecciano al racconto della sua nuova passione, il gioco sui cavalli, e delle metodiche singolari attraverso cui selezionava cavalli, scuderie e fantini su cui puntare. Il francese del secondo libro è molto meno personale, conseguentemente più traducibile, venne pubblicato in italiano nel 1984 con un’intervista che riepiloga la vita di Wolfson a quella data. L’edizione italiana di SE è l’unica sottoscritta dall’autore, che aveva tribolato, almeno quanto con Pontalis per il primo libro, con l’editore lacaniano Navarin (molti scritti su Wolfson sono di lacaniani, del resto notoriamente attenti alla lettera e al suo destino).
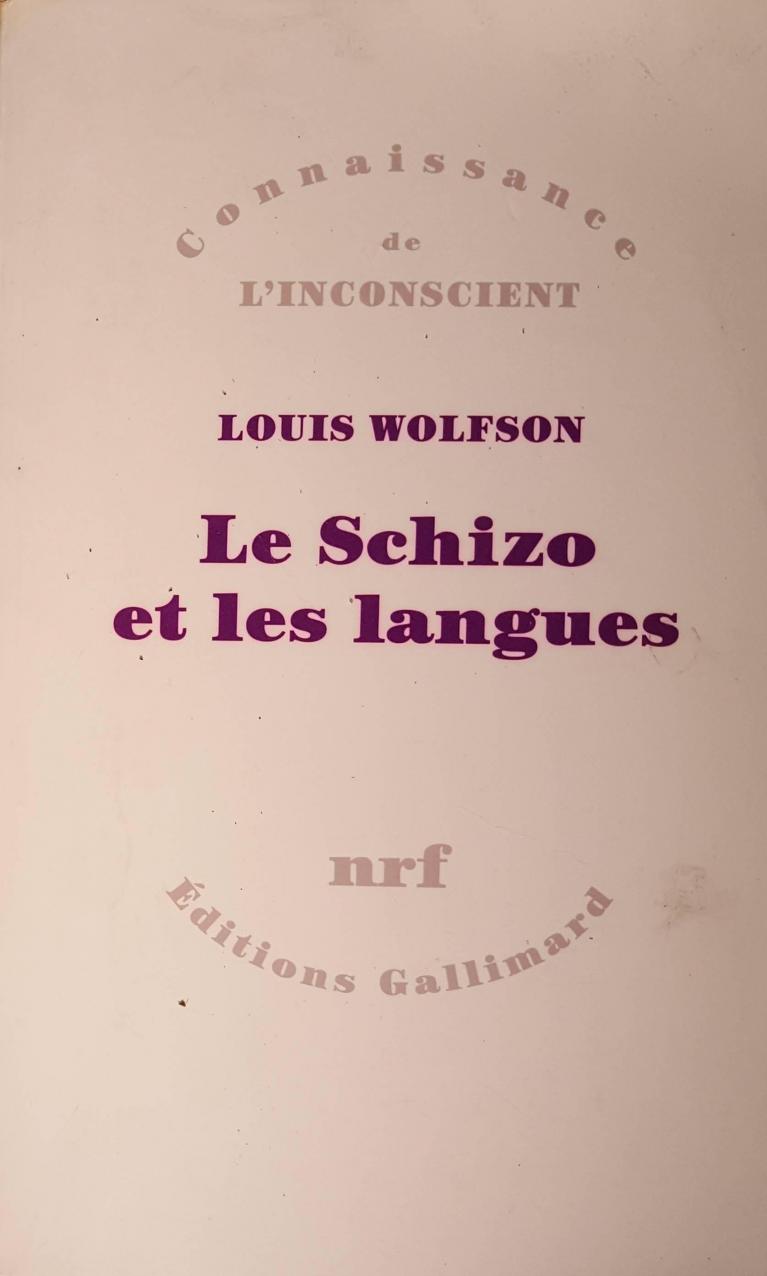
A seguire non si seppe più nulla di Louis Wolfson, e ciò almeno fino al 2010, quando cominciarono a ricomparire tracce, fino alla completa manifestazione con la pubblicazione dell’edizione rivista e aggiornata di Mia Madre… nel 2012 (prontamente riedito in italiano da Einaudi). Venne quindi ricostruita la sua vicenda umana, assolutamente incredibile. Cacciato dal patrigno alla morte della madre, visse del sussidio di invalidità come clochard, la passione per il gioco si spostò dai cavalli alla borsa, e vi perse tantissimo. Visse un anno nell’aeroporto di Chicago quindi si trasferì a Montreal. Quando venne a sapere che a Portorico il più grande radiotelescopio del mondo aveva individuato due pianeti simili alla terra in cui potevano esserci forme di vita, prese l’aereo e andò a vivere a Portorico, senza mai visitare l’osservatorio di Arecibo, prendendo alloggio in un appartamento per turisti prossimo all’aeroporto. Nel 2002 la fortuna gli tornò a sorridere allorché vinse cinque milioni di dollari alla lotteria elettronica di Portorico. In seguito non mutò il suo tenore di vita e investì in modo disastroso quanto guadagnato. Ancora è in lotta con le banche per riavere i soldi loro affidati.
Nel 2014 ho pubblicato con Pietro Barbetta per Manifestolibri Louis Wolfson: Cronache da un pianeta infernale, al progetto aveva partecipato con un suo intervento Duccio Fabbri, regista che lavora a New York e che stava coltivando da anni un documentario su Louis Wolfson, e che lo è andato a trovare più volte a Portorico. Ora il film è prossimo all’uscita in sala, quella che segue è l’intervista di Raphaël Koenig, che avevo conosciuto per un progetto editoriale ulteriore, Dialogues sqizophoniques avec Louis Wolfson, con Duccio.

Quando cinque anni fa avevamo pubblicato le Cronache, l’intento era promuovere la traduzione del primo libro in italiano, speriamo che ciò accada con l’uscita del documentario di Duccio, e che anche chi non ha accesso agli originali possa confrontarsi con l’unicità di Wolfson, e col suo assoluto e strabiliante talento letterario.
Duccio Fabbri: (Non) Filmando Wolfson: Una intervista con Raphael Koenig
Pubblicato in origine in Schreibheft, Zeitschrift für Literatur, Vol. 93, Sett. 2019 (dir. Norbert Wehr), come parte del dossier “Babel New York: Louis Wolfsons Le Schizo et les langues”, a cura di Maximilian Gillessen, Raphael Koenig e Marina Sawall, p.65-69, il dossier raccoglie materiali di assoluto interesse di un ampio spettro di autori, Emily Apter, Paul Auster, Gilles Deleuze, Duccio Fabbri, Michel Foucault, Maximilian Gillessen, Raphael Koenig, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Sylvère Lotringer, Michael Pierssens, Jean-Bertrand Pontalis, Jean Ristat, Marina Sawall, Werner Schmitz e Anton Stuckardt.
Per maggiori informazioni: www.schreibheft.de

Raphael Koenig: Come e in quale contesto hai conosciuto il lavoro di Louis Wolfson?
Duccio Fabbri: Un amico mi ha consigliato il libro. I libri di Wolfson credo si trovino solo in Francia e in Italia dove sono comunque rari.
RK: In che modo questo progetto si coniuga col tuo mestiere di filmmaker?
DF: Questo è il primo film nel quale ho il completo controllo come filmmaker. Sebbene abbia una lunga esperienza nel cinema questo è il mio primo documentario. Ho imparato a distribuire le energie su una lunga durata e dopo un po’ di anni ho iniziato il processo opposto: come risolvere un documentario il cui protagonista voleva renderlo perpetuo.

RK: Cosa ti ha portato a decidere di realizzare un documentario su Louis Wolfson? Cosa ti ha attratto personalmente?
DF: La mia solitudine, l’isolamento a cui porta il non conoscere la lingua e la cultura di un luogo in cui si vive. Dopo aver passato due anni a New York ho realizzato che la lingua è la nostra unica casa e che la mia vita non poteva essere la stessa rispetto a quella che avevo in Italia, ma era troppo tardi per tornare indietro. Leggendo le pagine di Wolfson ho provato ammirazione per colui che si era auto esiliato nella propria città, decidendo di rifiutare completamente la lingua madre. Potevo capire la portata e la severità del gesto ma non comprenderlo veramente. Ci sono voluti dieci anni a fare questo film e il rapporto con il progetto si è evoluto. Inizialmente ero appunto affascinato dall’aspetto letterario intrecciato con quello psicologico: l’uso ossessivo e sempre sperimentale della lingua francese, così come l’intensità e l’ironia delle pagine autobiografiche. Successivamente, quando ho conosciuto Wolfson, al progetto si è aggiunta la dimensione umana. Da una parte è nata un’amicizia, dall’altra ho capito che il film diventava una storia contemporanea e su come lui vive e non solo su come scrive. Aggiungendo questa dimensione sono accadute più cose. Un esempio: le domande a cui Wolfson si ostinava a non rispondere, e procrastinava per mesi, hanno perso importanza e le riflessioni su come rielaborare questi concetti mi hanno aiutato a dare una prospettiva diversa al documentario. Wolfson ha “passivamente” indirizzato l’andamento del film seguendo, a mio parere, esclusivamente il suo istinto.

RK: Come sei riuscito a convincere Louis Wolfson a farsi coinvolgere nel progetto? È risaputa la sua timidezza per la videocamera…
DF: Prima del nostro primo incontro una delle cose che ci ha avvicinato è stato il fatto che sono andato a visitare le case dove lui ha vissuto a New York. Abbiamo avuto modo di raccontarci gli stessi luoghi a sessanta anni di distanza. Il Bronx di Lawrence Ave e la centotrentottesima strada nel Queens. Tuttavia mi sono presto reso conto che dovevo fare molta attenzione ad avanzare qualunque tipo di richiesta, perché l’umore di Louis era soggetto a sbalzi, sul progetto del film poi, i suoi pronunciamenti non parevano particolarmente favorevoli – mi diceva: non è escluso, ma non è confermato. Diceva che ci saremmo anche potuti incontrare, sebbene lo ritenesse superfluo, ma non sapeva quando. A causa di impegni improrogabili avrei dovuto attendere mesi, probabilmente anni. Vista la convinzione assoluta con cui poneva i termini della questione, era difficile controbattere. Io volevo quantomeno capire quali ragioni impedissero un incontro. C’è sempre qualcosa di altro, di importante, che non si può carpire in quel dato momento, nel presente. Quindi ho dovuto decidere se dopo anni di comunicazione epistolare e via email avrei dovuto tentare la fortuna e andare a Porto Rico o continuare una partita a scacchi. Era diventata una partita epistolare in cui ci voleva un mese per avere la mossa dell’avversario ma sfortunatamente il numero dei pezzi sulla scacchiera era praticamente infinito e Louis non mi lasciava perdere, mi teneva cinicamente in vita. Per un bel po’ Louis non rispose alle mie email e telefonate. Dopo quasi tre mesi mi scrisse che aveva sofferto una leggera emorragia celebrale ed era stato ricoverato per tre giorni. Decisi di non aspettare oltre e di andare a Porto Rico, quantomeno per fare delle riprese del radiotelescopio. Avevo intenzione di alloggiare nello stesso quartiere di Louis. Quando ricevetti i dettagli della prenotazione non potevo credere ai miei occhi: l’indirizzo della mia stanza era lo stesso di Louis.

Si tratta di un condominio che affitta appartamenti ai turisti. L’edificio è molto vicino al principale aeroporto di Porto Rico e il frastuono dei motori jet rimbomba di continuo. Arrivai alla mia stanza, la numero 507, e scoprii che il caso ci aveva voluti addirittura vicini di stanza. Louis non sapeva ancora che ero a Porto Rico. La sera gli telefonai spiegandogli che ero arrivato per fare delle riprese al radiotelescopio di Arecibo. Quando gli dissi che eravamo vicini di camera non fece una piega. Prendemmo appuntamento per l’indomani. Ricordo Louis che apre la porta ed emerge dalla penombra, ha i capelli bianchi leggermente ondulati pettinati all’indietro, sopra i suoi occhiali da vista porta degli occhiali neri enormi che coprono gran parte della faccia. Ha la camicia rimboccata fin sopra i gomiti, con una mano mi porge un pezzo di carta a quadretti strappato da un quaderno. Louis mi chiede in francese di firmare il foglio. Lo prendo e lui riaccosta la porta invitandomi a leggere e firmare. Sul foglio c’era scritto qualcosa del genere: Io, Duccio Fabbri, dichiaro che non riprenderò mai Louis Wolfson con alcun mezzo cinematografico o fotografico. Mi pare ci fosse anche menzione di “macchine fotografiche installate in telefoni cellulari”. Louis sa bene che oggi una telecamera può essere ovunque. Capisco subito di non aver alternative, quindi firmo. Rassicurato, Louis apre la porta ed esce sul ballatoio. Così, senza telecamere né microfoni, iniziammo una lunga chiacchierata che ancora ricordo.

RK: Quando hai deciso di andare a Portorico per filmarlo? Come si è evoluta la tua relazione con Wolfson?
DF: Quando arrivai a Porto Rico la prima volta ci conoscevamo ormai bene. Le nostre lettere ci avevano fatto conoscere piuttosto bene ed eravamo in ottimi termini. Tuttavia non si è nemmeno parlato di fare delle riprese per molto tempo. Il primo compromesso fu quello di riprenderlo esclusivamente attraverso immagini riflesse. Specchi, ma soprattutto nelle finestre degli autobus (il mezzo di trasporto prediletto da Louis), oppure mentre camminava, lo riprendevo riflesso sui vetri delle macchine parcheggiate. Nei primi due viaggi a Porto Rico non sono riuscito a riprendere più di tre minuti di Louis Wolfson. Inoltre i tre minuti più che un linguaggio erano un singhiozzo. Sempre tutto mosso, con un suono pessimo e di fatto una figura semi-invisibile. Ho seriamente pensato che le cose sarebbero andate per il peggio se non fosse stato per il mio rapporto con Louis che nel frattempo era diventata un’amicizia. C’era una condivisione delle cose per lui e per me quotidiane che era toccante. Di fatto, si tratta di questioni ben difficili da raccontare. Soprattutto perché non ero intenzionato a fare un film sul mio incontro con Louis, ma soprattutto su di lui mantenendo il mio ruolo come propedeutico al racconto. Ho tuttavia nel processo accettato di narrare il film perché mi pareva il modo migliore e sincero di raccontare la storia di Wolfson.
RK: Puoi parlarci un po’ del processo di lavorare-filmare con Louis Wolfson? Come interagivi con lui durante le riprese? Hai elaborato qualche metodica specifica?
DF: Una delle frasi ricorrenti, diventata un mantra duranti gli anni di riprese era: “non è garantito”. Quindi mai nessun appuntamento è stato fissato per il giorno successivo con certezza. Tutto è sempre rimasto nell’immediato. La questione della comunicazione inoltre non è da trascurare. Louis si ostina a non parlare inglese, il mio francese è a dir poco elementare e il mio spagnolo una sorta di italiano adattato.
Sono arrivato addirittura ad aspettare per due settimane che mi desse udienza perché avevo portato con me un direttore della fotografia per cercare di dare uniformità, o quantomeno visibilità alle immagini. Siamo poi riusciti a riprenderlo ma non ha accettato di uscire con noi.
RK: Il tuo documentario è ormai in postproduzione, ho sentito dire che è stato un processo decisamente lungo e complicato…
DF: La post produzione di Sqizo, non più di altri documentari, comporta un lavoro di sintesi superlativa. Bisogna elevarsi a decine di metri da terra, trovare un filo tra campi, vigneti, foreste, aeroporti, le strade di San Juan e, senza perdere l’equilibrio, vedere la possibile trama. La storia di Wolfson ha tante ramificazioni e la tentazione di prendere tante strade diverse è sempre stata alla porta. Ho cercato di essere coerente con il mio istinto iniziale e mi sono accompagnato nel volo con due collaboratori fondamentali: Dejana Pupovac che ha scritto la narrazione insieme a me e Jacopo Quadri il “montatore saggio come un contadino”. Senza queste “ali” mi sarei potuto trovare con il mio filo impigliato in un sentiero infestato di rovi.

RK: Quali sfide o ostacoli hai dovuto affrontare in quanto realizzatore? Come è stato “tradurre” o trascrivere lo stile molto particolare e polimorfo di Wolfson in immagini cinematiche?
DF: Abbiamo pensato a sperimentare con le immagini per tradurre i vari passaggi linguistici di Wolfson. I passaggi linguistici e la polifonia a cui fai riferimento sono raccontati e anche visivamente spiegati con grafiche su immagini ma non abbiamo indugiato troppo su questo punto. Sarebbe risultata una riduzione didattica del libro. Oppure in passaggi di fatto inintelligibili per il pubblico. Il film ha un equilibrio che è basato sull’uomo Wolfson, che appare nella nostra realtà ma appartiene al mondo delle parole.
RK: Credo tu abbia letto molto del materiale pubblicato sul lavoro di Wolfson. Quali testi hai trovato particolarmente stimolanti, in quanto filmmaker?
DF: Ogni scritto è servito e mi ha dato qualcosa di importante, ma direi i testi di Sylvère Lotringer che sono stati poi redatti e pubblicati in Semiotexte. Lui è stato un riferimento unico e importante. Ho girato un’intervista a Sylvère che nella sua interezza è meravigliosa. Lenz (non direttamente legato a Wolfson) mi ha aiutato a connettere vari punti. A leggere in parole ciò che potevano essere sensazioni. Un libro che a te pare scontato probabilmente, ma la sua traduzione in inglese di Richard Sieburth mi ha aiutato immensamente. Richard è stato il nostro compagno di avventura, è stato il nostro faro durante tutta la durata del film e ha rilasciato un’intervista molto importante per il film.
RK: Che tipo di pubblico ti aspetti per il film? Come speri/pensi che reagirà lo spettatore al documentario? A tuo parere, quali aspetti del lavoro di Wolfson possano risuonare maggiormente nel pubblico? Detto altrimenti, in che modi Wolfson è rilevante per il ventunesimo secolo?
DF: Mi sono sforzato di rendere questa storia per tutti. Ho cercato di raccontare in modo reale la vita di Wolfson come esempio di vita-arte, e penso che questo sia un concetto universale e contemporaneo. Il fatto che Wolfson abbia partecipato (e stia partecipando al film) ha reso questo stesso progetto parte della sua opera.

